BANALITÀ DELL’ALTRO
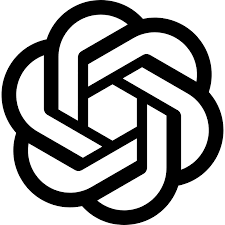 DOMENICO SCARAMUZZI
DOMENICO SCARAMUZZI
1. Un po’ di tempo fa, alla domanda ‘chi è l’altro?’, l’assistente vocale riferiva ciò che riusciva a reperire nel web e, per vie a noi sconosciute, a metabolizzare. Non diversamente si comporta la più giovane Chatgpt4 quando ci fa sapere che l’altro è uno che è come me, ma che non è me; ad un tempo, come me e diverso da me. In poche parole, tanto Siri quanto Chatgpt4 danno risposte che si mantengono, senza strappi significativi, nel raggio lessicale e semantico del ‘simile’, del ‘prossimo’ o di termini inclini – almeno a parole o nelle intenzioni – a smussare dissomiglianze e ad accorciare distanze. Nei fatti, però, la distanza dell’altro e dall’altro non sempre – anzi, mai – consente i facili scambi e le vagheggiate simmetrie.
L’alterità non è tema o questione di retorica; è, piuttosto, un’avventura: l’irreversibile incedere lungo percorsi senza ritorno, uscita senza rientri, viaggio senza rimpatrio; la costante, continua e puntuale capitolazione di presunte affinità o sperate familiarità. La prossimità dell’altro è refrattaria a catture di ogni tipo: incontrarlo è già trovarsi interrogati, interpellati, chiamati in causa e persino non riconosciuti. La prossimità, la buona prossimità, non abolisce le distanze, ma batte «sentieri costretti in un palmo di mano // segreti che fanno paura // finché un uomo ti incontra e non si riconosce» (Khorakhané).
Se, poi, il punto di tangenza con l’altro si fa punto di fuga o, meglio, deviazione in direzione dell’infinito, allora non c’è proprio alcuna possibilità di reclamare o richiamarsi a presunti postulati di reciprocità. L’io in relazione con l’infinito è collocato nell’incapacità di arrestare il suo cammino in avanti, nell’impossibilità di disertare il proprio posto: non ha né il tempo né il potere di ‘far ritorno’ a sé o in sé.
2. In realtà, rispetto ad altri non siamo mai ‘difronte’, ma sempre e soltanto ‘sotto’ o, come dicono gli inglesi, ‘sotto schiaffo’: assoggettati. Ha scritto E. Lévinas che l’altro non è un ‘tu’ – alla maniera di M. Buber – bensì un ‘voi’ o un ‘lei’ che mi si rivela nella sua ‘signoria’.
Purtroppo, la semantica dell’affinità e dell’armonia ha ancora la meglio su una semantica della distanza e della differenza. E anche là dove si fanno discorsi su quest’ultima, si ritorna o ci si ritrova ineluttabilmente nella prima, spesso sboccando molto più in là, in una sorta di semantica della ‘comunione’. Si pensi, ad esempio, alle più ordinarie pratiche di dialogo, là dove – a quanto pare – oltre a non tener conto della differenza tra l’accordarsi sul vero e l’accordarsi veramente, ci si abbandona all’idea di un dialogo in quanto pratica di reciprocità, possibile sulla base di un ‘vero’ o di un ‘giusto’ che sarebbero già dati, in maniera chiara, distinta e sostanziale e soprattutto previamente ai partner. In tal modo, si istituiscono negoziazioni, conversazioni, economie, mercati e persino tregue dimenticando – ahimè, troppo facilmente – che l’appello non è mai secondo o successivo rispetto al dialogo. In realtà, l’io non parla se non rispondendo; nessun io dice o si afferma come tale a partire da sé, ma risponde sempre di, a e davanti ad un altro.
3. Ecco, allora, il sospetto: e se la reciprocità – ad un tempo, madre e figlia della comunione, della comunicazione, dell’amore, dell’amicizia, della giustizia e di tante altre cose di questo genere – nascondesse in sé loschi meccanismi di riproduzione del potere? L’altezza di certi discorsi non dovrebbe, senza vergogna, fare continuamente i conti con la chiacchiera dei bassifondi?
Con ciò non si vuole tessere uno sperticato elogio dell’irrelazione né imbastire discorsi iperbolici, ma, semplicemente, tenere lo sguardo fisso alla realtà e i piedi per terra. In una dialogo, i partner non sono mai ‘eguali’: non possono esserlo da nessun punto di vista. Non vi è pratica comunicativa che possa presupporre, se non illusoriamente, la tanto affermata uguaglianza o parità degli interlocutori. ‘Comprendere l’altro’ – espressione frequentemente usata nel senso di ‘mettersi al posto dell’altro’ – allude davvero a comprendere l’altro in quanto altro? Comprendere l’altro non è, piuttosto, sperimentare l’impossibilità di mettersi al ‘suo’ posto? Anzi, anche qualora e là dove fosse possibile, dove mai dovrei o potrei mettere l’altro se non nel posto (il mio, il proprio) che, nel frattempo, io stesso ho lasciato libero per trasferirmi?
Insomma, come in un inutile gioco di scambi reciproci, tutto ritorna ineluttabilmente al medesimo!
4. L’amore dei nemici – si diceva. Di certo, i nemici è meglio non averli che doverli amare. Tuttavia, nell’impossibilità di rapporti e amicizie pienamente trasparenti e senza frizioni, non è facile entrare nel merito di questa evangelica espressione.
Di fatto e non a caso, anche nelle punte più avanzate della teologia contemporanea si riscontra, in fatto di reciprocità, un dato assai significativo: la maggior parte dei teologi che hanno preso in considerazione il pensiero di Lévinas si sono riferiti per lo più a Totalità e Infinito piuttosto che ad Altrimenti che essere, vale a dire si sono mantenuti al di qua o a distanza dalla radicale non reciprocità dell’uno-per-l’altro. Di conseguenza, la ricezione di temi quali il volto, l’alleanza, la responsabilità, l’epifania, la dimora, la promessa, la sostituzione, l’assegnazione, l’espiazione, ecc. è, tutto sommato, rimasta addomesticata, temperata o, meglio, metafisicamente centrata. L’altro vi compare ancora come uno dei termini speculari della relazione; l’alterità è ancora decisa dall’identità e in base all’identità; l’altro è ancora disegnato a partire da me.
Allora, come per l’altro, resto impantanato nel chiedermi ‘chi è il nemico?’. E ciò perché, secondo una logica di reciprocità, non si capisce molto bene – o, per lo meno, non è del tutto scontata – la ragione per cui ‘nemico’ si debba dire dell’altro e non dell’io.
Vi è ancora molto da fare valere contro la banalità dell’altro.
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA Domenico Scaramuzzi ENDOXA SETTEMBRE 2024 POLITICHE DELL'AMICIZIA/INIMICIZIA

