IL NUOVO VOLTO DELLA CONTRADDIZIONE SOCIALE NELL’ITALIA DEL BENESSERE: PASOLINI E IL POTERE DEL CONFORMISMO
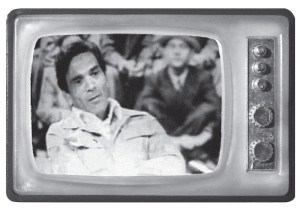 FABIO CIARAMELLI
FABIO CIARAMELLI
“….Ma io, con il cuore cosciente
di chi soltanto nella storia ha vita,
potrò mai più con pura passione operare,
se so che la nostra storia è finita?”
Questi versi, che concludono Le ceneri di Gramsci (1954), attestano la consapevolezza fondamentale di una vera e propria cesura storica. Pier Paolo Pasolini (1922-1975) capì già negli anni Cinquanta, cioè proprio all’inizio del cosiddetto boom economico, che ormai aveva fatto il suo tempo il marxismo economicistico, fondato sulla contraddizione tra lo sviluppo delle forze produttive e il mantenimento dei rapporti di produzione. La “nostra storia”, cioè quella vissuta e soprattutto tematizzata dalla vulgata marxista, cioè dal cosiddetto materialismo storico, alla luce del primato della contraddizione economica tra forze produttive e rapporti di produzione, già allora poteva dirsi “finita”, dal momento che era evidentemente fallita la sua prospettiva progressista.
Ma in che consiste il progresso? Nella visione marxiana classica, basata sulla concezione dialettica della contraddizione economica, or ora rapidamente richiamata (esposta, oltre che nel Manifesto del Partito Comunista del 1848, soprattutto nella famosa, e un tempo citatissima, Introduzione del 1857 a Per la critica dell’economia politica), alla contraddizione economica spetta il compito di spiegare il senso progressivo del processo storico, riconducendolo alla sua origine. In quest’ottica, lo sviluppo e la crisi d’un modo di produzione costituiscono la premessa d’un nuovo modo di produzione, che, destinato a nascere dalle ceneri del precedente, risulterà necessariamente più avanzato di quest’ultimo.
Ebbene, è precisamente questo progressismo, al tempo stesso deterministico ed economicistico, che Pasolini metteva radicalmente in discussione. E lo faceva proprio attraverso l’attenta osservazione del mondo a lui contemporaneo e delle trasformazioni del “modo di produzione” della ricchezza in esso prevalente. Gli appassionati “interventi civili” dei suoi ultimi due anni di vita (I grandi interventi civili è appunto il titolo che la Garzanti ha scelto per ripubblicare insieme nel 2021 gli Scritti corsari del 1975 e le Lettere luterane, uscite postume da Einaudi nel 1976) nascono esattamente dall’attenta osservazione del suo tempo, cominciata già negli anni Cinquanta.
L’innegabile sviluppo economico di quegli anni, con la sempre maggiore diffusione dei consumi individuali o privati, entrava fin dall’inizio in rotta di collisione con l’esigenza sempre più diffusa di servizi e consumi sociali. Senza la creazione di questi ultimi, non sarebbe stato possibile un vero e proprio progresso civile. In realtà, tuttavia, il boom dell’economia, cioè l’incremento della produzione di merci, faceva crescere i consumi privati, senza però che ciò comportasse alcuna riduzione dei costi sociali provocati dall’espansione dei beni di consumo, e soprattutto senza che a questo processo si accompagnasse un miglioramento complessivo delle condizioni di vita delle masse. La crescita o lo sviluppo economico non s’era affatto tradotta in autentico progresso. In conseguenza di ciò, era evidente che il nuovo modo di produzione che stava nascendo, contrariamente alle promesse “progressiste”, non fosse in alcun modo più “avanzato” del precedente.
Scriveva Pasolini: “Attualmente, il neocapitalismo sembra seguire la via che coincide con le aspirazioni delle ‘masse’”. In tal modo, anziché contrastare o reprimere l’aspirazione diffusa all’appagamento immediato dei desideri, il “neocapitalismo” assecondava e attivamente promuoveva la crescita dei consumi, percepita dalle ‘masse’ come forma prevalente se non esclusiva di autorealizzazione, ma in realtà perseguita dal sistema economico come indispensabile premessa per la massimizzazione dei profitti.
In un simile squilibrio tra promesse e realizzazioni trova la sua origine la polemica di Pasolini sullo sviluppo ridotto a sola crescita economica della produzione e dei consumi privati, e quindi incapace di trasformarsi in fattore di progresso civile. Va aggiunto che un simile squilibrio non era soltanto l’effetto d’un processo economico, dal momento che alla base delle dinamiche economiche Pasolini riconosceva il ruolo centrale delle relazioni di potere e perciò chiamava in causa la politica e il governo. Da qui la sua denuncia del “vuoto del potere in Italia” (nel celebre articolo sulla scomparsa delle lucciole negli Scritti corsari) e l’esigenza reiterata del Processo (nelle Lettere luterane).
A cinquant’anni di distanza da quelle polemiche, ciò che resta di Pasolini è, a mio avviso, la sua lucidità culturale e politica, che gli consentiva di cogliere con precisione il nuovo volto della contraddizione sociale nel secondo Novecento. Nella società italiana dei primi anni Settanta era giunto ormai a maturazione un processo, già da lui poeticamente intravisto negli anni Cinquanta, di profonda trasformazione sociale e culturale. Quella che in un poemetto del 1954 egli aveva dantescamente chiamato “l’umile Italia” stava già morendo. Ma ciò che ne prendeva il posto nel corso degli anni Sessanta, cioè quando, in modo “fulmineo e folgorante” ebbe luogo la “scomparsa delle lucciole” (definizione poetico-letteraria del passaggio al “neocapitalismo”), smentiva radicalmente i postulati e le categorie del progressismo marxista valido per le società “paleocapitalistiche”.
La specificità del caso italiano emerge dall’analisi del modo di produzione invalso negli anni del boom economico, dal momento che un modo di produzione non si limita mai a produrre unicamente oggetti, cose o merci. Prima di produrre merce, un nuovo modo di produzione produce nuovi rapporti sociali, una nuova umanità, una nuova cultura, modificando antropologicamente gli italiani: da qui la ricorrente polemica pasoliniana sul “genocidio” culturale, cioè sulla distruzione delle “culture particolari e concrete che costituivano l’Italia arcaicamente agricola e paleoindustriale” e delle stesse sopravvivenze di queste culture contadine nel sottoproletariato urbano, sistematicamente sottoposto ad omologazione coatta dal nuovo modo di produzione basato sul potere dei consumi.
Perché è così importante questa precisazione sugli italiani? Perché la “mutazione antropologica” analizzata da Pasolini riguardava essenzialmente l’Italia? In realtà, il nuovo modo di produzione, cioè il consumismo, che inondava il mercato di beni superflui e diffondeva edonismo, prendeva corpo in un Paese che, a differenza degli altri Paesi europei, non aveva conosciuto davvero la (prima) rivoluzione industriale e i risvolti politico-culturali di quest’ultima. Infatti, dove la prima rivoluzione industriale aveva avuto luogo, essa era stata accompagnata dalla rivoluzione liberale e quindi dalla nascita d’una borghesia produttiva e laica. In Italia, invece, una vera borghesia produttiva non era mai nata e il predominio della Chiesa cattolica non era mai stato interrotto.
Quando, dalle nostre parti, si diffuse la seconda rivoluzione industriale, cioè la nascita del modo di produzione consumistico e la prospettiva dell’opulenza, quest’evento non poteva che avere effetti deleteri. Infatti, il nuovo potere dei consumi e dell’aspirazione al benessere generalizzava e diffondeva il desiderio di beni superflui, che però non erano in grado di sostituire i beni necessari (cioè i servizi sociali e i beni pubblici) di cui il nostro Paese pativa (e patisce) l’atavica carenza.
I consumi privati e individuali sono quelli reclamizzati dalla televisione, che, nata proprio nella seconda metà degli anni Cinquanta, ebbe il compito di diffonderli, farli amare, esaltarli e moltiplicarli. Pasolini fu uno dei pochissimi a comprendere e sottolineare il ruolo in quest’ottica fondamentale della pubblicità televisiva, allora riconducibile fondamentalmente a Carosello. Ruolo che mirava (e riusciva) a produrre nella pancia degli italiani l’assuefazione al nuovo contesto consumistico. (Si tenga presente, a riprova della non comune lungimiranza di Pasolini, che le sue riflessioni precedono l’avvento delle televisioni commerciali e poi del berlusconismo).
Prima di concludere, va aggiunta un’ultima osservazione. La denuncia pasoliniana del progresso come falso progresso non ha nulla della nostalgia passatista o del moralismo pauperistico. La diffusione del consumo di beni privati e superflui non è un problema in sé: però lo diventa quando pretende di surrogare l’assenza di beni necessari (case, scuole, ospedali e tutti gli altri servizi pubblici, che nei Paesi di serie A, come Pasolini chiamava quelli in cui aveva avuto luogo la prima rivoluzione industriale, erano stati realizzati prima della diffusione del consumismo). In conseguenza di ciò, l’inganno del nuovo potere era quello d’aver fatto arrivare il nostro Paese del tutto impreparato all’appuntamento con la seconda rivoluzione industriale. Attraverso quest’ultima, l’Italia ancora povera e clerico-fascista diventava, “sia pur micragnosamente, opulenta e, sia pur stolidamente, laica”. E la classe dirigente che aveva gestito improvvidamente questa trasformazione, per non assumersene la responsabilità, finiva col nascondere la stessa portata storico-culturale del fenomeno.
Archiviata ormai la crisi del marxismo economicistico, ci è diventato impossibile sentirci orfani della storia basata sul primato della contraddizione economica, richiamata nei versi pasoliniani citati in apertura; e tuttavia, anche per noi, resta più che irrisolta la contraddizione culturale e valoriale che di quella contraddizione ha preso il posto. Mi riferisco, cioè, al contrasto insanabile tra l’aspirazione all’incremento dei consumi e la massimizzazione dei profitti. Quest’ultima, nella logica economica che continua ad essere imperante, finisce con lo smentire e col rendere irrealizzabile precisamente quell’aspirazione diffusa e inarrestabile, in cui le “masse” continuano a vedere l’unica possibile “promessa di felicità”.

