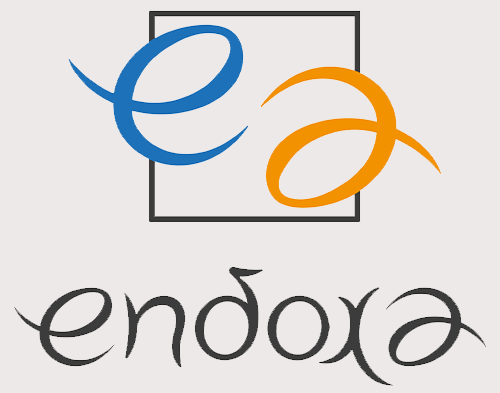DER WANDERER: KAFKA O DEL PASSANTE
 FABRIZIO SCIACCA
FABRIZIO SCIACCA
“Noch nicht geboren und schon gezwungen zu sein, auf den Gassen herumzugehn und mit Menschen zu sprechen” (“Non essere ancora nati e già costretti a girare per le strade e a parlare con la gente”) (F. Kafka, Tagebücher)
1. Non c’è interazione vitale nei personaggi di Kafka, umani o non umani che siano. Ogni cosa avviene con distacco, come parte di una trama nascosta, ma certa, che dipana il filo attorno al quale gli eventi si svolgono. I racconti di Kafka sono spesso popolati da animali. Sono davvero animali? Parlano, ascoltano, ragionano, si muovono come se fossero creature umane. Per converso, si ha l’impressione che tutti i personaggi umani abbiano qualcosa di non umano. In Der Geier (1920), l’avvoltoio osserva il colloquio tra la sua vittima, alla quale sta straziando i piedi incessantemente, e un tale che passava di lì [Es kam ein Herr vorüber] e sta osservando la scena. In altre dimensioni narrative avremmo avuto descrizioni orribili di questa scena. Kafka è unico in questo: non descrive, esprime. È un Ich-Erzähler. È lì dentro, in prima persona, parla e non può far nulla rispetto alla necessità che gli si para davanti. “C’era un avvoltoio che menava colpi di becco contro i miei piedi [Es war ein Geier, der hackte in meine Füße]”.
In fondo, non ha molto senso che il passante gli chieda come mai se ne stia lì a tollerare quella tortura. “Io sono inerme [ich bin ja wehrlos]”, risponde. Letteralmente, senza difesa. C’è un calcolo razionale in chi parla. Chi parla ha davanti un animale molto forte [ein solches Tier hat größe Kräfte] e preferisce subire la tortura dei piedi, piuttosto che il rischio di un attacco in zone più vitali, come il viso. Non può far nulla, dice al passante, se non aspettare.
Il sacrificio dei piedi ha una speranza catartica [da opferte ich lieber die Füße], mira alla rottura di uno schema di violenza. L’animale potrebbe forse saziarsi, e magari andarsene. Il passante a questo punto si offre alla collaborazione. Dice di andare a casa a prendere un fucile. Solo mezzora e sarà di ritorno.
Invano. La necessità non perdona, ha la sua ragione d’imporsi sull’errore. Il colloquio ha uno spettatore attento. Si svolge alla presenza di un animale che guarda ora l’uno ora l’altro mentre parlano. È un animale che ascolta e comprende la lingua degli umani. “Ora vidi che aveva capito tutto [alles verstanden hatte], si sollevò, piegò la testa all’indietro per prendere slancio e come un lanciere affondò il becco attraverso la mia bocca, dentro di me”.
2. A questo punto, la storia dovrebbe concludersi perché l’io narrante non potrebbe più proseguire. Invece accadono due cose apparentemente prive di logica, che solo in un teatro dell’assurdo potrebbero aver senso. La prima è che la vittima continua a raccontare la sua morte. La seconda è l’affiorar d’un esito inusitato, ma coerente con la struttura a contrappasso del racconto: “Cadendo all’indietro sentii, liberato [befreit], che nel mio sangue straripante, di cui erano piene tutte le cavità, l’avvoltoio affogava irrimediabilmente [unrettbar]”.
Tutto avviene in poco tempo e in tempo reale, si direbbe in presa diretta. Non si salva nessuno? L’io narrante paga con la morte la sua incapacità di reagire. Il suo aguzzino, dopo averlo torturato e infilzato non gli sopravvive, affogando nel sangue della sua vittima.
Su questa parabola, come del resto su ogni altra cosa kafkiana, sono fiorite le più svariate interpretazioni. In queste brevi righe non è mia intenzione discuterle. Mi limito a dire che, come è peraltro intuibile, le interpretazioni riguardano soprattutto la figura dell’animale e quella del narratore. Dell’animale s’è detto. Umano e non umano, come tutti gli animali kafkiani che parlano, ragionano, discutono, fiutano, danzano. Dell’io narrante possiamo dire ben poco, se non che somigli, in modo evidente, a Kafka-figlio dinanzi a Kafka-padre. E potremmo aggiungere che ciò rievoca l’impossibilità del figlio di sottrarsi alla tirannia del padre e di desiderarne la morte, che avviene liberatoria in un duplice senso: simultaneamente, il figlio si libera del padre e di sé stesso. Simbolicamente, è una morte sacrificale. Interrompe un sistema di violenza non placabile in altro modo.
Così come la parte dello scafo che emerge dall’acqua è l’opera morta, il visibile in questo racconto è una dinamica di morte che non lascia scampo. La parte più interessante del racconto è però quella sommersa, sulla quale non cadono gli occhi del lettore. Abilmente Kafka la mette in ombra, così come l’opera viva è la parte dello scafo immersa nell’acqua. Ciò che non viene reso visibile, ciò di cui non sappiamo nulla, è il passante. Chi è costui? Un passante, appunto. È uno che passa di lì e vorrebbe aiutare. Non riesce, perché per farlo non può restare, ma deve uscire di scena. Questo metterà tempo e farà perdere tempo. Troppo, rispetto alla necessità di quanto sta per accadere.
Viene in mente un altro racconto precedente, Die Vorüberlaufenden (1907). L’io narrante questa volta porta su una strada in salita illuminata da una luna piena. Vede un uomo in difficoltà, urlante, inseguito da qualcun altro più indietro, che gli corre incontro. Con un noi avvolgente quanto disturbante, Kafka scrive che “noi non lo afferreremo [wir ihn nicht anpacken], perché magari i due stanno solo giocando, oppure entrambi inseguono un terzo. O forse il primo viene inseguito senza ragione, forse il secondo vuol uccidere e noi diventeremmo correi di un omicidio, forse i due s’ignorano completamente, e ciascuno di loro, sotto la propria responsabilità, se ne corre a letto, forse sono dei sonnambuli, e forse il primo ha delle armi. E infine, non saremo stanchi, dal momento che abbiamo bevuto del vino? Possiamo esser contenti di non vedere più nemmeno il secondo.”
3. Confrontando i due racconti, emerge con chiarezza l’importanza della figura del passante. L’io narrante è, nel secondo racconto, certamente un passante tra passanti. Dal momento che il passante non può che essere percepito come altro-da-sé, Kafka mette in scena un sistema spiazzante di figure speculari del doppio, di passanti moralmente equivalenti. Di fronte a un evento la cui spiegazione più probabile muove nel senso di uno stato di pericolo, il narratore smonta completamente la credibilità di questa ipotesi tirando fuori una serie di congetture a favore dell’idea che molteplici potrebbero essere le spiegazioni di ciò che accade, per cui ogni forma di aiuto è inutile.
La figura del passante si rivela come uno degli enigmi kafkiani più interessanti. Come in Gibs Auf (1922), l’io narrante è in cammino ma, non trovando la strada per la stazione, chiede la via a un passante poco distante, una guardia, che con autorità di dice di rinunciare, girandosi “con grande slancio, come chi vuol esser solo con la propria risata [mit ihrem Lachen]”.
In tutti e tre i racconti, il passante è il simbolo dell’inconsistenza del noi, è colui che non può aiutare e anche colui che non può essere aiutato. Non è però inconsistente la sua presenza. La sua presenza è anzi necessaria. È il testimone dell’impossibile relazionalità umana e dell’umana incapacità di cooperare o di mantenere promesse –– si pensi a figure di passaggio senza nome, come il pittore dal nome d’arte di Titorelli in Der Proceß, le cui profferte di aiuto a K. (“Io da solo l’aiuterò a cavarsela [Ich allein hole Sie heraus]” si dissolvono nel nulla.
Il passante attesta la coerente serenità dell’orizzonte kafkiano di fronte all’assenza: nessuna speranza, nessuna via. Il passante non è capace di alcun atto morale, perché nessuna azione può essere morale in sé. Nessuna morale può imporsi nella torbida infinitezza di un mare di congetture. Si aggiunga che, in tutto questo, manca completamente il registro drammatico. Tutte le dinamiche kafkiane potrebbero persino essere ricondotte a una certa comicità (un genere che Kafka amava), se fosse possibile intendersi su un significato di ‘comico’ non convenzionale. In un mondo in cui tutte le interazioni sono paradossali, gli esiti di queste sono infausti, ma ciò non desta meraviglia. Perché?
4. Il passante non è una figura casuale. I passanti kafkiani non passano mai per caso. Non passano nemmeno di proposito. Passano necessariamente. Il passante condivide l’attimo, il gesto della sorpresa, l’impalpabile levità dell’evento. Tuttavia, è destinato a navigare in un oceano di solitudine, in mezzo a tanti altri passanti senza volto. In Der Bau (1923-24), significativa è l’immagine dei “poveri viandanti senza casa, per le strade di campagna, nelle foreste, nel migliore dei casi rannicchiati in un mucchio di foglie o in un branco di compagni, esposti a ogni intemperia del cielo e della terra”. Solo apparentemente consolatoria è la strategia della difesa, anche qui d’un io narrante, che allestisce una costruzione sotterranea somigliante a una tana ma che non è effettivamente tale, data l’immensa estensione, e che non è nemmeno dimora umana. Forse meta-umana e allo stesso tempo metà-umana, come ogni passante o viandante cui tocca al massimo il destino di comparsa.
5. Rimane infine uno spiraglio d’ipotesi: che il passante sia una creatura di Kafka e al contempo una metafora dello stesso Kafka. Che sia, pertanto, l’impresa impossibile di quel che Kafka avrebbe voluto essere in mundo, umano troppo umano tra umani: un alieno. La sua scrittura esprime il desiderio di fuga dall’insignificante normalità della sua esistenza di individuo borghese del primo Novecento. E questa fuga è sempre segnata da un movimento: “Mi trovo sulla piattaforma di una vettura tranviaria e mi sento profondamente incerto [vollständig unsicher] rispetto alla posizione che occupo in questo mondo, nella città, nella mia famiglia” (Der Fahrgast, 1907). Così come, in Der plötzliche Spaziergang (1913), dopo una giornata i cui movimenti rituali (lavoro, cena, svestizione, chiavistelli alle porte) fanno pensare a tutto tranne che ad altri movimenti, “ci si leva come per un improvviso disagio” e ci si ritrova per strada “coi muscoli che rispondono con particolare scioltezza a questa ormai inaspettata libertà [unerwartete Freiheit] che si è procurata loro”. E tutta la normalità viene lasciata alle spalle, “si perde nel vuoto [ins Wesenslose abschwenkt]”. Ed è lì, proprio lì che “la nostra personalità raggiunge la sua vera immagine [Gestalt], ferma, nera nel contorno, battendosi dietro le gambe”.
La fuga è il rapimento verso un mondo impenetrabile e rassicurante, che la sua scrittura realizza per simboli. I simboli sono legami. Simbolicamente, Kafka lega transiti: dal suo silenzio nel mondo al silenzio del suo mondo. Sofferenza comunque, e forse evitabile, quella di ritrarsi: “Tu puoi ritrarti dalle sofferenze del mondo, sei libero di farlo [das ist Dir freigestellt] e corrisponde alla tua natura, ma forse proprio questo ritrarsi è l’unica sofferenza che potresti evitare” (Die Zürauer Aphorismen, 1917-18). Esattamente: è l’unica sofferenza evitabile, ma anche l’unico atto di libertà possibile. Una sofferenza cui non vuole rinunciare. “Siedo qui – scrive a Max Brod in una lettera del 5.7.1922 – nella comoda posizione dello scrittore, pronto a tutto ciò che è bello, e devo osservare inerte – infatti che altro posso fare se non scrivere – come il mio io reale [mein wirkliches Ich], questo povero, inerme [wehrlos](l’esistenza dello scrittore è un argomento contro l’anima, poiché l’anima ha abbandonato l’io reale, però è diventata solo scrittore, non si è spinta oltre; è possibile che la separazione dell’io possa indebolire l’anima così tanto?) […], sia pizzicato dal diavolo [zum Teufel gezwickt], bastonato e quasi triturato”.
La sua scrittura non è realizzata per il successo, per il potere, per la gloria. È un esercizio di trascendenza, la cui dimensione autenticamente religiosa non ha nulla a che vedere con la questione, tutt’altro che definita, dell’ateismo kafkiano.
Kafka ha letto per far divertire, ha incantato senza far capire. Chi ha preteso di capire Kafka si è allontanato da Kafka, perché non c’è una sola spiegazione, ma migliaia di spiegazioni che si annullano a vicenda. Se nulla è spiegabile, non c’è nulla da piangere in nessuna pagina kafkiana. Nella scrittura, Kafka è quel passante, quel viandante, quel passeggero che non può fermarsi. Ogni pensiero è buttato giù dalle scale, ma il passo s’infrange sui gradini e cancella ogni traccia.
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA Endoxa Maggio 2024 Fabrizio Sciacca Kafkiana