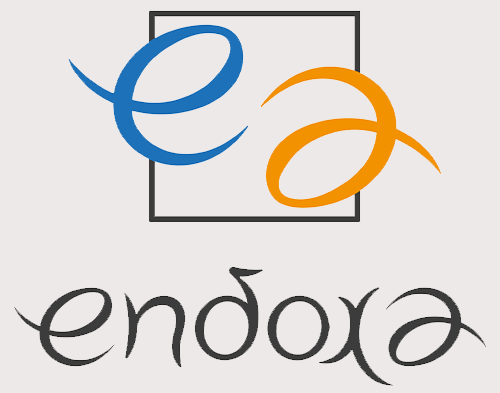“TROPPO SPESSO GLI UOMINI SI INGANNANO FRA DI LORO CON LA LIBERTÀ”:UNA LETTURA DI UNA RELAZIONE PER UN’ACCADEMIA DI KAFKA
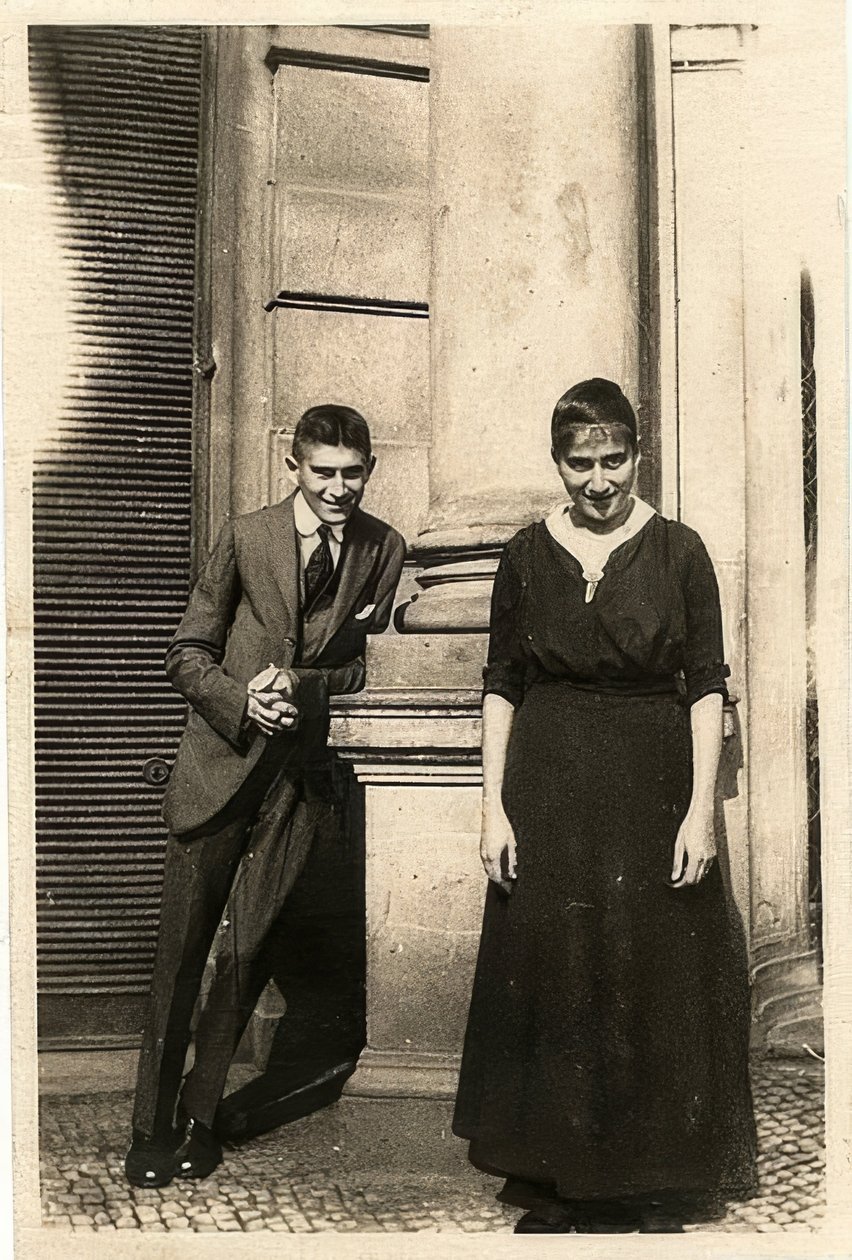 FRANCESCO SCOLLO
FRANCESCO SCOLLO
Il racconto Una relazione per un’Accademia risulta particolarmente interessante all’interno della produzione kafkiana per la sua capacità di condensare in poche pagine alcuni dei temi centrali nella riflessione dell’autore boemo. Tra questi, l’animalità è senza dubbio il più immediato da rilevare. Il racconto, infatti, traccia le linee del processo inverso a quello descritto nel ben più noto La metamorfosi: se in quest’ultimo Gregor si sveglia da un sonno agitato scoprendosi insetto, nel racconto qui preso in esame Pietro il Rosso è chiamato a esporre a un pubblico di accademici il prodigio che da scimmia l’ha mutato in uomo. In questa relazione, come già detto, emergono in filigrana alcune delle dimensioni che spesso caratterizzano le opere di Kafka. Si tratta delle difficoltà incontrate, tanto nella prosa quanto nella vita dell’autore, nelle interazioni con una comunità o nel raggiungere una libertà che spesso collima con la salvezza. Tuttavia, data anche la peculiare natura dell’io narrante, nell’analisi di questi altri aspetti del racconto non si può prescindere dalle modalità con cui Kafka intende il mondo ferino, soprattutto nei suoi rapporti con quello umano. Di fronte alla panoplia di figure animali squadernata nelle pagine di Kafka, si possono assumere differenti posture interpretative. Quella che in questa sede si predilige si riallaccia a quanto delineato da Camus, che nell’appendice a Il mito di Sisifo indica come dimensione più propria dell’opera kafkiana l’assurdità. Quest’ultima, costitutivamente, sfugge agli sforzi di razionalizzazione, e va quindi considerata nella sua autonomia. È facile capire come queste considerazioni possano determinare una certa ermeneutica delle figure animali. In esse, insomma, non bisogna individuare una sublimazione di determinate caratteristiche dell’essere umano, ad esempio dei suoi istinti più bassi, o di determinati esseri umani, magari i più subalterni. Tale interpretazione consiste nella riduzione a ragione di un enigma che altrimenti rimane forse irrisolvibile. Una simile impostazione, peraltro, si rinviene nel primo maestro di Pietro il Rosso. Questi, infatti, per sciogliere il muto mistero della scimmia, tenta di rendere l’animale metafora, di avvicinarlo il più possibile alle sembianze e ai gesti umani, di ricondurlo e ridurlo all’umanità. In questa sede, foss’anche solamente per guadagnare una distanza critica sul maestro del racconto, si preferisce privilegiare un metodo d’indagine più fedele all’intuizione di Camus. Ciò però non deve ostacolare il corso delle riflessioni sull’umano che spontaneamente sorgono dalla lettura di tali vicende animali. Difatti, il tratto peculiare del discorso kafkiano sull’animale consiste probabilmente nel gettare una nuova luce sulla condizione umana. Questo non implica uno scivolamento in una lettura metaforologica: l’animale è, e resta, animale; tuttavia le sue vicende permettono di guardare all’umanità in altro modo. Se, infatti, come Benjamin afferma in Franz Kafka. Nel decennale della morte, ci sono storie animali di Kafka che “si possono leggere per un buon tratto […] senza avvertire che non si tratta di uomini”, in Una relazione per un’Accademia ciò non potrebbe accadere, in quanto la natura, seppur ambigua, del protagonista è dichiarata sin dall’inizio. Eppure ciò accade comunque, e la fulminante intuizione di Benjamin risulta comunque valida: voltando le pagine del racconto ci si scopre intenti a chiedersi quale sia la vera natura di Pietro il Rosso. Su questo spaesamento si innesta la riflessione sull’umano.
Si guardi, pertanto, alle parole con cui Pietro il Rosso presenta il mutamento della sua natura. Già dalla prima pagina, l’io narrante allude a quanto, in questo trapasso, viene perduto: “io, scimmia libera, mi sottoposi a questo giogo”. Se, come qui comincia a intravedersi, nel processo di mutamento ne va della libertà, bisogna dunque prestare attenzione a come questo viene descritto. Stretto tra le sbarre della gabbia e la cassa, ricorda Pietro, “smisi di essere una scimmia. Un ragionamento chiaro e bello, che devo in qualche modo aver tirato fuori con la pancia, perché le scimmie pensano con la pancia”. In questo brano emerge un chiaro cortocircuito fra ominazione e dismissione della natura scimmiesca: l’atto con cui Pietro smette di essere scimmia è compiuto in maniera totalmente animale. Ma come può un pensiero così genuinamente razionale scaturire dal ventre di una scimmia?
Il pensiero a cui qui il protagonista fa riferimento riguarda la necessità di trovare una via di fuga. È proprio nel modo in cui questo viene formulato che si può individuare una prima cesura rispetto alla precedente vita animale. Il protagonista infatti, già dai primi momenti nella gabbia di Hagenbeck, si comporta da essere umano: cerca cioè una via di fuga, fa calcoli per la sua sopravvivenza e accantona l’idea animale di una fuga totale che, nonostante porti dritto alla morte, è per sua stessa ammissione possibile. Così dicendo, Kafka qui implica che se Pietro fosse rimasto fedele alla sua natura di scimmia, non avrebbe mai cominciato a pensare a una via di fuga: avrebbe anzi tentato la disperata via del suicidio libero e incosciente. Non è quindi la condizione di costrizione e l’assenza di facili vie di fuga a far sorgere in lui una forma di pensiero umano e razionale, ma l’opposto. È proprio perché non è più un animale che egli accantona la via di fuga più facile e naturale, l’unica che preservi la sua libertà: la morte. Pertanto, nel momento in cui osserviamo Pietro in gabbia, è già in corso la sua dipartita dal regno animale.
Ciononostante, l’io narrante riporta altri episodi rilevanti della trasformazione che lo ha riguardato, alimentando così, forse volutamente, l’aura di ambiguità che la circonda. Questo dato fornisce un dettaglio rilevante: c’è, nella relazione di Pietro, la tendenza alla ricerca di un momento puntuale che sancisca il suo passaggio da una natura all’altra. Questa tendenza emerge in maniera esemplare al fondo della prima pagina, dove il relatore espone all’accademia la sua evoluzione ricorrendo all’immagine di quella che, perlomeno nel momento in cui egli la attraversa, ha le dimensioni di una porta. L’allontanamento da questa, tuttavia, ha fatto sì che le sue dimensioni siano mutate in quelle di uno “spiraglio lontano da cui proviene [il soffio che mi rinfresca i talloni] e da cui una volta passai anch’io”, fattosi “così piccolo che se pur mi bastassero le forze e la volontà per tornare a quel punto, mi scorticherei addirittura per passar di lì”. In questo passo il processo di ominazione è sì visto come un’evoluzione continua e progressiva, ma il riferimento a una soglia ben precisa è talmente esplicito da non poterlo ignorare. C’è, al fondo della narrazione di Pietro il Rosso, una feritoia il cui passaggio risulta estremamente doloroso, qualsiasi sia la direzione in cui la si attraversa.
È soprattutto di questo dolore che bisogna occuparsi per comprendere il racconto. Il passaggio alla condizione umana avviene sotto l’insegna della violenza: sono due colpi di fucile a interrompere l’idillio della scimmia. Dell’agguato, tuttavia, l’io narrante non conserva memoria alcuna. Probabilmente a causa della sua traumaticità, l’evento viene confinato nella sfera del rimosso. Assieme a questo, però, Pietro perde memoria anche della sua vita da scimmia, facendo sì che la sua relazione presso l’accademia risulti difettiva proprio nel suo oggetto stesso. È questa lacuna a alimentare il racconto, nonché a elicitare il tentativo, tanto di Pietro quanto nostro, di individuare il momento esatto in cui il mutamento avviene o ha inizio.
La comunione di intenti che ci lega a Pietro è sintomatica. L’oblio esperito dall’io narrante, con il conseguente tentativo di recupero di quanto rimosso, se letto in parallelo con la perdita di libertà che comporta l’ingresso nel regno umano, determina, forse, la dimensione più umana di Pietro. Da questo accostamento emerge, infatti, la convinzione che alle proprie spalle ci sia un eden, nel quale si viveva liberi e dal quale si è stati sottratti in maniera coatta. Di questa convinzione, la relazione, intesa come tentativo di recupero quantomeno narrativo di quella dimensione aurea, è conseguenza. Il mito di un’età dell’oro si intreccia con il mito della caduta, di un momento puntiforme in cui la libertà viene perduta e viene segnata l’origine dell’umano. L’appartenenza di questo intreccio al mondo umano emerge in maniera chiara nel brano in cui Pietro osserva due acrobati al trapezio, il cui incipit eloquente recita: “troppo spesso gli uomini si ingannano fra di loro con la libertà”. In questo passaggio, Kafka sembra mostrare come l’assenza di libertà sia una condizione strutturale dell’uomo, e altrettanto strutturale e ineluttabile sia la tensione verso questa. Gli acrobati volteggiano in aria, credendosi liberi, e ciò suscita il riso di Pietro, che riconosce come unica libertà quella animale, pur non avendone memoria. La sua convinzione, pertanto, non avrebbe più valore della medesima idea espressa da un essere umano. Pietro, infatti, non ha ricordi della Costa d’Oro, così come l’uomo non ne ha dell’Eden. La gabbia, non lo sparo né tantomeno la vita animale, è il primo ricordo di Pietro, così come il desiderio di assoluto dettato dall’assenza di questo, e non l’assoluto stesso o la caduta che ce ne separa, è il primo ricordo, la prima certezza dell’umanità. È pertanto solo grazie alla sua natura anfibia che Pietro gode, agli occhi del lettore, di un’autorità impareggiabile. Si devono quindi sottolineare i punti in cui Pietro diverge dai comportamenti umani, perché proprio in questi alligna il significato più profondo del racconto.
Il riso di Pietro, dal punto di vista umano un’anomalia, è dovuto al fatto che, singolarmente, la libertà non è mai stata oggetto del suo desiderio né delle sue illusioni. Un’ulteriore spiegazione di questa risata emerge se si torna all’immagine della porta divenuta, col tempo, spiraglio. In seguito a questa, l’io narrante chiosa: “la vostra origine scimmiesca, signori miei, ammesso che qualcosa di simile sia esistito nel vostro passato, non può essere per voi più remota di quanto non sia per me la mia. Al tallone, però, chiunque cammini su questa terra, ne avverte il solletico: tanto il piccolo scimpanzé come il grande Achille”. È questo solletico, questo leggero soffio che rinfresca i talloni, a far credere agli uomini che si possa tornare a uno stadio primigenio e libero scimmiottando, come fanno gli acrobati, i movimenti degli animali. Se un simile ritorno è precluso all’io narrante che, nonostante la sua trasformazione, conserva un legame più intenso col mondo animale, non si capisce come a compierlo possa essere un uomo. La relazione di Pietro ha come risultato proprio questo: mostrare come persino per lui, creatura anfibia, un ritorno all’eden sia impossibile.
Di questa attenzione kafkiana per il racconto dell’origine Kracauer è acuto osservatore. In La massa come ornamento si legge: “quasi al contrario di chi crede nel progresso, [Kafka] trasferisce nel passato questo stato di libertà, o almeno la possibilità di goderne”. Ma non è questo il punto. Del mondo animale, della libertà della scimmia, a Kafka in fin dei conti importa solo in maniera relativa. Tuttavia, come intuisce Benjamin nel testo già citato, il passaggio dal regno animale è un passaggio obbligato: “si può capire perché Kafka cercasse continuamente di captare dagli animali la presenza del dimenticato. Essi non sono la meta; ma sono indispensabili per arrivarci”. Ma qual è la meta alla quale Kafka cerca di condurre con questo racconto?
La risposta, forse, si può trovare nell’ambigua risata di Pietro il Rosso. Questa, infatti, svela la nostalgica illusorietà di una libertà totale e, allo stesso tempo, indica la strada per una libertà mediata e limitata, consistente nella consapevolezza della situazione in cui stalla l’umanità. Parimenti, Kafka, come nota ancora Kracauer, “non intende trasfigurare come utopia realizzata una forma di vita passata, ciò che gli interessa soprattutto è di caratterizzare la totale chiusura della condizione presente”. Al notissimo aforisma kafkiano che qui echeggia, secondo cui ci sarebbe una quantità infinita di speranza nel mondo ma non per noi, si può forse aggiungere la glossa della postura critica e demistificatrice di cui tanto Kafka quanto Pietro sono esempio.
ENDOXA - BIMESTRALE LETTERATURA Endoxa Maggio 2024 FRANCESCO SCOLLO Kafkiana