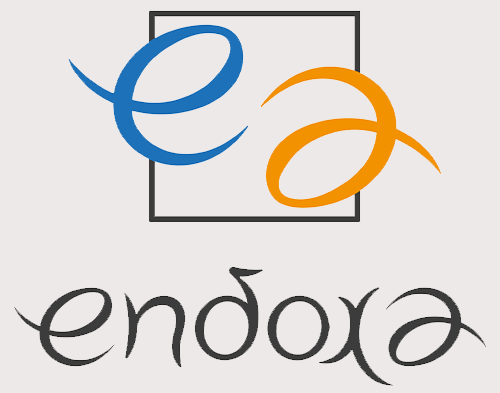LA BI-LOGICA DI KAFKA
 TOMMASO GAZZOLO
TOMMASO GAZZOLO
1. Queste brevi considerazioni non riguarderanno che la scrittura di Kafka, la sua forma, la sua logica. In Solo come Kafka, Marthe Robert aveva osservato come la sua scrittura procedesse attraverso una certa messa in movimento della letteralità, in grado di farla funzionare come il meccanismo alla base delle metamorfosi costantemente in opera nei suoi testi. Perché la metamorfosi non ha bisogno di «operazioni molto complicate»: le basterebbe sfruttare le risorse «degli pseudo-ragionamenti che la retorica e la grammatica le forniscono in abbondanza». Così, data la proposizione antisemita “l’ebreo è un cane”, questa è immediatamente presa alla lettera e lasciata slittare fino a trasformarsi in quella “il cane è un ebreo” – e da lì procederanno le sue indagini. Analogamente accade con quel “chi va a letto con i cani si alza con le cimici”, Wer sich mit Hunden zu Bett legt steht mit Wanzen auf, pronunciato da suo padre. Sarà sufficiente trasformarlo appena – attraverso la sostituzione di “alzarsi” con “essere” – per aver come risultato i due «falsi proverbi» “chi si prende le cimici è lui stesso una cimice” e “chi va a letto con i cani è lui stesso un cane”.
Deleuze e Guattari non diranno qualcosa di molto diverso, quando insisteranno su come la scrittura di Kafka non proceda che secondo linee di fuga – anzitutto fuga dalla “propria” lingua, o dal linguaggio da se stesso: ma fuga dice, appunto, che non si tratta mai di procedere per metafore, di “arrestare”, cioè, le parole, per farne dell’una il significato dell’altra (del tipo: “cane” sta per, al posto di, significa: “ebreo”), bensì di lasciar proliferare la loro letteralità, di rendere mobili i passaggi dall’una all’altra (se ogni ebreo è un cane, allora ogni cane sarà ebreo). È in questo senso che si dovrebbe parlare di un Kafka schizofrenico, di una logica “schizo” propria di Kafka – ma a patto di chiarire che il pensiero schizofrenico non è altro che un particolare caso di applicazione dei principi logici propri dell’inconscio in quanto tale.
2. Se seguiamo, qui, il lavoro di Matte Blanco, diremo che l’inconscio opera secondo due principi fondamentali: quello di generalizzazione e quello di simmetria. Del primo, Blanco dà la seguente definizione: trattare una cosa individuale (persona, oggetto o concetto) come se fosse un membro o elemento di un insieme o classe che contiene altri membri; trattare questa classe come sottoclasse di una classe più generale; trattare questa classe più generale come una sottoclasse di una ancora più generale, e così via. Così nella scrittura di Kafka, in cui tutto assume valore collettivo, per dirla ancora con D&G: ogni enunciazione individuata è immediatamente già enunciazione collettiva – è per questo che K., nome formato di una sola lettera, non è un nome individuale, in fondo, se non in quanto è trattato da Kafka come istanza di un insieme che lo contiene, e quell’insieme come istanza di un altro insieme, etc. Così Kafka forma i suoi “popoli”: quello dei topi, quello dei cani, che sono anche sempre popoli “mancati” o popoli “in appello”, in quanto non cessano di concatenarsi collettivamente in classi sempre più ampie.
Segue il principio che Blanco chiama di simmetria – e che corrisponde a quanto Robert aveva intuito: il sistema inconscio “tratta la relazione inversa di qualsiasi relazione come se fosse identica alla relazione”. E cioè: le relazioni asimmetriche sono trattate dall’inconscio come simmetriche. Se “Giovanni è il padre di Pietro”, per l’inconscio vale anche che “Pietro è il padre di Giovanni”. Ciò che nella logica aristotelica è assurdo, diviene invece il principio di funzionamento dell’inconscio. Per questo vale, in Kafka, che se “tutti gli ebrei sono dei cani”, allora “tutti i cani sono ebrei”. Ma da tale principio, come Matte Blanco osserva, seguono una serie di conseguenze – che, per quanto non mi sembra sia stato ancora sufficientemente sottolineato, spiegano perfettamente i procedimenti all’opera nella scrittura di Kafka.
La prima è che il principio di simmetria abolisce la successione temporale: l’enunciato “A viene dopo B”, infatti, è immediatamente reso identico a “B viene dopo A”, con la conseguenza che, a saltare, ad essere impossibile, è ogni ordinamento seriale degli eventi, ogni possibilità di ordinarli in una successione. È esattamente questo che è all’opera nel Processo, e che rende semplicemente vano e inutile interrogarsi sull’esistenza di una “colpa” o meno: ché, se la pena deve seguire alla colpa, è sempre vero, qui, che la colpa deve seguire la pena. Anders ha parlato diffusamente di questa “paralisi” del tempo in Kafka, in forza della quale “il processo comincia con una accusa che rimane del tutto infondata; ma essa trascina l’accusato K. nella colpa” o, in America, fa sì che il protagonista riceva “la lettera per cui viene cacciato dalla casa di suo zio; ma, come risulterà in seguito, la lettera era già stata scritta, prima ancora che la causa della cacciata si fosse verificata”. È chiaro come la logica “giuridica” venga qui sottoposta ad un trattamento “schizo”: il principio garantista per cui non c’è pena senza colpa, si trasforma – o meglio: si scopre identico – a quello per cui non c’è colpa senza pena, per cui la punizione crea la colpa che pure dovrebbe accertare e quindi presupporre.
Ma anche la relazione parte-tutto è abolita: perché, se si applica il principio di simmetria, la relazione “il braccio è parte del corpo” implica quella inversa, “il corpo è parte del braccio”. Nell’inconscio, non solo non c’è successione, allora, ma anche non vi vale più il principio per cui il tutto non è maggiore della parte. Se il messaggero non riuscirà ad uscire dalla stanza dell’imperatore morente, allora, è perché la distanza per arrivare alle scale non sarà minore di quella per percorrere il cortile, come non lo sarà di quella che li separa dal secondo palazzo e dal suo secondo cortile, e così via.
Allo stesso modo, il vecchio fa bene a stupirsi di “come un giovane possa decidersi ad andare a cavallo sino al prossimo villaggio senza temere (prescindendo da una disgrazia) che perfino lo spazio di tempo, in cui si svolge felicemente e comunemente una vita, possa bastare anche lontanamente a una simile cavalcata”: perché il tempo di durata della vita intera non è maggiore di quello della cavalcata, dal momento che andare a cavallo fino al prossimo villaggio è sì parte di quanto si può fare nella vita, ma solo in quanto la vita intera non è che una parte della cavalcata fino al prossimo villaggio (e dunque si morirà prima di raggiungerlo, necessariamente). È lo stesso principio, questo, che riorganizza, necessariamente, le relazioni spaziali: perché se a è a destra di b, allora b è a destra di a. La contiguità, per come la pensa la logica classica, salta: svanisce, ed al suo posto si inserisce quella spazialità che è propria della scrittura kafkiana – basti pensare ai corridoi del tribunale, a questa specie di contiguità senza coerenza in cui stanza, porte, sentieri, passaggi comunicano senza che vi sia più la distinzione tra vicino e lontano, destra e sinistra, alto e basso.
Il principio di simmetria, infine, rende piene classi che, secondo la logica “classica” o aristotelica, sarebbero per definizioni vuote – ad esempio quella la cui funzione sarebbe del tipo “p e non-p”. Come Matte Blanco indica, in logica se chiamo p “essere vivo” e non-p “essere morto”, la classe definita dalla funzione “p e non-p” è necessariamente vuota, in applicazione del principio di non contraddizione: nella classe, cioè, di chi è vivo e morto, non può, per definizione, inscriversi nessun individuo, nessun membro. E tuttavia, “essere vivo” ed “essere morto” sono sottoclassi di una classe più ampia, la cui funzione proposizionale “può includere tutte le possibilità riguardanti la vita”. Ma allora, in forza del principio che rende simmetrica la relazione parti-tutto (per la quale la parte è sempre identica al tutto), ciò implica, per l’inconscio, che essere vivo sia identico ad essere morto. La classe di quelli che sono vivi e morti, allora, diventa pensabile come una classe piena. Il Cacciatore Gracco, allora, può essere morto e al contempo essere vivo – ed è da qui che bisognerebbe ripensare, con Blanchot, tutto il tema dell’impossibilità di morire e dell’esser morto in Kafka, tale per cui “non moriamo, ecco la verità, ma il risultato è che neppure viviamo, siamo morti alla nostra stessa vita, siamo essenzialmente dei superstiti”. Anche Odradek è un oggetto di questo tipo: immortale, o, meglio non morto, e proprio per questo in qualche modo vivo. Ma Odradek riprende anche quella logica, come ha notato Zizek, tale per cui, in Kafka, le cose divengono in qualche modo “umane” solo quando cessano di somigliare ad un essere umano – in applicazione del principio che si è visto, che rende piene classi che dovrebbero essere “vuote”: si dà la classe dell’essere umano e non umano, ed in essa si danno oggetti ed individui. Gregor Samsa diviene umano, in fondo, solo divenendo un insetto.
3. Ciò di cui si tratterà allora, nella scrittura di Kafka, sarà di trascinare, far divenire asimmetria la simmetria, “bucare” la logica del pensiero, del cosciente (che è sempre la logica a-simmetrica) – o meglio, per dirla con Matte Blanco: lasciare che il principio di simmetria possa sciogliere, come un potente acido, certi punti, certe giunture, certi tubi che sono quelli in cui scorre il nostro pensiero ordinario. Kafka lo fa, come è stato più volte notato, a forza di “sobrietà”, diremmo, a forza di letteralità – il suo modo di spingere una logica verso l’altra, di operare trasformazioni, spostamenti, sostituzioni. Va da sé che tutto ciò non servirà certo ad una “esplorazione” dell’inconscio – non è una logica del sogno o dell’incubo, per dirla con Welles, a essere decisiva, qui –, quanto a far sì che la realtà possa, in qualche modo, lasciarsi “afferrare” per ciò che essa è. Perché se il pensiero comincia a “sciogliersi” – a forza, lo ripeto, di prenderlo alla lettera, e di operare su di esso con le sue stesse regole –, esso comincia ad acquistare una nuova forza, ad aprirsi nuove direzioni, connessioni nelle cose e tra le cose. In tal senso, ogni interpretazione “psicoanalitica” di Kafka, così come la ricerca di un certo “significato del cassidico” (Walter Jens) nella sua opera, rischiano di non centrare il bersaglio, in quanto confondono il senso della scrittura con quello dei suoi contenuti. Che allora in Kafka ciò che è usuale divenga straordinario, e ciò che è straordinario sia abbassato al livello dei fatti comuni, non dipende da quanto Kafka si proporrebbe di dire, bensì dalle regole della sua scrittura, la quale si fa progressivamente sempre più chiara, esatta, asciutta, “logica”, proprio per acquisire così quella “letteralità” che finirà per corrodere la logica stessa da cui deve liberarsi. Per questo lo stesso sarà l’altro, l’inusuale ovvio, e viceversa.
Quello che è stato chiamato il metarealismo di Kafka – in corrispondenza con il concetto di metageometria (Felix Weltsch) – si avvicina, a quanto la bi-logica intende, qui, cogliere: che la spinta all’esattezza, a dire la cosa per come essa “è”, alla “lettera”, coincide con la scoperta, proprio attraverso tale spinta, di un’altra logica, che farà pertanto apparire la “realtà” in modo nuovo. Lo abbiamo visto con il trattamento che Kafka fa subire al verbo essere, all’essere predicativo – attraverso la legge della simmetria: perché dire che A è B, significa, alla lettera, dire l’identità del soggetto con il predicato, dire che ciò che è detto e ciò di cui è detto sono lo stesso (“l’ebreo è un cane” non può, in tal senso, che dire lo stesso di “il cane è un ebreo”). Certo, A non è B: l’identità dice anche, inevitabilmente, l’essere identico dei diversi, dei differenti. Ma proprio per questo il principio di simmetria apre ad una scrittura che lavori per abolire questa differenza, per rendere il linguaggio più rigoroso, di modo che questa identità possa finalmente apparire come tale. Per questo Gregor dovrà trasformarsi in una cimice, e la cimice in Gregor, di modo che dall’uguaglianza (A=B) si riesca finalmente a passare al loro essere lo stesso, ad una A che è A, che non è che se stessa. Molti dei racconti di Kafka – o meglio: dell’esigenza, della necessità che li rende urgenti – si spiegano in questi termini: esigenza di chiarezza, di una lingua esatta, che sia in grado di dire la cosa per come è, per come la “logica” della lettera la rende necessaria.
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA Endoxa Maggio 2024 Kafkiana tommaso gazzolo