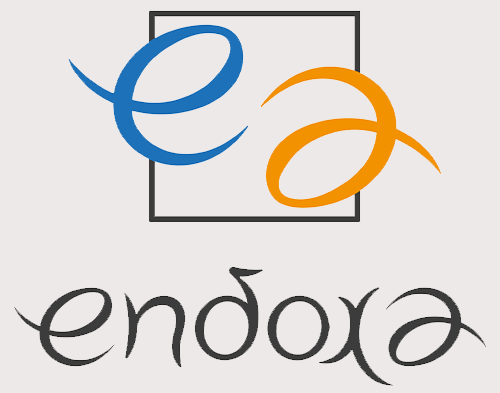L’INCIAMPO E IL DOPPIO: KAFKA E IL PADRE
 ULDERICO POMARICI
ULDERICO POMARICI
1. In uno dei suoi aforismi Kafka afferma: “La vera via passa su una corda, che non è tesa in alto, ma rasoterra. Sembra fatta più per far inciampare che per essere percorsa”. Se prendiamo questo pensiero alla lettera esso potrebbe significare che la nostra vita, se vissuta in regime di verità, cammina su di una corda tesa che non dobbiamo evitare. È come avere la scelta fra due ‘maniere’ di vivere. C’è una strada, pochi millimetri sotto di noi sulla quale potremmo comodamente camminare o tenerci in equilibrio precario su questa corda tesa come un giocoliere: il mondo di Kafka, dice Benjamin, “è un teatro universale. Per lui l’uomo è naturalmente in scena”. Bene, credo che questo ‘doppiofondo’ − quello che ‘normalmente’ si percorre sulle strade e quello sul quale, in regime di verità, siamo costretti a precorrere su quella corda tesa che è il nostro ‘vero’ fondo stradale − configuri uno stato di indecisione, una doppia vita, che racconta bene, in metafora, l’ossessione di Kafka per la figura paterna. Franz non è mai in possesso della propria vita. Per questo, fra l’altro, non potrà né sposarsi né generare né ambire a qualcosa che lui possa ritenere degno. Esistono almeno tre testi nei quali il rapporto col padre viene messo in scena: il più celebre, La lettera al padre, ma poi Il cruccio del padre di famiglia, e infine La Condanna.
2. Ma questi stati di indecisione continuano intanto a perseguitare Kafka anche altrove, una ‘striscia’ fra “somiglianze di famiglia”, come nella storia del cacciatore Gracco che muore cadendo da un dirupo nell’inseguire un camoscio. Ma ‘in realtà’ non riesce a morire veramente e in modo definitivo perché da migliaia di anni vaga sui mari della terra per colpa del timoniere, sulla cui barca funebre il suo cadavere era adagiato, che non riuscendo a trovare la via dell’oltretomba, costringe il cacciatore a un perenne peregrinare da morto sulla terra; ma un morto che si racconta e racconta la propria condanna a una semivita o similvita, come saranno i personaggi dell’Ubik di Philip K. Dick: “Ero vissuto volentieri e volentieri ero morto”, dice Gracco. Il timoniere, che gli nega la morte autentica che lo sottrarrebbe alla doppiezza è una figura del Padre. L’errore lo condanna a errare in eterno. E che questa di vagare senza una meta, senza possibilità di redenzione né di ribellione sia una necessità ineluttabile alla quale sottomettersi Franz lo afferma a chiare lettere in un suo aforisma: “uno dei più efficaci mezzi di seduzione del male è l’invito alla lotta”. Perché del padre K. non può liberarsi. Il padre è la sua lettera e dunque la sua vita. Al suo peso esistenziale occorre rassegnarsi fino all’annichilimento. Solo suicidandosi, come accadrà in un altro racconto, La Condanna, dove il figlio Georg, per timore del rifiuto paterno, nasconde il tentativo di matrimonio subendone la terribile reazione: “Non t’ingannare! Sono ancora il più forte e di molto [..] Prendi pure a braccetto la tua fidanzata, e vienimi incontro! Te la spazzo via dal fianco e non sai come [..] Ora sai dunque ciò che esiste al di fuori di te, finora non conoscevi che te stesso. Eri davvero un bambino innocente, ma ancor più un essere diabolico! E perciò sappi: ti condanno a morire affogato!”. E il figlio, in preda a un metafisico senso di colpa, esegue la condanna inflittagli dal padre gettandosi al fiume. In Kafka, dice Benjamin, “il padre è colui che punisce. La colpa lo attira come i funzionari del tribunale. Molti indizi fanno ritenere che il mondo dei funzionari e il mondo dei padri sia − per Kafka − lo stesso”.
3. Il timore (Sorge) del padre di famiglia, presenta di nuovo uno spazio di ambiguità, stavolta linguistica: Odradek, è il figlio dal nome di origine misteriosa: slava o tedesca? Che cos’è questo nome? L’indecisione sancisce la sua incompiutezza, una qualche collocazione. In fuga dal senso, transfuga, apostata. Che non ha re-ligio. Impossibile da far ricadere nel dominio paterno. Di qui la Sorge del genitore. “Il più strano bastardo che la preistoria abbia generato in Kafka con la colpa è Odradek” dice Benjamin. Non è neanche un animale come ne La Metamorfosi: sulle prime, dice Kafka “ha l’aspetto d’un rocchetto di spago piatto a forma di stella, e infatti sembra anche che sia rivestito di spago; certo devono essere soltanto pezzi di spago strappati, vecchi, annodati insieme, o anche pezzi di spago di colore e specie diversissimi messi insieme. Si sarebbe tentati di credere che questa formazione avesse avuto in passato una qualche forma razionale e che ora sia semplicemente rotta”. Un essere- rotto, inutile. Ecco che Odradek sembra avanzare come figura dell’inconscio, dell’Unheimliches: non è possibile parlarne perché non ha un nome sensato, ma poi, soprattutto, perché “Odradek è straordinariamente mobile e impossibile ad acchiapparsi. Si trattiene alternativamente nelle soffitte, sulle scale, nei corridoi, al pianterreno”. È imprendibile e ovunque. Questa potrebbe essere la vendetta sul Padre, e la Sorge del genitore che non riesce più a dominarlo. Dove abiti? gli si chiede. E lui: “Senza fissa dimora “, dice, e ride con un suono che somiglia al fruscio di foglie cadute. “Forse dovrà allora un giorno rotolare ancora per le scale trascinando i suoi fili arrotolati fra i piedi dei miei figli, e dei figli dei miei figli?” si chiede il padre. Generazioni che cascano, come la forma di vita dell’umanità beckettiana.
4. Il culmine del dissidio col Padre lo troviamo nella Lettera al padre: l’inciampo esistenziale si materializza con l’idea che proprio chi ti è più vicino, chi ti ha dato la vita, può diventare il Nemico assoluto, quello che orienta ogni tuo agire costituendo l’orizzonte degli eventi. Sulla scena della Lettera Franz si presenta come un estraneo, rivendicando il suo non-possesso dei ‘caratteri’ propri dei Kafka. Lo scrittore è un uomo ontologicamente in esilio avendo il Padre occupato tutto il territorio fin dalla sua nascita. E Franz, in questo dialogo immaginario col padre, attesta la propria impotenza, “la convinzione ormai profondissima che per mantenere una famiglia e poterla guidare occorra necessariamente tutto ciò che io ho individuato in te, insieme, buono e cattivo, come è fisiologicamente riunito in te, quindi forza e disprezzo del prossimo […] senso del dominio e tirannia, conoscenza degli uomini e diffidenza verso la maggior parte di essi”. Ecco: Franz non è così. Non che egli si ritenga migliore! Semplicemente non ritiene di poter appartenere ai Kafka. Né vuole appartenere. Preferisce l’estraneità. Franz immagina che l’occupazione paterna del suo territorio divida il mondo in tre parti, del tutto separate le une dalle altre: nel primo mondo, in cui egli vive solitario come in un ghetto, è schiavo di leggi create solo per lui, leggi di un universo totalitario, alle quali lui si trova sempre, evidentemente, a disobbedire incorrendo così nelle punizioni paterne; nel secondo mondo c’è il Padre, che da lì impartisce gli ordini andando in collera se non vengono eseguiti. Infine, nel terzo mondo, vive l’intera umanità, “felice e libera da ordini e da obbedienze”, una sorta di Eden dal quale lui è escluso a priori. Così, la vergogna diventa la sua forma di vita. Vive di vergogna e di paura. Ma non si piega del tutto al Nemico. Tutt’altro. Nasce sconfitto ma duellante. È lui, infatti che in prima persona – nella scrittura recupera il ruolo di protagonista che non può avere nella vita ! – conduce il discorso parlando per entrambi: in suo proprio nome e in vece del Padre. Diventa due: e non è questa, la rappresentazione, la natura dell’auctoritas? E’ il rovesciamento immaginario dell’autorità paterna: Franz si fa Soggetto del discorso e inizia un monologo abitato dal fantasma del Padre. Che cosa racconta Franz? Da una parte il Figlio, con una dominante “sensazione di nullità”, attraversato dal senso di colpa, dalla diffidenza che egli nutre verso se stesso che infirma ogni sua azione; dall’altra il Padre: impulso vitalistico e “una certa smodatezza”, con “l’aspetto enigmatico dei tiranni, la cui legge si fonda sulla loro persona, non sul pensiero”. La sensazione di nullità – esemplificata in un’affermazione lapidaria :”disimparai a parlare” – gli è stata indotta, negli anni, attraverso la minaccia (“Non ammetto obiezioni”) e il gesto paterno (“quella mano alzata”). Così, davanti al padre, Franz non riesce a pensare né a parlare : incespica, balbetta, fino a tacere del tutto. Il Padre lo rimprovera aspramente per questa sua nullità – così Franz nella replica immaginaria – : “Sei incapace di vivere”. Agli occhi del Padre quella di Franz contro di lui è “la lotta dell’insetto che non solo punge, ma al tempo stesso succhia il sangue per mantenersi in vita”. Il Padre è invece “l’uomo gigantesco”, “la misura di tutte le cose”, “l’autorità suprema”, dunque la Legge, che parla il suo proprio linguaggio e non ammette dialogo ma solo obbedienza : “solo il tuo punto di vista era giusto, ogni altro era demenziale, folle, stravagante, anormale” continua Franz nel suo dialogo immaginario. Così, il territorio che il Padre occupa è inespugnabile e tale deve restare, proprio come quello di uno Stato-Nazione: “a volte immagino la carta della terra spiegata e tu sopra, disteso di traverso. Ed è come se, per la mia vita, potessi prendere in considerazione solo le zone che tu non copri o che sono fuori della tua portata”. Dentro questo dominio si può vivere solo come sudditi che obbediscono mossi dalla paura. O meglio, come esclusi. Franz, infatti, si nega la possibilità di varcare il confine di quel territorio che non è il suo – il matrimonio, “la meta più alta” – il dominio per eccellenza, entrando nel quale si configurerebbe un atto di lesa maestà, un vero e proprio parricidio : sposarsi vorrebbe dire, nell’immaginario di Franz, sostituire il Padre, violare il suo “ambito esclusivo”. Così, Franz non entrando nel matrimonio si nega il desiderio ma, negandoselo, resta schiavo, prigioniero del fantasma paterno e del desiderio stesso. Il matrimonio sarebbe per lui il segno della libertà e dell’emancipazione ma, proprio per questo, per Franz è “una meta troppo alta”, impercorribile. Nella condivisione di questa consegna paterna c’è la paradossale fedeltà della vittima che – obbedendo al diktat del Padre – preferisce immolarsi piuttosto che perpetrare il crimen laesae maiestatis. Georges Bataille riferisce che Kafka avrebbe voluto intitolare l’intera sua opera Tentazioni di evasione dalla sfera paterna. Ma insinua il fondatissimo dubbio che Kafka non avesse alcun desiderio di evadervi realmente. Quella fra lo scrittore e il Padre è ‘in realtà’ una lotta fra due parti di Franz. Narrazione e vita si confondono rinviando tragicamente l’una all’altra: Franz voleva restare sotto l’autorità paterna in una condizione di esclusione, ma, insieme, vivere narrativamente quella dismisura per poterla infinitamente, nella scrittura, negare. Negare l’autorità senza tuttavia essere in grado di farne un esodo reale. Così, per Franz, scrivere è uno dei suoi “tentativi di fuga” fallimentari, utile solo a confermare l’inazione e l’impossibilità di uscire dal cerchio paterno. Infatti, sempre nel suo dialogo immaginario col Padre afferma: come scrittore “ero riuscito realmente a ritagliarmi uno spazio indipendente da te”, ma – con un’ennesima metafora teriomorfica che esprime tutta la sua disperazione – nel farlo, “ricordavo un po’ il verme che, schiacciato da un piede nella parte posteriore, riesce a liberare la parte anteriore e striscia via di lato”. La scrittura e la morte. La scrittura è la morte. E Franz vi si abbandona: “das Nichts wählen”, scegliere il Nulla.
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA Endoxa Maggio 2024 Kafkiana ULDERICO POMARICI