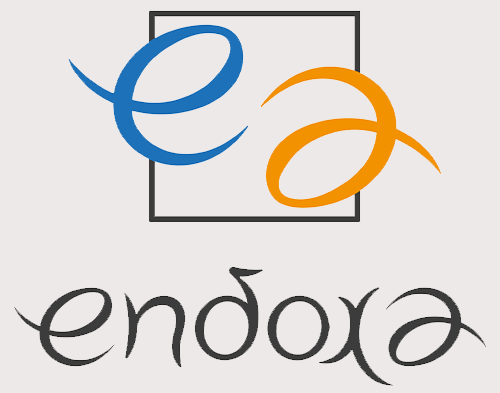T-KAFKA
 JUAN CARLOS HERRERA RUIZ
JUAN CARLOS HERRERA RUIZ
Molti anni fa, non ricordo esattamente dove, lessi una recensione di un libro di racconti di Kafka, tradotto postumo e pubblicato in spagnolo, in cui si diceva che, in una fase della sua vita, il nostro autore era solito incontrare un gruppo di amici intimi in un caffè viennese per leggere loro alcuni di quelli che allora erano i suoi nuovi tentativi narrativi. Si dice che questi incontri fossero molto piacevoli e che, di norma, i presenti ridessero a crepapelle per ciò che il loro amico scrittore leggeva loro, e che lo stesso Kafka finisse per ridere delle sue stesse creazioni.
Questa evocazione, apparentemente innocua e difficilmente verificabile, acquista improvvisamente molto senso rispetto a una lettura attuale de Il processo, come formula letteraria che in modo quasi impercettibile riesce a mettere sullo stesso piano l’assurdo, la distopia, l’umorismo e una realtà che si presenta a noi, nella contemporaneità on line delle nostre vite, in tutta la sua dimensione schiacciante: la nascita di un nuovo sistema di diritti e doveri che si contrappone a quello esistente, superandolo in violenza e corruzione, e rinnovando il suo slancio proprio nell’invocazione dell’innovazione tecnologica e nella ricerca dell’efficienza.
Il processo che si sta affrontando nella contemporaneità ha tutte le sembianze del diritto e della giustizia in tempo di guerra, cioè quando lo Stato esercita una violenza che contrasta con l’esistenza stessa dello Stato di diritto, per controllare e punire, anche preventivamente, coloro la cui coscienza è aliena dal modello di pensiero e dalla corrente di azione imposti dal potere, senza che la maggioranza dei cittadini minimamente se ne accorga.
Questa giustizia di guerra ci viene presentata in due modi fondamentali: il primo è che viviamo in uno stato di “libertà vigilata” che può essere cambiato in qualsiasi momento; il secondo è che, una volta interrotta tale libertà vigilata, il cittadino non conosce i motivi per cui viene privato della libertà o processato, e questo non per ignoranza delle leggi, ma perché tali leggi, in tempo di guerra, non sono sufficienti ad autorizzare lo Stato a perpetrare le operazioni più crude contro cittadini vulnerabili e rispettosi del diritto che, anche senza violare la legge, rappresentano un “pericolo” per la sicurezza o l’ordine di quello Stato. Questa “ignoranza” della condizione distopica in cui si vive abitualmente, sotto la nozione di giustizia e di diritto, era già stata anticipata da un contemporaneo di Kafka, Walter Benjamin, nel suo Sulla critica del presente.
Ma ai tempi di Kafka e Benjamin non esistevano i mezzi di sorveglianza di cui dispongono oggi la giustizia e l’ordine: stiamo parlando di un nuove modalità di controllo che per analogia possiamo associare al dispositivo a cui è sottoposto K. Il nostro dispositivo è l’intelligenza artificiale. E il parallelo tra il processo a cui è sottoposto K e lo stato di sorveglianza permanente a cui siamo sottoposti oggi, attraverso le nuove tecnologie, ci si presenta in tutta la sua chiarezza. Walter Benjamin si era preoccupato di caratterizzare le trasversalità poco velate tra il fascismo, l’omologazione della coscienza alla lotta di classe e il ruolo divulgativo dei media tecnologici nel suo saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, dove mette in guardia dalla coltivazione di un paramilitarismo di Stato senza freni, che trasforma l’ideologia nel feticcio della merce e che si affida alla diffusione di contenuti mediatici (all’epoca il cinema era la massima espressione tecnologica) per creare una falsa coscienza e la conseguente destabilizzazione emotiva delle masse. Questi movimenti favorirono l’unione tra la borghesia industriale tedesca, le élite militari e i signori della guerra fascisti alla guida dello Stato.
Sulla stessa linea, Pier Paolo Pasolini dichiarava che i media tecnici, in particolare la televisione, non possono avere altra funzione che quella della massificazione e dell’alienazione, che sfruttano l’ingenuità dello spettatore per porlo in una posizione di inferiorità rispetto al mezzo, stabilendo un rapporto profondamente antidemocratico e autoritario e già all’inizio degli anni Settanta, temeva che la mediazione esercitata dai media finisse per essere totalizzante. Questa opera totalizzante avrebbe portato, ad esempio, all’affermazione di un particolare modo di parlare e di pensare da parte di chi detiene il potere, e questo è proprio il modo in cui la classe operaia parla e pensa, non appena esce dalla sfera quotidiana o familiare, poiché tutto ciò che viene dall’“alto” è preferibile a ciò che è desiderato dal “basso”. Così, nel linguaggio parlato della classe operaia non c’è nulla che non sia già stato organizzato dal potere, al punto che l’unica cosa che rimane originale nel linguaggio della classe operaia è la sola dimensione non verbale.
Seguendo l’intuizione di Pasolini, ci sembra che così come K si trova invischiato in un assurdo vortice di argomentazioni giuridiche, in una sorta di nuovo ordine sociale, a lui sconosciuto in quanto apparso dal nulla, il cittadino K di oggi si trovi di fronte a un nuovo ordine sociale tecnologico, agile e ineffabile, dove il potere assume un protagonismo performativo, quasi da buffone, le cui azioni dirottano l’opinione pubblica, servilmente prona ai suoi contenuti, per ottenere il totale servilismo di chi sta in fondo alla scala sociale. Gli individui che risultano essere estranei e prodotti di scarto di questa catena di produzione di matrici di significato diventano automaticamente nemici del potere algoritmico, dalla cui fede non si può apostatare.
L’indizio che abbiamo sulla “deviazione” di K ha a che fare con il suo lavoro in una banca. Potrebbe essere un simbolismo o un’allusione a qualche comportamento scorretto legato alle sue funzioni all’interno di quella banca: forse perché avrebbe capito, come un altro contemporaneo di Kafka, Bertolt Brecht, che chi fonda una banca è più criminale di chi la rapina. Oggi K sarebbe stato spiato nelle sue e-mail, nei messaggi Whatsapp e in altre comunicazioni che lui stesso avrebbe cercato, senza successo, di nascondere o far sparire dai suoi archivi.
Ma per la numerologia dell’IA non esiste una coscienza i cui progressi possono essere nascosti o scomparire; è essa stessa uno strumento politico di modellazione ideologica che trasforma le macchine tecnologiche in un panopticon. Ciò deriva dal presupposto che, pur non possedendo una coscienza, le macchine possono essere probabilisticamente utlizzate per alterare il significato di simboli, insignificanti per la macchina (il significato è utile e leggibile solo per una coscienza che la macchina non ha), ma funzionali agli strati sociali o ai gruppi che detengono il potere.
Insomma, la pretesa di chiamare “intelligenza” l’Intelligenza Artificiale è un modo ingannevole, sfacciatamente falso e arbitrario di creare nelle masse la percezione di una realtà inesistente, ma anche funzionale a un’idea di giustizia e di diritto, la cui apparenza può essere modificata e fatta apparire coerente, in tanti modi quanti ne consentono i calcoli probabilistici, per produrre l’omologazione delle coscienza.
Questa forma di strumentalizzazione della tecnologia a favore dell’omologazione del pensiero, che abbiamo avanzato come risultato di una lettura attuale de Il processo, diventa anche l’oggetto di costruzione di una formula che permette di indirizzare il pensiero e le azioni di un’intera classe di una data popolazione in un’unica direzione a favore degli interessi del potere. Allo stesso tempo, questo potere ha trasformato il diritto in una volontà elevata al rango di legge, la volontà di una classe dirigente che ora si nasconde dietro il prodigio dei mezzi tecnologici, in modo che il contenuto della legge sia determinato dagli interessi e dalle condizioni materiali della sua vita (della classe dirigente). D’altra parte, il sistema giuridico, che di solito esprime e consolida i diritti reali di coloro che già detengono il potere nel sistema capitalistico, è riuscito, grazie ai mezzi tecnologici di sorveglianza, a fare un enorme balzo in avanti, nel senso di permettere alle classi dirigenti di aggirare o modificare a piacimento la legalità che esse stesse hanno stabilito, di creare o annullare prove e argomentazioni con la semplice pressione di un tasto, fino ad applicare ogni sorta di metodo extra-legale a loro vantaggio, conferendo al contempo diritti puramente formali alla classe operaia, come è evidente nella storia che coinvolge la nostra K. Postuliamo che l’IA basata sugli algoritmi funzioni oggi come un nuovo programma di operazioni, di regole, che vengono eseguite su un’ampia gamma di apparati tecnologici, in funzione del prolungamento dell’esistenza di certe strutture di potere politico ed economico, sotto l’egida del diritto e della giustizia, ma basate su un regime di proprietà e su un modo di produzione che, per principio, è contrario all’esistenza e all’influenza del movimento operaio, alla lotta di classe o a qualsiasi forma di alterità che comporti la modifica degli equilibri del potere corporativo, così come li abbiamo conosciuti dopo il secondo dopoguerra del XX secolo.
Quello che è diventato un luogo comune quando si parla di “lavaggio del cervello” è fondamentalmente ciò che è implicito nell’idea di fascismo di Benjamin nel già citato saggio sull’opera d’arte: questo lavaggio consiste nella creazione di schemi psicologici comuni, in virtù della funzione algoritmica, che persuadono le masse dell’esistenza di un consenso e di una rappresentatività intorno a un certo modo di essere e di stare al mondo, a ciò che è legale o illegale, offrendo loro l’illusione di potersi manifestare, ad esempio, nelle reti sociali o accademiche, e allo stesso tempo sottraendole alle questioni materiali essenziali che contano o influenzano la vita.
Ma cosa ne sarebbe stato delle comunicazioni private, delle ricerche sul web o dei post sui social media di un K contemporaneo? Sarebbero state indubbiamente sottoposte al controllo del nuovo ordine mondiale digitale; sarebbero state immediatamente rivelate come dannose per la sicurezza e l’ordine sociale, per la moralità pubblica o la pace, o per la più elementare decenza dei buoni cittadini. Conseguentemente, il sistema di giustizia, corrotto e violento come quello che Kafka affrontò con ilarità un secolo fa, oggi avrebbe scansionato l’accumulo di dati nella coscienza di K e, in modo simile a una macchina, avrebbe emesso un mandato d’arresto in cui si diceva che, effettivamente, quel cittadino aveva commesso, ad esempio, reati sessuali.