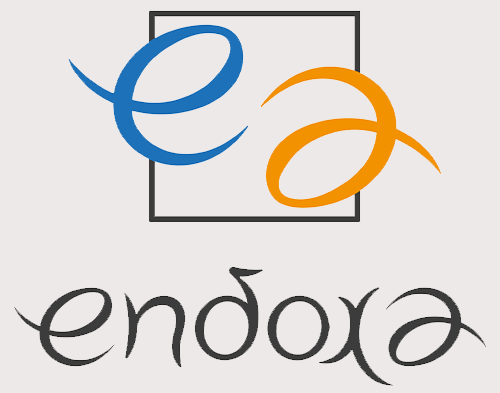GÜNTHER ANDERS E IL MESSAGGIO DI KAFKA
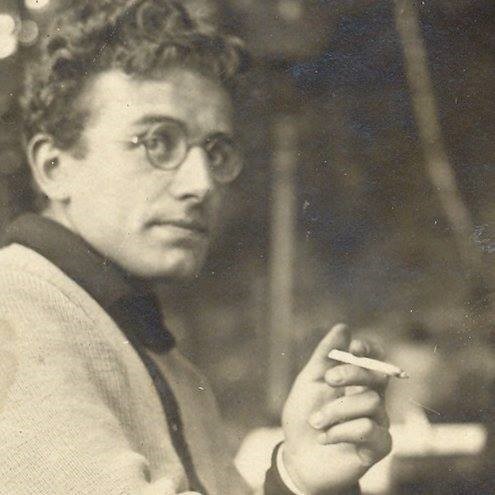 MICAELA LATINI
MICAELA LATINI
1.Occuparsi di Franz Kafka significa, per il filosofo tedesco Günther (Stern) Anders, fare i conti, in modo anche critico, con il proprio sé, significa interrogarsi sul non-senso che ha colpito la storia dell’umanità, in una sorta di “corpo a testo”, di “vita a opera”. Si tratta di un percorso su diversi livelli. Se per un verso Anders affronta il “nodo-Kafka” come Literaturkritiker – (ma queste definizioni in Anders lasciano il tempo che trovano!) –, per un altro verso l’impatto del narratore praghese su di lui affiora in modo indubbio nelle sue prove narrative, dal romanzo La catacomba molussica (Die molussische Katakombe) alle micro-storie raccolte nel volume dal titolo Lo sguardo dalla torre (Der Blick von Turm). Basti pensare all’atmosfera evocata in questi racconti, ma anche agli ibridismi delle figure che affollano le pagine letterarie di Anders, o alle situazioni che descrive nella sua prosa breve.
Lo spazio più significativo del confronto con Kafka è tuttavia quello critico-letterario. Dello scrittore praghese Anders si occupa principalmente in occasione di un seminario, dal titolo Teologia senza Dio (Theologie ohne Gott), tenuto nel 1934 all’Institut d’Études Germaniques di Parigi, dopo essere scappato dalla Germania nazista. Rielabora in seguito questi abbozzi nel 1946, durante l’esilio americano, per il testo Kafka. Pro e contro. I documenti del processo (Kafka. Pro und contra. Die Prozeß-Unterlagen), e poi per l’edizione tedesca del volume Mensch ohne Welt, quando la sua (e di tanti altri) drammatica esperienza di emigrato sarà ancora più tragicamente forte e personale. In un gioco di riflessi tra sé e Kafka, Anders propone un’interpretazione acuta e affascinante del romanzo Il Castello (Das Schloss) di Kafka: il castello rappresenterebbe il luogo da cui erano stati cacciati gli ebrei tedeschi, che, privi di ogni documento ufficiale, non sono più niente. Nella sua prima lettura dell’opera kafkiana, l’allora Günther Stern – rifugiato politico da poco sbarcato a Parigi, privato della nazionalità tedesca, escluso dalla sua comunità d’origine, succube delle soperchierie amministrative – s’identifica nell’eroe del romanzo. Anche lui come l’agrimensore K. non riesce, a dispetto dei suoi tentativi, a inserirsi nel mondo, a «fare parte del tutto», a farsi ammettere nella società. E così tutta la sua vita non è che una ‘nascita interminabile’, una infinita “venuta al mondo”. L’esistenza dell’antieroe kafkiano sarà un restare in attesa davanti alla porta della vita. Non cerca, come i mistici, un al-di-là per il bisogno di trascendere l’al-di-qua. Per questa ragione le sue storie restano sempre incompiute, e tutte le cose di questo mondo si rivelano, in antitesi alla poetica di Rainer Maria Rilke, come cose dell’altro mondo. La tesi di Anders: l’estraniazione per Kafka si presenta non solo come non-appartenenza, non solo nei termini di un “non essere a casa”, ma s’irrigidisce in un divieto metafisico. Allo stesso modo la condizione umana si configura come un “non-essere-ammesso” nel mondo. Essere un individuo, secondo il Kafka riletto da Anders, significa esistere come il “dividuo”, tagliato fuori dalla società. E tuttavia il limite dell’antieroe kafkiano è la sua inadeguatezza ad assumere la sua ex-centricità radicale, la sua “estraneità”. Vale la pena di ricordare che lo stesso Anders aveva scritto nel 1933 una novella il cui protagonista, di nome Learsi (che poi è un anagramma di Israel), proviene da una terra lontana – la Bocotia – ed è appena giunto in una città dello Stato di Topilien. Questo parente vicino di K. cerca di farsi accettare in quanto straniero all’hotel «La Libertà», che però si dichiara completo e dal quale finisce per essere espulso perché accusato di aver rubato l’insegna. È quel che accade nel Castello, massima espressione di questo impossibile approdo, dell’impossibilità di appartenere veramente che è propria della figura sociale dell’emigrato. In questo senso Anders sottolinea come lo status di straniero sia centrale nelle opere di Kafka, che spesso iniziano proprio con situazioni di approdo, e che finiscono come sforzi inutili di arrivo.
Questa tensione fa tutt’uno con quelle interpretazioni critiche che non attraccano a una verità. Se non c’è un senso raggiungibile, e tuttavia il senso va cercato, allo stesso modo la cifra della ricerca kafkiana del senso consiste nell’esodo nel deserto, nell’esilio. Non c’è solo questo; l’esilio verso l’altro e l’altrove comporta anche il venir meno della memoria. Non è un caso se la devastazione in Kafka è completa: i suoi personaggi, a differenza di quelli di Döblin, hanno perso anche il loro nome, la loro identità personale e quindi sono ridotti a un iniziale, K. (come nel Processo e nel Castello). Hanno dimenticato la loro origine e la loro destinazione, abitano in luoghi in cui è impossibile orientarsi, sono immersi nell’oblio, anzi ne sono così innervati che hanno persino dimenticato la dimenticanza, come Kafka sottolinea esemplarmente in quel fantastico paramito intitolato Prometeo (Prometheus, 1918).
2. Lo stesso K., destinato a restare straniero in tutti i luoghi, ha obliato il paese dal quale proviene, o meglio vi allude come un ‘altrove’ senza nome. Lui è “di qui”, il passato è “di là”. Ma – come recita il sottotitolo dell’opera di Anders, Diesseits als Jenseits – l’aldilà è diventato per lui questo mondo, perché l’aldiqua si è trasformato in una realtà trascendente. Per Anders, in Kafka l’origine è un altrove, dal momento che la stessa vita è un altrove. Le figure kafkiane sono ritratte ad aspettare davanti alla porta del mondo, nell’anticamera della loro vita. Anders sottolinea come la topografia fondamentale di Kafka, di tutta la sua opera, sia proprio quella della soglia, del dentro/fuori. Emblematico in tal senso è quel che scrive come nota a margine del racconto Il messaggio dell’imperatore (Eine kaiserliche Botschaft, 1917), dove il cammino del messaggero è caratterizzato dall’impossibile dirigersi dell’uomo verso il senso, verso la propria casa. Nel Kafka di Anders la speranza di una qualche comunicazione è dichiarata come impossibile: la verità non solo non può essere trovata, ma vengono anche meno le condizioni della sua ricerca. Rispetto all’altro autore “giuridico” del Novecento, ovvero Brecht, la differenza è però netta. Come Anders sottolinea nel saggio dedicato al drammaturgo svevo e contenuto nel volume Uomini senza mondo, il messaggero brechtiano deve capire il messaggio per poterlo trasmettere. Kafka invece mette in opera la distanza tra il messaggio e il messaggero. Il secondo ha il compito di trasmettere una comunicazione, anche se questa ormai risulta antiquata.
Per Kafka il messaggio dell’imperatore morente è destinato a non arrivare mai, è condannato a perdersi nei meandri dello “spazio intermedio”, tra i tanti cortili, corridoi, dimore, palazzi, porte. Non si raggiunge il villaggio più vicino, perché il tempo a disposizione, tutta la vita, è troppo breve. È questo un punto fondamentale. In Kafka la dimensione temporale è di fatto assente, e le sue opere tratteggiano un mondo in cui è impossibile morire. L’assenza di tempo pregiudica la possibilità di concetti quali il progetto e la speranza: a dispetto delle tesi di Ernst Bloch, per Anders il tempo dell’uomo è al più tempo di sopravvivenza. Lo stesso vale per lo spazio di Kafka, che fa tutt’uno con un interregno tra due mondi, con una ‘terra di nessuno’ sulle cui secche resta impigliata la bottiglia con il messaggio dell’imperatore.
Ma c’è di più. Il mondo fantastico di Kafka è così perfetto in ogni suo minutissimo particolare che non ci si può penetrare. Come spiega Anders, nell’edificio kafkiano ogni passo in avanti registra una sconfitta. Così nel Castello i continui sforzi da parte dell’agrimensore K. (che teoricamente dovrebbe misurare lo spazio) d’irrompere nel castello non fanno altro che ribadire la sua posizione di estraneità, l’essere “chiuso fuori” rispetto a un dentro cui si aspira, in perenne esilio. La peculiarità del caso Kafka sta nel fatto che non si sente chiuso dentro, ma chiuso fuori. In altre parole non è in gioco la volontà di erompere nel mondo, ma semmai d’irrompere in esso. Il mondo, e il castello che ne è una pars pro toto, è ciò che è assolutamente potente oltremisura, e invalicabile. Si tratta per Anders di una “prigione negativa” in cui l’uomo non si sente chiuso dentro, ma semmai chiuso fuori. È questa per lui la situazione in cui versa l’individuo moderno, che deve confrontarsi con la sua impossibilità di appartenere e dunque con la sua impossibilità di essere. Di qui la disperata richiesta da parte di chi non è (dunque non appartiene) di essere accettato dal mondo.
3. È proprio nelle righe iniziali del suo Kafka. Pro e contro che Anders esplicita il suo riconoscersi nello scrittore di Praga equiparando i tentativi di K. nel Castello allo sforzo proprio della comunità ebraica di appartenere a qualcosa e di essere accettati. E tuttavia trapela in questi passi anche una pesante critica a Kafka, reo di andare ampiamente oltre ciò che è compatibile con la dignità. La colpa, così centrale nell’opera kafkiana, prende i connotati di una specie di narcisismo negativo, di una voluptas humilitatis, e quindi di una forma di masochismo. Ma a ben vedere queste riflessioni introducono una questione centrale (e a ben vedere ambivalente) nella lettura che Anders offre di Kafka. Non possiamo dimenticare che il titolo dello studio recita Kafka. Pro e contro. Vediamo meglio. Oltre a riconoscere la sua ammirazione e il suo debito teorico nei confronti dello scrittore praghese, Anders muove al suo indirizzo anche un’aspra critica. Le pagine di Anders, pur riconoscendo a Kafka il merito straordinario di averci dato, insieme a Marx, la più compiuta rappresentazione di un mondo totalmente alienato, ne riconoscono il limite, consistente nel non aver attaccato lo status quo esistente. Il fatto è che Kafka sembra dire che le regole del gioco sociale sono immutabili e vanno accettate così come sono. Per questo rischia di diventare ‘inutilizzabile’ filosoficamente e moralmente, malgrado la ricchezza delle sue vedute. Il limite di Kafka sta nel fatto che il suo antieroe non agisce, ma resta in attesa davanti alla porta della vita. Certo, questa lettura non riconosce la valenza implicita dell’attendere, come tensione verso qualcosa. Il che appare quanto meno strano in un autore come Anders, che ha eletto Samuel Beckett e la sua celebre pièce dal titolo En attendant Godot a teatro emblematico della catastrofe del Novecento.
Il giudizio espresso dalle righe di questo volume può apparire come ingiusto, o almeno spropositato, ma per essere compreso va inserito nel dibattito dell’epoca, soprattutto in quello d’impostazione marxista. Anders non condivide la tesi di partito per la quale Kafka avrebbe in qualche modo contribuito a legittimare una realtà alienata, con il suo ostinato desiderio di essere ammesso in un mondo che pur presenta come assurdo. E si distanza nettamente da quella sostenuta da altri intellettuali marxisti, in primis da quelli che avevano proposto, nel 1946 e all’interno della rivista del Partito comunista francese “Action”, di “brûler Kafka”. Ben lungi dal condividere questo attacco, Anders non manca di riconoscere e di criticare quella sacca di passività che i personaggi di Kafka sono costretti a portare sulle spalle come una gobba, insieme al peso del loro castigo. Le figure kafkiane hanno interiorizzato la sconfitta e il fallimento: hanno trasformato la disperazione in una sorta di apologia della rinuncia al mondo e hanno declinato la loro esistenza nei termini di un processo insensato di accumulazione della colpa. Ma Anders va al di là di tutto questo. Invita, infatti, a leggere Kafka in negativo, a farne un monito prezioso per il futuro: la sua opera tratteggia il mondo come non dovrebbe essere. In altre parole occorre, per Anders, interpretare gli atteggiamenti delle figure kafkiane come ‘segnali di pericolo’, come negativi rispetto a quella che deve essere la nostra forma di vita. Di qui la raccomandazione di Anders, per il quale non serve a nulla bruciare Kafka, come richiedono i marxisti ortodossi. Occorre invece imparare a «comprenderlo a morte», e questo non è davvero uno sforzo da poco.
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA Endoxa Maggio 2024 Kafkiana MICAELA LATINI