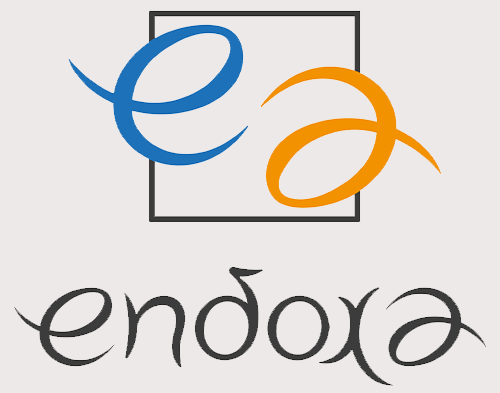L’ERRORE DI KAFKA
 PIER MARRONE
PIER MARRONE
Il capolavoro di Kafka, Il processo, come tutte le grandi opere, non sopporta di essere ridotto a una sola interpretazione. C’è chi lo ha interpretato come un romanzo esistenzialista, il quale, come alcune filosofie, enfatizza l’assurdità della vita umana, ossia l’assenza di qualsiasi significato razionale nelle nostre vicende, sempre in balia dell’irruzione di qualcosa di incomprensibile e mostruoso. C’è chi lo ha intepretato come una commedia, confortato anche dall’aneddoto di Max Brod che ricordava come tutti i suoi amici ridessero copiosamente quando Kafka ne lesse loro il primo capitolo. Però forse tutto dipendeva dal tono della sua voce, dall’enfasi e dalle pause, poiché un bravo commediante sarebbe forse capace di volgere in farsa anche l’Apocalisse oppure Il discorso sul metodo di Descartes. C’è stato anche chi lo ha interpretato in chiave mistica, dal momento che il finale sanguinario ricorda molto da vicino un sacrificio religioso. Sono tutte interpretazioni, queste e anche altre, che possono avanzare delle ragioni, anche se forse non tutte stanno sullo stesso piano di un’accessibile credibilità e, inoltre, non è affatto detto che si tratti di letture dell’opera necessariamente in competizione tra di loro.
Eppure, secondo me, lettore non raffinato e del tutto episodico di Kafka e di letteratura, e per lo più incapace di rintracciarne con precisione i presupposti e le influenze artistiche, c’è un’interpretazione naturale di questo testo, che mi pare sia la prima a imporsi a una prima lettura, che non è affatto detto debba essere necessariamente la più superficiale. Si tratta, molto semplicemente di quella lettura che vede la contrapposizione tra il mondo e l’esistenza di un individuo e una struttura burocratica che risponde solo alle procedure e non prende invece in considerazione quanto il protagonista K. realmente è, al di fuori e prima delle procedure che governano in maniera anonima le nostre vite nelle società complesse. Una burocrazia che contribuisce a rendere del tutto incerta la posizione che l’individuo occupa nel mondo delle relazioni umane.
Questo deve essere stato un sentimento che ha occupato la mente di Kafka a più riprese. Ad esempio, in una nota del 1907, ben prima di iniziare a lavorare al suo capolavoro postumo, Kafka scriveva “Mi trovo sulla piattaforma di una vettura e mi sento profondamente incerto rispetto alla posizione che occupo in questo mondo, nella città, nella mia famiglia. Neanche incidentalmente saprei dire quali esigenze potrei avanzare con ragione in un qualsiasi senso.” E quando parla della sua posizione intende precisamente quella posizione spaziale che sta occupando in quel preciso istante. Kafka è semplicemente un passeggero senza giustificazione, incapace anche di quella volontà di potenza che piaceva a Nietzsche e che consiste nell’assumere titanicamente l’assenza di qualsiasi giusitificazione dell’esistenza come un vero e proprio valore, che deve essere il fondamento per la costruzione di nuovi valori. Però questo fondamento, va da sé, è del tutto infondato e qualsiasi costruzione che lo avrà come base non potrà che essere egualmente incerto. La conseguenza probabile di questa assunzione volontaristica del valore come privo di qualsiasi fondamento, che ha il nome di nichilismo, non è affatto detto che sia il bambino che gioca con il mondo al modo dei bambini che sperimentano sulla spiaggia costruzioni effimere di sabbia, come Nietzsche sperava, ma sia invece il regno e l’incubo della violenza, dove ognuno cerca di prevalere a partire dalla sua costruzione di significati e di valori.
Una soluzione, quella di Nietzsche, estranea e inaccettabile per Kakfa, che rimase intrappolato, come altri intellettuali, in questa paralisi di fronte a tutti i sistemi che sovrastano l’individuo. Eppure questi sistemi non erano ovviamente sperimentati per la prima volta nell’epoca nella quale Kafka visse. Piuttosto, si può invece dire che ci sono sempre stati, almeno laddove c’è una forma di potere politico, per quanto embrionale. Secondo la teorizzazione dell’ordine tripartito resa famosa da Geroges Dumézil, ad esempio, le società indoeuropee condividevano una medesima struttura sociale divisa tra coloro che lavoravano, coloro che si occupavano delle relazioni con il divino, coloro che combattevano. Si tratta di un controesempio calzante, per dire che in fondo quanto sperimentava il giovane Kafka non era affatto qualcosa di ignoto? Probabilmente no o non almeno sino in fondo, poiché nelle società tradizionali, ossia in quelle società che pretendevano di discendere il proprio ordinamento da una struttura cosmica, era forse molto difficile sperimentare quella solitudine che in Kafka non è altro che la mancanza di significato. Ossia: nelle società tradizionali uno poteva anche non essere contento di stare dove si trovava, ma esisteva un significato condiviso da tutti, anche da lui o da lei, che giustificava il suo ruolo, per quanto umile potesse essere. In Kakfa, figlio compiuto dell’epoca moderna, questo ovviamente non può esserci.
Nemmeno la stuttura del diritto ci fornisce una ragione per quanto facciamo e per quello che siamo. In un brevissimo scritto del 1914 titolato Davanti alla legge questo appare in maniera chiara. Un uomo tenta di entrare attraverso il cancello della legge custodito da un guardiano, ma l’ingresso gli è ripetutamente interdetto per tutta la vita. Sembra anche che sia lui solo a voler varcare quel cancello. Prima di morire rivolge al guardiano un’ultima domanda: “Tutti tendono verso la legge, come mai in tutti questi anni nessun altro ha chiesto di entrare?”. Nessun altro ha chiesto di entrare perché quell’ingresso è destinato solo a lui e si chiuderà per sempre con la sua morte, così risponde il guardiano. Ossia: ognuno ha i suoi propri motivi per ritenere che la legge, ossia il diritto positivo, quello scritto nei codici, abbia valore. La sua opinione rispecchia, quindi, la sua solitudine, ma questa solitudine è anche l’accesso impossibile alla legge e la mancanca di fondamento del diritto, che è pura convenzione, inaccessibile nelle sue ragioni. È una solitudine che si esprime nella struttura de Il processo, sin dal suo incipit: “Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. poiché senza che avesse fatto alcunché di male una mattina venne arrestato.” Questo genera immediatamente un’emozione di solidarietà nel lettore, perché si immagina che tutto il seguito del romanzo, come in effetti accade, altro non è che un addentrarsi in un incubo privo di trama. Non che Josef K., naturalmente, non tenti di trovarci un significato. Josef K. è come noi, che vogliamo sempre trovare un significato nelle cose che ci accadono, soprattutto in quelle tragiche che rischiano di annichilirci. Ma i suoi tentativi non possono che essere patetici.
Durante il primo interrogatorio, al quale viene convocato senza che gli venga indicata né l’ora né il luogo, si prefigura il fatto che sia tutto frutto di un equivoco, poiché a Josef K., che di mestiere fa il primo procuratore di una banca, viene chiesto se esercita la professione di pittore. Questa sciatteria “è significativa del modo in cui si procede contro di me. Lei può obiettare che questo non è affatto un procedimento, e ha perfettamente ragione, perché è un procedimento solo se lo riconosco per tale”. Josef K. avrà modo di ricredersi rapidamente e comprenderà che la sciatteria non è affatto qualcosa che possa volgere a suo favore, poiché quello che è insondabile e incomprensibile ai suoi occhi non lo è agli occhi di chi ha istituito il processo del quale Josef K. è letteralmente la vittima sacrificale.
Il problema che vorrei porre però non riguarda un’analisi letteraria di questo capolavoro. Non è il mio mestiere e non credo di avere delle cose anche minimamente interessanti da dire. Piuttosto vorrei porre un’altra questione. Ossia: Kafka aveva ragione a coltivare questo sguardo così pessimista e terrificante nei confronti della burocrazia? Non è una domanda priva di senso, almeno tanto quanto un’opera d’arte ambisce elevarci a uno sguardo universale o forse anche solo a una visione generale. Questa prospettiva, universale o generale che sia, è fondata? È giusto avere un pregiudizio preventivo verso la burocrazia? Perché mi pare che si tratti soprattutto di questo che Kafka ci illustra. Certo: si può dire che quello che in realtà è il bersaglio di Kafka è più in generale l’apparato dello stato, il dispositivo potenzialmente sempre repressivo dello stato nei confronti dell’individuo inerme di fronte a una potenza immensamente superiore alla sua, che è talmente superiore da non avere nemmeno bisogno di giustificare la sua azione repressiva, indirizzata verso una colpa incomprensibile a Josef K. così come a tutti noi. Ma secondo me, se questo elemento con ogni probabilità non è assente, non è quello principale. Attori politici all’interno dell’opera non ci sono. Ci sono freddi burocrati, freddi esecutori, ma non ci sono politici. Non c’è nessuna passione riconducibile alla lotta politica. Delle idee politiche di Josef K. non si parla mai e di nulla si viene a conoscenza.
Che l’idea di stato non sia al cuore de Il processo mi pare confermata dal fatto che Kafka non poteva non sapere che le forme di esercizio del potere possono essere molto diverse e non si tratta di differenze irrilevanti. Non si può ragionevolmente sostenere che il potere è tutto eguale dappertutto, che una dittatura è equivalente a una democrazia liberale, che uno stato teocratico sia sullo stesso livello di uno stato che garantisce la libertà religiosa, anche se è vero che la burocrazia può avere comportamenti che sfuggono alla comprensione del singolo o che sono assurdi e inefficienti. Ma quale è l’alternativa? Perché alla fine, se siamo sovrastati dal capolavoro di Kafka, dovremmo anche riuscire a capire per quale motivo questa vicenda ci pietrifichi e ci faccia pensare che tutti potremmo esserne i protagonisti. E poi: a chi di non è capitato di essere dentro a processi burocratici che hanno alimentato il nostro fastidio, con tutta l’inerzia della burocrazia che incombe su di noi e che ci impedisce di dedicarci alle cose che realmente ci importano, costringendoci a compilare moduli, a telefonare a uffici che spesso non rispondono, a utilizzare password, spid, riconoscimenti biometrici? Ma, lo ripeto, quale è l’alternativa?
La burocrazia spersonalizza, enfatizza i processi e le caratteristiche oggettive e non quello che una persona è, che non può certo essere ridotto alla sua data di nascita, al suo sesso, al suo titolo di studio. Tuttavia, se non ci fosse questa spersonalizzazione dei processi decisionali, noi ci troveremmo di fronte a incubi ancora peggiori di quello descritto magistralmente da Kafka. Pensate a un concorso per insegnare nelle scuole superiori, dove non contasse il titolo di studio, che dovrebbe garantire un livello minimo accettabile delle conoscenze necessarie per cercare di trasmettere dei saperi alle generazioni più giovani, ma contasse invece la fedeltà politica a un capo, oppure la professione di fede verso qualche religione, dove, cioè, contassero non le tue competenze, ma la tua vicinanza personale a un partito politico o a una fede, oppure la tua appartenenza a un gruppo etnico. In questi casi i processi di selezione sono indifferenti o poco attenti alle tue capacità, ma molto attenti alle tue fedeltà. Tutto questo verrebbe intensificato se la burocrazia non esistesse.
La burocrazia tende all’anonimato, è vero, ma questo anonimato che predilige i processi e non i nomi propri è il presupposto, necessario sebbene non sufficiente, dell’imparzialità. Riempire i processi burocratici di nomi propri è il viatico dell’abuso. Ma ancora peggio è distruggere gli apparati burocratici. E questo lo possiamo dire sulla base dell’evidenza storica. Uno dei presupposti dell’Olocausto nazista è stato la distruzione degli apparati statali e burocratici, che hanno tolto qualsiasi protezione residua agli ebrei e ad altri gruppi, come è stato messo in luce dalle indagini di Timothy Snyder. E questo è il motivo per il quale l’Olocausto ha avuto luogo nell’Est europeo. Gli ebrei che vivevano nella Germania nazista, per quanto paradossale possa sembrarlo, potevano godere di tutele, grazie all’esistenza degli apparati burocratici che nella Polonia e nell’Ucraina invase non esistevano, poiché la struttura burocratica era stata intenzionalmente fatta collassare dai nazisti. La burocrazia tedesca non fu in grado di assassinare gli ebrei in Germania, poiché i burocrati non ricevettero mai chiare istruzioni sulle procedure per discriminare chi tra i cittadini tedeschi dovesse essere considerato ebreo. Nel 1942 alla conferenza di Wannsee che doveva occuparsi della “soluzione finale della questione ebraica” la questione pare venisse ampiamente discussa, senza una soluzione definitiva, se non quella di separare il sangue ebreo dal flusso sanguigno ariano. Questo obiettivo finale sarebbe stato possibile a realizzarsi solo quando nei territori invasi in vista della colonizzazione tedesca fosse stata distrutta la struttura statale e burocratica. Con poche eccezioni gli ebrei tedeschi non vennero uccisi in Germania, bensì deportati in zone prive di strutture burocratiche e assassinati lì.
È, invece, rassicurante narrare lo sterminio degli ebrei in Europa come il trionfo della meccanizzazione dell’assassinio, come trionfo della burocrazia o, addirittura, come compimento della razionalità illuministica. È rassicurante perché fa ricadere la responsabilità di atti tremendi su forze più grandi delle persone, mentre lo sterminio degli ebrei in Europa non fu affatto l’esito di dinamiche impersonali, come quelle burocratiche. Anche negli stati europei invasi dai nazisti le possibilità di sopravvivere per gli ebrei erano sempre legate alla persistenza delle stuttura statale che garantiva la cittadinanza e conservava la burocrazia. Dove non esiste lo stato non esiste nessun cittadino e non esiste nessuna protezione impersonale, per quanto labile. Oltre che lo sterminio degli ebrei, gli omicidi di massa di bielorussi, polacchi e zingari avvennero prevalentemente nelle zone dove lo stato era stato dissolto.
Questi esempi e queste evidenze storiche, alle quali si potrebbero aggiungerne altre, suggeriscono che dovremmo stare molto attenti prima di condannare la burocrazia come un male in sé, come a mio modo di vedere suggerisce Kafka. E naturalmente non sarebbe onesto da parte mia dire che non ho utilizzato degli esempi estremi. Tuttavia, gli esempi estremi hanno talvolta il pregio di chiarire i termini della questione. Voglio perciò concludere con un altro esempio che mi sembra aderente alla posizione che ho sostenuto – che è meglio che la burocrazia ci sia –.
Tempo fa mi era capitato di assistere a un’accesa discussione tra colleghi, professori di filosofia. Le discussioni tra filosofi in Italia raramente hanno per oggetto le idee, i metodi della propria ricerca, il confronto tra posizioni che contrappongono visioni differenti dell’esistenza. L’oggetto principale è invece l’occupazione di posti nei dipartimenti e la possibilità di influenzare l’esito delle procedure di selezione del personale docente per assicurarsi quote di un potere miserabile. Riassumo brevemente l’oggetto del contendere di quella discussione per quello che sono riuscito a capirne. Vi era in un dipartimento di non so quale università la possibilità di assicurarsi la presenza di uno studioso giovane e molto brillante, che era una presenza accreditata sulle più importanti riviste internazionali del suo settore, che insegnava in quel momento all’estero, ma che aveva manifestato la sua disponibilità a rientrare in Italia. Sembrava che sul suo nome, privo di qualsiasi sponsor all’interno del dipartimento che avrebbe potuto offrirgli un posto di lavoro, ci fosse un accordo generale. Invece no. Un collega improvvisamente segnalò il nome di un’altra studiosa, secondo lui enormemente più qualificata, che avrebbe dovuto occupare quella posizione. Naturalmente, quando si tratta di pesare e confrontare i curricula degli studiosi in competizione per una risora scarsa, quale è un lavoro retribuito generosamente, si entra in un terreno insidioso e forse poco solido. La ragione dell’insidiosità è che il confronto è di natura qualitativo e non quantitativo. Forse anche per questo motivo, il legislatore aveva introdotto delle condizioni per accedere alla possibilità di rientrare in Italia per studiosi operanti all’estero. Una di queste era occupare una posizione analoga a quella che si sarebbe occupata in Italia. E il ministero, diligentemente, aveva prodotto una tabella di equivalenza tra le posizioni nelle università estere e quelle analoghe nelle università italiane. Ne risultò che la studiosa non possedeva le qualifiche necessarie e quindi non poteva essere chiamata a lavorare in Italia. Un collega coinvolto nella discussione insorse veementemente proclamando che “noi non siamo dei burocrati!”, e che il dipartimento coinvolto avrebbe dovuto decidere in una situazione ideale sulla base del confronto qualitativo tra i due candidati, cosa resa impossibile dalla legge, ma che sarebbe stata possibile se, anziché la legge, a governare fosse stato l’arbitrio individuale, la fedeltà personale, le preferenze individuali, contro i cui abusi non c’è difesa se non quella degli apparati della legge e della loro espressione burocratica.
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA Endoxa Maggio 2024 Kafkiana Pier Marrone