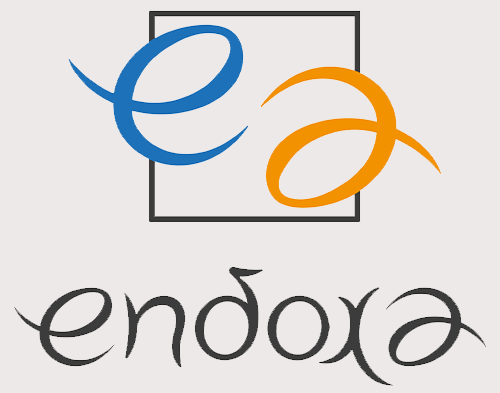KAFKA E CIÒ CHE NON ARRIVA
 JUAN PABLO PINO POSADA
JUAN PABLO PINO POSADA
Uno dei passaggi più citati di Kafka, se non il più, è quello in cui parla a un compagno di scuola del tipo di libri che si dovrebbero leggere. Non quelli, dice il ventenne Kafka, che danno la felicità, ma piuttosto quelli che ci svegliano “con un pugno nel cranio” e lavorano su di noi “come una disgrazia che ci fa troppo male, come la morte di qualcuno che abbiamo amato più di noi stessi, come se fossimo gettati in giungle lontane da ogni essere umano, come un suicidio”. E sentenzia: “un libro deve essere l’ascia per il mare ghiacciato dentro di noi”.
Che il giovane Kafka prediliga un’esperienza di lettura in cui l’esposizione a ciò che si legge comporti un tale contatto è quantomeno interessante alla luce dei motivi – presenti in tutti i registri della sua produzione scritta – dell’incontro mancato e della comunicazione impossibile. Kafka non solo dice di diffidare delle lettere e delle parole, di scrivere in modo diverso da come parla, di parlare in modo diverso da come deve pensare “e così via fino alla più profonda oscurità”, ma costruisce un intero universo immaginativo di frammenti, racconti e romanzi intorno alla mancanza di risposta, all’accesso negato e alle distanze insormontabili.
Come comprendere, nel contesto di questa poetica di ciò che non arriva, il ruolo che corrisponde al lettore dell’opera di Kafka, e se l’immediatezza del colpo e la concentrazione della scure coincidono con la moltiplicazione kafkiana delle mediazioni, con “l’infinito rinvio”, come lo chiama Borges? Anche se dubito fortemente che si possano trovare delle risposte, mi sembra una domanda legittima chiedersi se i lividi e le crepe non debbano essere le tracce di lettura che l’autore ceco ha immaginato per i suoi lettori.
L’espressione “poetica del non-arrivo” è stata coniata da Judith Butler in un necessario saggio sul processo che – al momento in cui Butler scrive – si stava svolgendo a Tel Aviv per la custodia di alcune scatole di carte postume di Kafka. Contro le pretese nazionalistiche dello Stato di Israele di trasformare Kafka in un bene culturale sionista e contro le pretese altrettanto nazionalistiche dell’Archivio della letteratura tedesca di Marbach di integrare l’eredità di Kafka nella tradizione della letteratura (ben) scritta in lingua tedesca, Butler dimostra che Kafka nella sua opera smonta l’idea di un luogo e di un tempo di arrivo scrivendo del perpetuo non-arrivo, dell’irrealizzabilità di qualsiasi obiettivo e, allo stesso modo, dell’impossibilità di qualsiasi messaggio.
Questa negatività è ciò che la filosofa ebreo-americana definisce la poetica di ciò che non arriva. Le scatole, in ogni caso, sono arrivate, dal momento che, come è già noto, dopo aver ottenuto la custodia nel 2016, la Biblioteca Nazionale di Israele è diventata il deposito legale delle carte di Kafka. Infatti, parte del materiale è accessibile online per tutto il pianeta, compresa – ironicamente archivistica – la lettera stessa in cui Kafka chiede a Max Brod di distruggere tutti i manoscritti, senza eccezioni e senza che vengano letti prima da nessuno.
Quando si leggono le pagine kafkiane alla ricerca di indizi per il processo di lettura, di solito si trovano situazioni in cui ogni testo dà luogo a una miriade di possibilità interpretative, cosicché l’esercizio dell’interpretazione tende a diventare inutile, a metà tra il risibile e il doloroso. Il dialogo tra Josef K e il prete, quando quest’ultimo racconta la leggenda “Prima della legge”, ne è un buon esempio. “Il silenzio delle sirene” è un altro. I testi possono avere molti significati, oppure sono sconosciuti o dicono sempre la stessa cosa, come i quadri ripetuti di Tintorelli ne Il processo. In questo senso, è possibile parlare anche di un’estetica di ciò che non arriva, intendendo inizialmente con questa formula la presenza nella diegesi dell’impossibilità per i personaggi di arrivare a un significato stabile di ciò che leggono o interpretano.
Questa estetica, tuttavia, va oltre il piano diegetico e si estende ampiamente nell’ambito della ricezione empirica dell’opera di Kafka, come dimostra l’immensa biblioteca di interpretazioni a cui hanno dato luogo sia ciò che l’autore ha portato alla luce sia ciò che ha voluto nascondere. È difficile trovare un grande intellettuale europeo della seconda metà del XX secolo che non abbia scritto qualcosa su Kafka. Ma il gioco delle molteplici interpretazioni, nel suo insieme, assomiglia molto a esercizi intellettuali disincarnati e disaffezionati che non ricordano affatto la grande “disgrazia” o il “suicidio” a cui Kafka un tempo associava l’incontro con i libri.
Permetteteci di inquadrare la questione dell’esperienza di lettura kafkiana sulla base di quanto accade con Rayuela, il romanzo dello scrittore argentino Julio Cortázar. In una lettera del 1965, Cortázar afferma: “Penso che K. non abbia avuto quasi nessuna influenza su di me; lo rispetto ma non ho nessun affetto per lui, a volte lo sento quasi disumano”. Cortázar cerca sempre il contatto umano con il lettore, cioè, nel suo linguaggio, l’abbraccio commovente o il colpo rabbioso. Ciò che colpisce è che in Rayuela – un collage in cui fantastica sulla complicità di chi legge – assistiamo alla storia del progressivo isolamento e allontanamento di Horacio Oliveira, archetipo di un cinismo freddo, sterile e velenoso. Cortázar cerca di colmare il divario tra la freddezza rappresentata e la comunicazione perseguita tra scrittore e lettore – “non ci sono messaggi, ci sono messaggeri”, dice Morelli – chiedendo a chi prende in mano il libro di de-automatizzare la lettura lineare e di procedere invece a zig zag attraverso le diverse parti del libro. Per tutto il tempo il lettore deve essere consapevole del suo atto di lettura, cioè Cortázar cerca un contatto umano attraverso l’attivazione psicosomatica del fatto che ha a che fare con un artefatto materiale contorto. Non è facile dire quanto questa strategia sia efficace, dato che in molti casi i lettori riferiscono disconnessione e difficoltà di immersione. È comunque la strategia di Cortázar, ma qual è quella di Kafka?
Mi sembra che quella di Kafka sia soprattutto una grande domanda, una domanda la cui risposta è ciò che non arriva. Se si deve immaginare uno spazio intermedio tra il pugno e il rinvio, forse si può immaginare un’estensione che si apre con la domanda e in cui i punti interrogativi continuano ad allungarsi, anche cento anni dopo, anche, a mo’ di esortazione, per una nuova e sconfortante epoca di tribù e territori. Kafka stesso disse a Gustav Janouch: “Non c’è bisogno di scusarsi. L’uomo legge per porre domande”.
ENDOXA - BIMESTRALE LETTERATURA Endoxa Maggio 2024 JUAN PABLO PINO POSADA Kafkiana