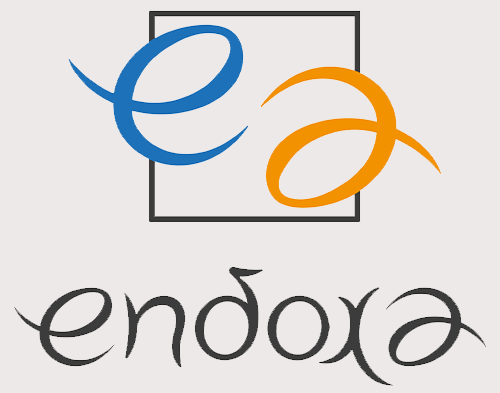KAFKIANA – EDITORIALE
 ERNESTO C. SFERRAZZA PAPA
ERNESTO C. SFERRAZZA PAPA
1924-2024. Il centenario della morte di Kafka non giustifica la proliferazione di contributi su di lui. Di una simile giustificazione non c’è affatto bisogno. Insieme a Dostoevskij, di cui è stato uno dei migliori esecutori testamentari, Kafka è l’autore su cui maggiormente si è esercitata la tradizione filosofica novecentesca, che da ogni parte ha provato a tirarlo per estorcergli una verità che persevera nel rimanere celata. Aveva ragione Adorno nei suoi appunti quando sosteneva che le frasi di Kafka pretendono un’interpretazione e allo stesso tempo la rendono impossibile. Kafka non si limita a essere uno scrittore non sistematico – nonostante la ricorrenza di “motivi” che percorrono la sua opera, come aveva visto bene Benjamin. Tantomeno la difficoltà consiste nell’incompiutezza, che anzi apre la strada a una interpretazione la cui facilità è sospetta. Kafka ci consegna una serratura la cui chiave non è mai stata costruita. Di fronte ai suoi aforismi, alle improvvise inversioni a U dei suoi racconti, ci ritroviamo come chi intuisce di dover capire qualcosa, e che forse ne va della sua stessa vita, ma non riesce afferrare alcunché. Lo si è scritto fino alla nausea, come a voler sublimare lo sconquasso che Kafka induce: leggerlo rende ansiogeni, claustrofobici, spaesati. Ma forse una sensazione poco considerata che la lettura di Kafka provoca è quella della stupidità, se la stupidità è anzitutto l’incapacità di porre la domanda corretta, la domanda che potrebbe salvare. Non sono dopotutto frustrate tutte le domande in Kafka? I personaggi kafkiani, dal disgraziato contadino dell’infinitamente interpretata parabola Davanti alla legge all’agrimensore K., fino all’eroe tragicomico Joseph del Processo, non cessano mai di porre le domande sbagliate, e per questo sono condannati. Ma da questa condizione per Kafka non è possibile uscire, proprio come il cacciatore Gracco non può morire. E nondimeno, la scrittura di Kafka non è disperata. La speranza c’è, infinita, ma non per noi, sempre per altri, come ricorda Max Brod nella biografia dell’amico. A dominare in Kafka è l’aporia non risolvibile, che se fosse risolta smetterebbe di essere tale. Il nichilismo kafkiano non si traduce in una difficoltà interpretativa, ma è critica immanente del mondo sociale così com’è. Una scrittura riconciliata con il senso rischia di riconciliarsi con il mondo: Kafka non lo avrebbe permesso. Per questo motivo le interpretazioni metaforiche della sua opera rischiano di risolversi in manierismi, esercizi di stile senza mordente, perché vogliono a ogni costo penetrare un’opera che reclama di rimanere non pienamente comprensibile. Ciò che è possibile fare è sperimentare in modo da cogliere le contraddizioni determinate che di volta in volta il mondo offre. Proprio perché canzona come ridicola ogni interpretazione definitiva, Kafka concede una infinità di sperimentazioni: da qui la legittimità della panoplia di letture tentate, tutte manchevoli e allo stesso tempo tutte necessarie. Questo numero di Endoxa va considerato come un brano di questa lotta interpretativa. Buona lettura.