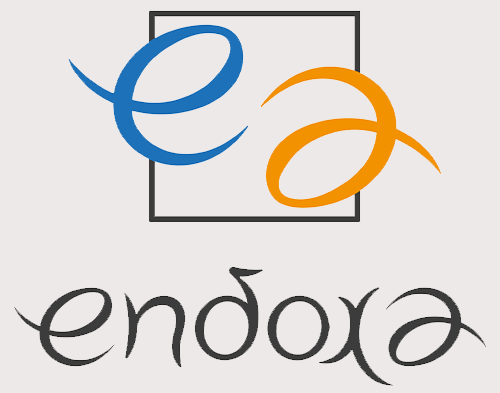LETTURE KAFKIANE
 VICENTE JAIME RAMÍREZ GIRALDO
VICENTE JAIME RAMÍREZ GIRALDO
1. Ogni opera, ogni autore che ha la capacità di interrogare e sfidare un lettore, aggiorna ancora una volta la questione delle condizioni e delle possibilità di lettura. La lotta per la comprensione non si vince solo confidando nella laboriosità ermeneutica. La sfida alla comprensibilità dell’opera è come un’atmosfera che, dal testo, si espande fino a comprendere sia il lettore presente sia l’autore assente. Sorgono nuove domande che, più che ostacoli, sono modi di consegnare il senso. Più che difficoltà, sono domande che illuminano la comunicazione che sta avvenendo. La problematizzazione della lettura – da quella filosofica a quella strettamente letteraria – è una delle conseguenze della vera filosofia, della vera letteratura: fa nascere nei lettori una strana inquietudine per l’improbabilità di ciò che stanno facendo. L’evidenza dell’attività – la semplice lettura – comincia a dissiparsi e, nella recente chiarezza, si manifestano nuovi e intensi problemi. Una di queste nuove difficoltà è che il lettore prende coscienza di sé: l’azione che sembrava atemporale diventa storica, il suo universalismo si attualizza e si trasforma in realtà propria. Un caso esemplare – non l’unico – di questa esperienza di lettura è quello che può accadere e accade con Kafka. È lo spettro di un autore che arriva, con falsa familiarità, in luoghi davvero remoti e strani, e che, grazie a cliché e pregiudizi, sembra essere accolto nell’intimità e nell’immediatezza della comprensione. Il vero Kafka assomiglia al suo spettro: incarna la letteratura, la vocazione letteraria, la volontà di conoscere. La popolarità di Kafka, come la semplicità di una parabola, può essere la chiave della sua cifra, fino a un certo punto. La sua opera, in un generoso vagabondaggio, giunge, a un certo punto, all’attenzione ignara di un lettore casuale: qualcosa è accaduto. Il lettore vede se stesso, perplesso. Alla fine, incredulo, vulnerabile, stupito, si chiede, si interroga, chiede agli altri. Può tornare, deciso, a rileggere, a verificare la meraviglia.
Alle domande iniziali del lettore se ne aggiungono altre, e la perseveranza diventa ironica devozione: c’è un significato reale, oggettivo, nelle storie kafkiane? Quale essenza può rimanere attraverso le trasmutazioni della distanza culturale, della storia, delle traduzioni? Quale conoscenza dell’autore ci permette di illuminare, entro i limiti della ragione, le sue scene enigmatiche? Come viene modificato il testo dal contatto con il lettore? Come viene trasformato ciò che viene letto dai cambiamenti del lettore stesso? Alla distanza secolare dell’esistenza di Kafka, come ci si rapporta all’accumulo di opinioni ermeneutiche, all’accumulo di critica storica e di raffinatezza filologica? Inoltre, come influisce sulla propria realtà questo evento di lettura sempre più sfuggente? In particolare, per un lettore latinoamericano, come si inscrive il suo compito o la sua avventura all’interno di una tradizione di lettura, nella costruzione culturale idiosincratica del suo modo di leggere? Vale la pena, superando lo sconforto per l’improbabilità del progetto, di soffermarsi preliminarmente su alcune delle domande poste.
2. Uno degli elementi che determinano la visione generale di un autore e di un’opera è la tradizione di lettura in cui è stata letta. Non si tratta solo di scuole o orientamenti interpretativi – che sono rilevanti ed espliciti – ma di un atteggiamento tacitamente e decisamente consolidato. Ci sono già generazioni di lettori latinoamericani – certamente non le uniche – per i quali Borges è stato arbitro e maestro, guida generosa e definitiva. È stato al tempo stesso didascalico e censore, i cui giudizi erano tanto illuminanti quanto inappellabili. Kafka non fece eccezione al suo magistero. L’importanza di Borges – come scrittore, traduttore, divulgatore, intellettuale – non può essere esagerata nel modo di essere di un intellettuale latinoamericano e nel modo di rapportarsi alla tradizione dei paesi centrali della tradizione europea – soprattutto alla filosofia – e di altre culture. Kafka è uno dei tanti scrittori segnati da una modalità di appropriazione, di delucidazione e di generalizzazione, cioè da una lettura borgiana. Inutile dire che molti aspetti di quella lettura non solo anticipano una ricezione più equa – in termini filologici e critici – ma rimangono intrinsecamente preziosi. Che tipo di lettura era? Quella di essere aperti al merito dell’artificio, della favola terribile e perfetta, ma di sospendere ogni interpretazione al di là del piacere letterario. Fin dal suo primo scritto del 1935, Incubi e Franz Kafka, in cui il filo conduttore brillantemente seguito è quello dei sogni, il verdetto è il dovere di evitare ogni comprensione allegorica: “leggiamolo con disinteresse, con puro godimento tragico”. Nel 1937 avverte che “in Germania abbondano le interpretazioni teologiche della sua opera”, giudicate – equanimemente – né ingiuste né necessarie. Ma è nel 1951, nell’intenso e importante Kafka e i suoi predecessori, che viene presentata nella sua forma più pura una lucida e audace strategia di comprensione e integrazione: “Il fatto è che ogni scrittore crea i suoi precursori”; in altre parole, viene ricostruita una discendenza che rende l’autore profeta di “miti oscuri e istituzioni atroci”. Infine, in uno dei suoi prologhi sintetici e decisivi – un prologo, una citazione di Borges fissa il destino di una lettura – che ha dato unità e presentazione al progetto editoriale “Biblioteca Personal”, ribadisce a proposito di Kafka: “Ha scritto sordidi incubi in uno stile limpido”. Non si tratta, in nessun caso, di una negazione degli aspetti rivelati nell’opera di Borges. Si tratta piuttosto della necessità di riconoscere l’impotenza di una forma di lettore nell’aprirsi ad altre sfide della lettura, che non possono essere racchiuse nel confine strettamente letterario e ludico – una caratteristica essenziale della nostra umanità. Sebbene esistano altri sensi generali della lettura, al di là della ricerca sulla sua vita e sulla sua opera, la valutazione e i contributi di Borges sono ancora validi. Borges perseverava in una lettura attenta, seguiva le incipienti vicissitudini editoriali e le nuove traduzioni in diverse lingue, traduceva lui stesso opere molto importanti; tutto questo è innegabile. Ma in un certo senso ha limitato, in nome della letteratura, le possibilità di interpretazione, contribuendo al contempo a renderla più veritiera. Basterebbe citare un esempio e alcune delle sue conseguenze. Quando nel 1938 traduce e pubblica, tra le altre opere, Die Verwandlung – che sarà conosciuto, al di fuori del tedesco, con gli equivalenti di metamorfosi di origine e significato greci – e propone di tradurlo in spagnolo come La transformación, dimostra non solo saggezza ma anche una maggiore penetrazione nel cogliere il significato dell’opera (era stata l’inerzia degli editori a imporre di continuare a usare un titolo già diventato familiare). Questa sensibilità linguistica invalida da sola gli sviluppi interpretativi che si basano sulla genealogia classica delle metamorfosi, anche solo per contrapporla a quella raccontata da Kafka. L’evento narrato non è un passaggio da una forma a un’altra che può essere anticipato; infatti, il “mostruoso insetto” non può essere rappresentato – Kafka è stato attento a evitarlo; non c’è un itinerario concepibile del possibile cambiamento. È come un convertito religioso che non riesce a spiegare l’inconcepibile anatomia delle sue nuove convinzioni. Come nella scelta di una parola poetica, l’errore impedisce l’incarnazione di un’idea essenziale.
3. È affascinante notare che, in questo momento, Kafka è ancora un autore del futuro. La sua opera è una costellazione continua di problemi che richiedono attenzione. Oltre alle ricerche europee, approfondite e metodiche in loco, condotte in nome della scienza della letteratura, della sociologia storica o della storia culturale, ci sono quelle eccentriche che si svolgono non solo in altri confini disciplinari, ma anche in altri luoghi della geografia letteraria. I prodotti o i risultati originali faranno parte di un potenziale di appropriazione erudita – nel senso di ricostruzione documentaria e libresca di sfere e atmosfere estranee – da parte della periferia culturale e saranno input per il continuo dialogo sincronico degli studiosi, che sta diventando sempre più ubiquo e ininterrotto. Ma l’apparente universalità della conversazione non deve diluire l’identità dei partecipanti, né l’incipiente consapevolezza delle proprie genealogie. In altre parole, un compito in sospeso in America Latina non è solo quello di portare alla luce le ripercussioni di un modo di fare letteratura di risonanza esistenziale – senza isolarlo da una densa narrazione culturale e scientifica – ma di rendere possibili altre letture, nuovi orizzonti di esplorazione ermeneutica. In questo senso, la ricerca scientifica protocollare – si pensi alla trilogia biografica su Kafka pubblicata da R. Stach tra il 2002 e il 2014 – getta una luce inaspettata su una simbiosi tra esistenza e letteratura, ma ribadisce anche la vicinanza già intuita dalla chiaroveggenza del lettore puramente letterario. Le altre letture di Kafka, la consapevolezza di altri modi di essere lettori, hanno molte strade da esplorare. Non solo per ciò che ha significato per gli scrittori e per la loro forma privilegiata di conoscenza non istituzionale, cioè non universitaria, non “scientifica” – García Márquez ha affermato di dovere la propria libertà letteraria alla lettura di Kafka – ma per la trasformazione del lettore e per il tipo di contemplazione e penetrazione che la letteratura permette della realtà – e che le relazioni periferiche e marginali con la tradizione filosofica centrale non sono state in grado di offrire.
4. Una di queste strade, al di là del “mero godimento tragico” o della rivendicazione della fantasia, è lo spazio della comprensione religiosa – presente fin dall’inizio al crocevia dell’interpretazione di Kafka – nel senso esposto da Benjamin nel 1934: Kafka non va inteso come un fondatore di religioni, ma come religioso nella profonda attenzione che offre al mondo e alle sue creature. Decenni dopo Bloom (1994), con altri mezzi e in un altro contesto, è arrivato a decantare la frase secondo cui Kafka: “non era uno scrittore religioso, ma trasmutava la scrittura in religione”. L’appello a questa religiosità si scontra con una tradizione di lettura canonica, e saranno necessarie molte precisazioni per dissipare gli equivoci. Non si tratta della decifrazione di un simbolismo banale, ma di un atteggiamento che cambia molti significati della sua opera. Il profeta letterario, che ancora una volta mostra l’accesso alla legge – a un senso normativo del mondo – nella vocazione esistenziale della letteratura, fonda un nuovo spettacolo teatrale per la rivelazione, parabole per esprimere una metafisica. La messa in scena del mestiere letterario rende plausibile la religiosità dello scrittore. Dall’oggettivare il suo prodotto – la scrittura, das Schreiben – sotto forma di diario, racconto, epistola, all’accompagnarlo con il rito di un’interpretazione potenzialmente infinita – ne Il processo la sezione “Nella cattedrale”, ad esempio – come in un’opera esegetica o profetica. L’alternativa di una religiosità prosaica ci lascia, ancora una volta, sulla soglia della comprensione, ma recupera la contemplazione e l’attesa, rende più giustizia al silenzioso maestro della legge, rende più plausibile la liturgia in cui consiste tutta la lettura kafkiana.
ENDOXA - BIMESTRALE LETTERATURA Endoxa Maggio 2024 Kafkiana VICENTE JAIME RAMÍREZ GIRALDO