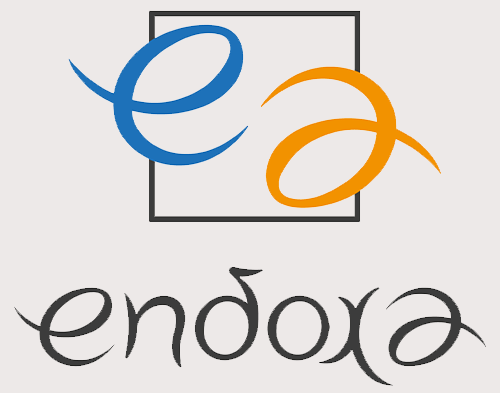SUL LINGUAGGIO DEI GESTI
FABIO CIARAMELLI


Partirò da un aneddoto che ha per protagonisti Ludwig Wittgenstein e Piero Sraffa. Il grande filosofo austriaco e l’altrettanto grande economista italiano insegnavano ambedue a Cambridge ed erano amici. Si racconta che un giorno, mentre discutevano della teoria raffigurativa del linguaggio elaborata dal cosiddetto “primo Wittgenstein”, teoria che postula un rigido isomorfismo fra linguaggio e mondo, Sraffa abbia posto un’obiezione decisiva, chiedendo all’amico di quale pezzo di mondo poteva mai essere la copia isomorfa quel famoso “gesto napoletano e siciliano” che consiste nel passarsi le dita di una mano sotto il mento per esprimere rifiuto, disaccordo e/o disinteresse.
L’aneddoto è interessante, perché proprio per rispondere a obiezioni di questo tipo, secondo cui tanto il linguaggio gestuale quanto quello verbale sono costituiti da espressioni che non hanno un significato univoco, incontrovertibile e pienamente formalizzabile, il cosiddetto “secondo Wittgenstein”, nella sua opera postuma intitolata Ricerche filosofiche (la cui Prefazione non a caso rende omaggio a Sraffa) ha elaborato la teoria dei giochi linguistici, spostando la sua attenzione verso l’analisi del linguaggio ordinario e dei suoi molteplici usi.
Facciamo un salto di alcuni decenni. Antonin Scalia, giudice ultraconservatore della Corte Suprema, nominatovi a suo tempo da Reagan, e morto negli ultimi mesi della presidenza Obama, si trovò un giorno, sugli scalini della Cattedrale di Boston, a rispondere con fastidio alle insistenti domande d’un giornalista che l’interrogava a bruciapelo all’uscita della messa. Ma invece di prendere la parola, la sua risposta fu proprio il gesto evocato da Sraffa nella sua conversazione con Wittgensetin. Il giornalista gli aveva chiesto: che cosa risponde a quelli che mettono in dubbio la sua imparzialità nei rapporti tra Stato e Chiesa? Per mostrare tutto il suo disappunto ma al tempo stesso per manifestare il suo disinteresse per questo tipo di quesiti, l’autorevole magistrato, nato da padre siciliano nel New Jersey, si lasciò scappare il gesto in questione, che i giornali americani definirono subito “osceno”. Per difendersi, Scalia ebbe un bel dire che si trattava soltanto d’un “gesto siciliano”. Il punto è che, nelle comunità italo-americane nel corso del tempo quel gesto aveva acquisito un significato più insultante e più volgare dell’originaria espressione del proprio menefreghismo. Per chiudere l’incidente ci volle perciò una precisazione ufficiale della portavoce della Corte Suprema.
Certamente il gesto di portare al viso il dorso della mano piegata, per poi stenderla verso l’alto, sfregandosi appena appena il mento con la punta delle dita, ha sicuramente una dimensione familiare e colloquiale, e perciò appare inadeguato come risposta d’un uomo pubblico alla domanda d’un giornalista. Napoletano o siciliano che sia, quel gesto non fa che confermare la propensione verso la mimica e una certa teatralità che costituiscono elementi ricorrenti nello stereotipo tradizionale del meridionale, che, quando parla, gesticola e s’accalora più di altri.
A ben vedere, però, il linguaggio dei gesti – come conferma l’obiezione di Sraffa a Wittgenstein – inevitabilmente accompagna, arricchisce e precede la comunicazione verbale. I meridionali – e in generale gli italiani – vi ricorreranno anche più spesso di altri, ma ciò non vuol dire affatto che ne abbiano l’esclusiva.
In realtà, nessun essere umano, pur volendolo e magari desiderandolo, riesce a parlare soltanto con le parole, reprimendo la dimensione gestuale in cui si radica il linguaggio, e nella quale vengono a galla il corpo, gli stati d’animo, le motivazioni profonde. Ma sarebbe altrettanto ingenuo e superficiale concludere che il linguaggio dei gesti, la loro forza espressiva, la loro capacità di non limitarsi a descrivere o a raffigurare la realtà esterna siano qualcosa di immediato e diretto, cioè di spontaneo e universale, in cui si travasa senza nessuno schermo il vissuto di ciascuno. Al contrario, come dimostra l’infortunio del giudice Scalia, il significato d’un gesto e quindi la sua interpretazione rimandano al contesto concreto in cui vi si ricorre. L’uso non trasforma soltanto il senso delle parole, ma anche quello dei gesti, la cui maggiore immediatezza non ne fa nulla di innato, cioè di naturale e immutabile. Il linguaggio dei gesti è dunque, a sua volta, socialmente condizionato, storicamente determinato e in perenne trasformazione. Eppure non è mai possibile metterlo del tutto a tacere. In qualunque lingua e a qualunque latitudine, prima che con le parole, gli esseri umani parlano col corpo.
Endoxa ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA STORIA DELLE IDEE Ciaramelli Endoxa maggio 2018 linguaggio wittgenstein