LA PAURA HA LA VISTA CORTA
LUIGI GUI

Uno dei tanti possibili volti della paura, visto da una prospettiva sociologica, è il volto spaventato e risentito di chi è rimasto spiazzato dal crollo delle aspettative di realizzazione di sé, dalla repentina disillusione di poter godere indisturbato dei propri beni, dalla negazione della promessa di benessere come affermazione della propria individuale autodeterminazione. Non è lo spavento allarmato di chi è investito da un evento improvviso e terrificante, è piuttosto una miscela tra smarrimento e timore che avvelena il presente, sentendo crescere la propria vulnerabilità verso il futuro, la percezione dell’imminente minaccia di perdere ciò che sino a poco fa pareva assicurato.
Osservato così, questo volto della paura appare un tratto diffuso nella popolazione della vecchia Europa, nei cittadini di quell’occidente industrializzato e finanziarizzato, e sembra ormai pervadere l’intero globo, con i suoi modelli di produzione e consumo.
Si coglie con diffusa evidenza, tra i cittadini degli Stati europei (e in senso lato di tutto il mondo Nord “occidentale”), l’emergere di manifestazioni di paura e protesta, di paura e chiusura, di paura e disaffezione partecipativa.
Per comprendere alcuni tratti di questo sentimento collettivo, è opportuno provare a ricapitolare, pur in breve e per sommi capi, alcuni elementi che hanno differenziato le premesse della paura nelle epoche pre-moderna, moderna e post-moderna, con riferimento alla doppia e intrecciata evoluzione tanto dei sistemi produttivi, sorretti dalla rivoluzione industriale nell’economia capitalista, quanto di quelli culturali e politici, grazie all’imporsi dell’illuminismo come approccio alla conoscenza e al progresso dell’uomo.
Il volto che cambia
Nelle società premoderne e preindustriali gli eventi che incombevano sulla sorte delle persone davano ai singoli poco scampo; da un lato i loro destini erano compresi e con-fusi con le vicende della condizione sociale cui appartenevano (con scarse possibilità di sottrarvisi), d’altro lato ciascuno era esposto ai rischi di malattia, distruzione e morte sui quali, individualmente, poteva incidere poco o nulla.
In tale contesto, l’orientamento esistenziale prevalente spostava l’attenzione dalla condizione presente a una prospettiva trascendente. “Se poco puoi fare contro una pestilenza o una carestia qui sulla terra – questo poteva essere il messaggio – molto puoi fare per guadagnare la felicità e, all’opposto, per evitare le pene nella vita ultraterrena”. Più della morte stessa, evento prossimo alla vita quotidiana, poteva spaventare ciò che incombe dopo la morte.
Nel corso degli ultimi tre secoli, però, l’Europa è stata percorsa e pervasa dall’età dei lumi. Gli uomini sembravano allora poter afferrare le briglia del loro sviluppo e imprimervi una traiettoria differente, finalmente a proprio immediato vantaggio. Non più succubi impotenti di forze superiori, ma, in maniera progressivamente crescente, conoscitori delle leggi che governano la natura e la società, dunque, potenzialmente e progressivamente padroni delle proprie condizioni di vita. Scienza e tecnologia, rigorosa razionalizzazione produttiva e istituzionale, prove tangibili della capacità di cambiare il mondo, mostravano a quegli uomini (più propriamente, all’élite economico-politica e culturale emergente) le loro chance di cambiare il proprio destino. In questa scena mutata, anche la paura cambiava natura, si specchiava nelle azioni e nelle possibilità umane. La paura dell’aggressione altrui poteva ridursi in proporzione inversa con il consolidarsi del potere di controllo normativo e repressivo degli Stati moderni; la paura delle carestie e della miseria poteva attenuarsi per l’accresciuta capacità dei sistemi industriali di sfruttare l’energia fossile e le correlate tecnologie di conversione, con esiti di produzione di beni inimmaginabili in ogni epoca precedente.
Il progresso tecnologico e l’economia capitalista annunciavano l’innalzamento continuo dello standard di qualità della vita, di consumi di beni materiali e immateriali; parallelamente, lo sviluppo dei nascenti sistemi istituzionali di welfare pianificavano la massima redistribuzione dei benefici del mondo che cambiava. Premessa e promessa dello sviluppo otto-novecentesco in Europa è stata, dunque, la fiducia in un crescente benessere per i popoli degli Stati europei. I cittadini dei paesi “progrediti” potevano liberarsi dalla paura di ogni carenza ed ergersi a modello per i popoli “arretrati” dei paesi “in via di sviluppo”.
La grande narrazione della modernità occidentale attenuava le paure individuali, dunque, promettendo sicurezza e salute già ora. Come è evidente, il fuoco dell’attenzione si era spostato dall’attesa di una felicità (e dalla paura di una dannazione) ultraterrena, alla soddisfazione di bisogni terreni: pance da riempire, corpi da vestire, malattie da sconfiggere, menti da formare, case più salubri da costruire, via via in una progressione crescente in quantità e qualità di beni per soddisfare sempre nuovi bisogni. Anche la paura, quindi, appariva come una realtà che il progresso avrebbe sconfitto, a favore di quella parte di uomini e di mondo (il Nord del globo) che si fossero ordinati (sub-ordinati) alle leggi del progresso industriale, garantiti da istituzioni statali capaci di farsene garanti. Il prezzo di questo processo di ri-strutturazione sociale verso un ordine moderno è stato, per intere masse di uomini e donne, molto alto: massificazione del lavoro, consistenti migrazioni verso le nuove concentrazioni industriali, degrado delle preferire urbane, demolizione dei tessuti comunitari tradizionali di reciproca protezione, scomposizione tayloristica dei processi di lavoro e dei tempi della vita quotidiana, accelerazione e pressione alienante dei ritmi di produzione e consumo; a fronte di ciò, tuttavia, l’allontanarsi dalla condizione di fame, malattia, alti tassi di mortalità infantile, bassa speranza di vita delle epoche precedenti, sono parsi vantaggi sufficienti a legittimare i sacrifici imposti.
L’attesa fiduciosa di benessere, materiale e sociale, e la proiezione si sé (della propria classe o della propria nazione) in un domani migliore, parevano funzionare da antidoti alle paure individuali.
Non si vuole in tal modo affermare che l’Ottocento e il Novecento non siano stati secoli privi di vicende terrificanti e di tragedie personali dominate dalla paura, ma nella percezione collettiva anche le paure di quel presente potevano essere reinterpretate come temporanei accidenti lungo un cammino che comunque sarebbe andato verso il loro superamento, se non per se stessi almeno per le generazioni a venire.
L’equilibrio sistemico poteva apparire garantito dalla seguente circolarità interattiva: crescente capacità di produzione industriale, consumo individuale massificato, elevazione per tutti delle condizioni di agio, politiche pubbliche per ridurre la divaricazione eccessiva delle condizioni di vita tra agiati e disagiati, a beneficio dei cittadini titolari di diritti entro i confini di ogni Stato nazionale. Il benessere, in quell’ottica redistributiva, si è riferito prevalentemente alle condizioni materiali ritenute oggettive e misurabili (condizioni di salute, lavoro, fruizione di beni, previdenza sociale). Le articolazioni dei sistemi di welfare hanno inteso l’obiettivo di equità redistributiva prevalentemente nella prospettiva del tendenziale livellamento ed estensione dell’accesso a risorse, prestazioni, consumi. Fino agli anni ‘80 del secolo scorso, le politiche socio-assistenziali e i sistemi organizzati d’intervento e protezione sociale, si sono articolati e complessificati nell’impegno di parametrare il disagio e le risposte per affrancarvisi (livelli di assistenza o soglie minime, indicatori economici equivalenti, nomenclature per la diagnosi, assegnazione di punteggi percentuali per misurare le capacità residue, etc.) secondo l’enfasi, non sempre tradotta in pratica, di una prospettiva universalistica: sicurezza per tutti, protezione da ogni rischio.
La meta annunciata a ciascun cittadino moderno è stata la realizzazione di sé, come singolo individuo, adottando i mezzi socialmente legittimati, resi accessibili dall’economia di mercato e normati dalle istituzioni pubbliche.
In questa modernità, la paura si affacciava nell’occasionale emergere del rischio di non poter far fronte agli impegni di tale realizzazione personale. La promessa di sicurezza sociale rappresentava la rassicurazione da tale paura.
Promessa tradita
Ma il mito della pianificazione del benessere/welfare, dell’universalizzazione e della standardizzazione delle risposte ai bisogni delle persone, ha dovuto fare i conti con il repentino mutare delle prospettive: dalla seconda metà del secolo scorso si andava verificando ciò che Bauman ha chiamato liquefazione della società, e Giddens destrutturazione individualistica della vita post-moderna. Ecco dunque cambiare anche il volto della paura sociale. Il sistema economico ha palesato le sue fragilità e le sue crisi; il sistema ecologico ha evidenziato la sua sofferenza, le scorte di materie prime hanno mostrato il loro limite.
Da un lato si è assistito a processi di smaterializzazione dei bisogni percepiti, di accentuazione delle soggettività particolari nel percepire ciascuno in forme differenti le proprie mete esistenziali, da un altro lato, si sono affermati processi di de-regolazione dell’economia, di frammentazione della vita sociale, di precarizzazione e di vulnerabilità delle condizioni individuali. L’effetto è duplice e apparentemente contraddittorio: aumenta la necessità di sistemi sociali di protezione ma tale necessità è percepita separatamente da tanti singoli individui senza più aggregarsi in domanda collettiva. Si affermano i bisogni vissuti da prospettive private, particolari, contingenti, ciascuno per sé e, al contempo, la promessa istituzionale di soddisfazione universalistica dei bisogni (e di protezione dai rischi) non regge più.
Tale processo, che Castel ha chiamato di decollettivizzazione collettiva, ha enfatizzato a dismisura la libertà degli attori sociali ed economici da ogni regolazione collettiva, la competizione degli interessi particolari e il protagonismo individuale, incomprimibili a un’istanza comune, insofferenti a risposte pubbliche standardizzate, mente si imponeva la disarticolazione delle forme di contrattazione nel mercato del lavoro rendendolo più flessibile e precario. La tensione a perseguire mete di agio individuale ha eroso progressivamente le basi ideologiche del welfare universalistico, che prometteva protezione “dalla culla alla bara”.
La garanzia annunciata di sicurezza sociale per tutti, sembra aver subito inesorabilmente i colpi delle dottrine neoliberiste, che chiedono agli Stati di ridurre l’impegno finanziario su questo fronte. La spesa pubblica per il “sociale” è additata come freno alla ripresa economico-competitiva dei paesi occidentali.
Ora la domanda di protezione proveniente dai cittadini lavoratori-consumatori, entro i confini di ogni Stato, sembra piuttosto far prevalere istanze securitarie di ordine pubblico. Torna l’appello allo Stato come potente e protettivo gendarme di hobbesiana memoria. Una larga parte del consenso politico-elettorale è andato spostandosi da domande di servizi rivolti alle persone, ai sevizi di sicurezza dalle persone. Pare affermarsi, nell’opinione più diffusa, la richiesta di essere difesi non tanto da fattori che minacciano gli itinerari di vita personali (infortuni, malattia, disoccupazione, vecchiaia, ecc.) quanto piuttosto dal crescente numero di “altri” cittadini vulnerabili o vulnerati, nuovi competitori nella spartizione dei benefici residuali del welfare: cittadini autoctoni vs immigrati, ceto medio indebolito vs nuovi poveri, lavoratori garantiti vs lavoratori precari, adulti occupati vs giovani disoccupati, anziani “garantiti” vs giovani previdenzialmente “scoperti”, proprietari di casa che vedono ridurre il valore del loro bene “immobile” vs giovani coppie, sfrattati, rifugiati, nuovi homeless privi di alloggio. D’alto lato, aumenta la porzione delle persone che scendono sotto le soglie della povertà relativa e della povertà assoluta, mentre le politiche pubbliche paiono incapaci di controvertirne la tendenza.
Il volto della paura di questa post-modernità, assume così una nuova prospettiva. Sembra crollare la capacità di rassicurazione che la modernità aveva promesso ai suoi figli. La fiducia nella razionalità pianificatrice si sgretola di fronte al suo fallimento previsionale. L’incertezza irrompe, il rischio esce dalla portata del ragionamento calcolato mostrando l’incapacità dell’uomo di tenere sotto controllo le mille variabili intervenienti e inaspettate dello sviluppo che lui stesso ha avviato. L’ecosistema si scompone e ricompone in soluzioni inaspettate. Il mercato finanziario globale costruisce e distrugge, apparentemente fuori controllo, i sistemi economici e sociali dei diversi paesi. Un’unica razionalità e un solo attore istituzionale (lo Stato) non sono più sufficienti a prevedere il futuro, ancor meno a progettarlo né a governare i processi evolutivi e le nuove emergenze.
L’uomo della post-modernità pare in preda alla “sindrome Titanic”, come la chiamava Bauman: ha allestito una spettacolare e sofisticata imbarcazione per navigare verso ciò che aveva immaginato come il suo progressivo futuro, ma non sa avvistare l’iceberg che ne potrebbe squarciare la prua e ancor meno sembra preparato a fronteggiare adeguatamente tale evenienza. Il futuro, ieri promessa rassicurante contro le paure, lenitiva delle fatiche presenti, oggi è percepito da molti abitanti del vecchio occidente come minaccia, ignoto incombente, motivo di paura.
Problemi di vista
L’incertezza spinge i cittadini del Nord del globo ad accorciare lo sguardo, a non confidare nell’avvenire, il cui sole ora non si vede sorgere, e a concentrarsi sul presente per trattenere per sé ciò che credevano di essersi definitivamente accaparrato e che pare sfuggire di mano.
La minaccia di “invasione” dall’Est e dal Sud del mondo, il pericolo di subire la violenza terroristica, (statisticamente assai poco significativa come causa di morte tra le tante possibili, ma deflagrante ed esponenzialmente pervasiva nelle evocazioni mediatiche, fino a inibire la spontaneità di circolazione e l’assembramento in luoghi affollati), la crisi economica protratta e la contrazione della protezione sociale pubblica, fanno emergere nuovi sentimenti di risentita impotenza. Per un verso è un risentimento contro le istituzioni pubbliche, che si legittimavano per la loro garanzia di protezione e che ora paiono impreparate al compito, incapaci di giustificare sufficientemente la loro esistenza; un risentimento che contraddittoriamente spinge a chiedere più forza e impositività istituzionale e al contempo alimenta la disillusione delegittimante di ogni autorità pubblica. Per altro verso, è il risentimento di chi sente tradita la sua aspettativa di realizzazione e vede incrinarsi la promessa di un futuro certamente migliore.
In uno scenario di incertezza collettiva e di fragilità delle strutture pubbliche a guida democratica, la paura sociale pare orientare grandi quantità di cittadini a invocare leader politici più “forti” delle stesse istituzioni che sono chiamati a reggere, quasi potessero, con ciò, rinvigorirle autoritariamente. Paura che induce a sovraenfatizzare identità locali e nazionali, unitarie e rassicuranti, da preservare o far resuscitare come fattore di conservazione di ciò che ancora si è e si teme di smarrire. Paura che spinge a evocare robuste recinzioni (muri, dogane, reticolati, motovedette), che proteggano il proprio presente da ogni minaccioso nuovo arrivo (non è difficile osservare tale orientamento negli elettori statunitensi di Donald Trump, o nei francesi che guardano a Marine Le Pen, e così via, in ogni Stato in Europa). Paura che alimenta sia nuovi investimenti in spesa militare pubblica, sia la fiorente economia della sicurezza privata: lievitano gli acquisti di videocamere, porte blindate, sistemi d’allarme, contratti con agenzie di security, quartieri-fortino, armi per uso personale.
In questa post-modernità “occidentale” la paura trattiene in un presente difensivo e intristito, non consentendo di allungare lo guardo per vedere oltre, proiettarsi su nuove mete, rigenerare fiducia collettiva. È la paura degli scoraggiati – letteralmente privi di coraggio – che non sanno o non osano guardare oltre il proprio vissuto contingente. La paura presente, si potrebbe allora sostenere, è frutto e al contempo co-artefice della desocializzazione delle vite individuali, dell’attenuazione della percezione di comunanza di destino e di legami mutualmente interdipendenti. Nuovo coraggio può emergere, all’opposto, tra chi è ancora capace di una fiducia antropologica, che consenta di vedere oltre all’oggi e oltre al sé; contrappeso alla paura di qui pare essere, dunque, la capacità di proiettarsi in un tempo che non si esaurisca nella propria particolare vicenda (individuale, di gruppo o regionale che sia) e la capacità di identificarsi con altri diversi da sé con cui condividere comuni attese.
ENDOXA - BIMESTRALE SOCIOLOGIA Anthony Giddens marzo 2017 paura sindrome Titanic welfare Zygmunt Bauman

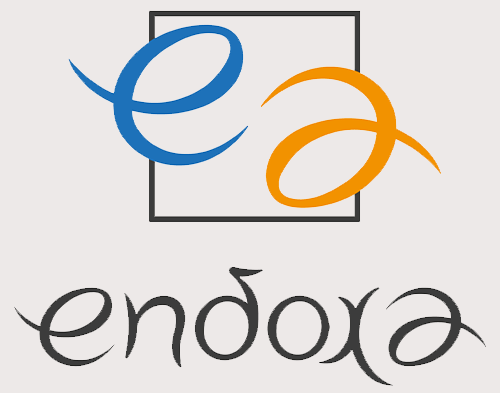
1 Comments Lascia un commento ›