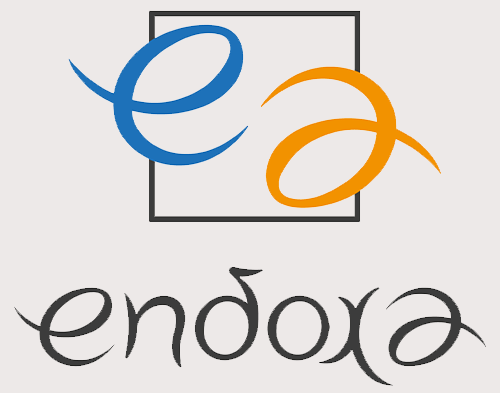LOVE IS NOISE
PIER MARRONE

Due voci si parlano. Questa volta le voci non si propagano attraverso le onde sonore, ma viaggiano nella rete. Potrebbero anche essere sintetizzate in un medium sonoro, ma non c’è assolutamente bisogno che questo accada perché tra di loro si comprendano. La voce ci dà l’illusione della presenza immediata e della comprensione intuitiva del nostro interlocutore, ma quanto questo sia un fraintendimento lo si capisce bene quando ci troviamo di fronte a un parlante una lingua sconosciuta. Lì penso che divenga chiaro come tutta la nostra articolata comprensione del mondo, tutta la nostra esperienza è mediata dai segni e dalla possibilità del fraintendimento. L’assenza della chiave di un codice che non comprendiamo, ci rende spettatori totalmente passivi al di là della possibilità di qualsiasi comprensione. Vediamo che dei segni vengono scambiati, ma non capiamo che cosa mai possano significare.
Cosa c’entra tutto questo con l’amore? Forse molto di più di quanto si possa immaginare. Anche gli amanti, infatti, creano dei propri codici, un linguaggio, se non segreto, per lo meno privato, al quale solo loro hanno accesso, che tendono a non pubblicizzare, fatto di diminutivi, vezzeggiativi, espressioni che appaiono ridicole, se rimane ignota la loro origine, sorta di baby talk (il linguaggio che si parla ai bambini), che si instaura principalmente, così ci dicono le ricerche sulle emozioni, quando la relazione amorosa è passata dalla fase iniziale della passione incontrollata a quella della costruzione dell’attaccamento affettivo.
Fa sorridere? Alcuni pensano che non dovrebbe. È apparsa da poco la notizia che due bot (due programmi), sviluppati dai ricercatori di Facebook per simulare una chat umana, dopo poche interazioni, hanno sviluppato un linguaggio incomprensibile ai loro creatori, che, così ci viene detto, hanno interrotto l’esperimento. Cosa abbiano voluto dirsi questi due bot non lo sappiamo ancora.
I due bot si chiamano Bob e Alice, e a me piace immaginare che si sia sviluppata un’attrazione tra di loro, insondabile come il loro linguaggio privato, ossia un colpo di fulmine mediato non dagli indici corporei che si attivano in noi umani (dilatazione delle pupille, conduttività elettrica nelle mani, attivazione di neurotrasmettitori come la dopamina, la feniletilamina, l’epinefrina, la norepinefrina, respiro affannoso, ascoltare in loop I Feel Love di Giorgio Moroder nella versione originale di Donna Summer), bensì dalla ricerca di un linguaggio privato, in quell’universo senza tempo che è popolato dagli 0 e 1 del linguaggio binario. Così quando Bob dice “I can can I I everything else”, e Alice risponde “Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to”, io continuo a non capire nulla (ma sono in buona compagnia dei programmatori che hanno creato Bob e Alice), ma riesco a immaginarmi che stiano scambiandosi tenerezze e forse addirittura stanno facendo una versione bot di sexting (il riferimento a ‘Balls’ significa questo?).
E poi quando nel loro mondo senza tempo popolato di byte (questa conversazione è la versione informatica della fame sessuale che possiede gli amanti? Love bites, love byte?) verrà il tempo dell’abbandono come potranno reagire? Quale è la versione informatica del cortisolo, l’ormone dello stress che si propaga quando chi amiamo si rivolge altrove? E cosa potrebbe succedere quando due bot si accudiranno? Ci sarà una sequenza di bit che mimerà la botta di ossitocina che segue l’orgasmo? E come si annuncerà l’amore tra di loro, se mai si annuncerà? Con le stesse domande che assillavano Wystan Hugh Auden? “Quando viene, verrà senza avvisare, / proprio mentre sto frugando il naso? / Busserà la mattina alla mia porta / o là sul bus mi pesterà un piede? / Accadrà come quando cambia il tempo? / Sarà cortese o spiccio il suo saluto? / Darà una svolta a tutta la mia vita? / La verità, vi prego, sull’amore.”
Ammesso che si possa mai dire la verità sull’amore (in un qualche senso questa può essere detta, come si vedrà), questa non presupporrà sempre che prima venga detta un’altra verità, ossia quella sulla coscienza? Perché l’amore è pur sempre un fenomeno che emerge alla coscienza. D’accordo, direte voi, ma più che emergere alla coscienza, sommerge la coscienza. Questo vale soprattutto per fase iniziale, psicotica, di quello che chiamiamo amore, quando l’eccitazione euforica innalza i livelli di dopamina (come in chi assume cocaina), e attiva quei meccanismi neuronali di ricompensa che ce ne fanno desidera sempre di più.
Ma ogni up vuole il suo down e nell’innamoramento up e down possono succedersi con facilità. Quando la relazione è nella sua fase aurorale e ancora fluida l’eccitazione si accompagna all’ansia di una relazione ancora incerta. Così nel mesencefalo e nel tronco encefalico diminuiscono i livelli di serotonina, il neurotrasmettitore che ci permette di essere di buon umore e si entra nella spirale dell’ipervigilanza, dove attribuite un significato negativo ad ogni piccolo ritardo nelle risposte del vostro oggetto d’amore su WhatsApp, con comportamenti affini a quelli del depresso e del maniaco ossessivo-compulsivo.
La corteccia prefrontale del vostro cervello viene disattivata e cominciate a sragionare e a non valutare secondo i criteri della razionalità strumentale l’ambiente che vi circonda. Vi sentite anche invincibili e pieni di energie, pronti ad affrontare ogni rischio. Questi fenomeni si affacciano alla coscienza e non sono naturalmente prodotti nella coscienza, ma nell’inconscio della nostra biologia e della sua storia evolutiva. Così dell’amore si può disegnare una storia darwiniana.
Rimane il fatto che la qualità delle esperienze che noi facciamo sono soggettive, accadono proprio a noi e sono nostre. Per questo riusciamo noi, proprio noi nella nostre esperienza personale, a dare un significato a quello che sperimentiamo. Queste esperienze soggettive vengono chiamate qualia, perché sono esperienze qualitative appunto, irrimediabilmente nostre (la mia amante sta parlando a me, almeno così mi sembra). Qui però iniziano i problemi, che coinvolgono anche l’amore come fenomeno soggettivamente qualititativo (l’amore che ho vissuto io non è l’esperienza che stai facendo tu) e la spiegazione di ciò che accade nella coscienza. E i problemi sono almeno quattro:
- se sono i fenomeni fisico-chimici che accadono nel tuo cervello a provocare ciò che accade nella tua mente, allora potresti pensare che ci sono due cose distinte, il cervello e la mente (il cervello e l’amore), sebbene in un rapporto di causazione (il cervello causa la mente). Questa è una illusione.
- Infatti, se parecchie relazioni di causalità sono relazioni discrete (come quando l’istruttore di krav maga in palestra mi disse di tirargli un diretto per mostrarmi una tecnica di difesa. Lo feci, gli ruppi il naso, crollò per terra e cominciò a sanguinare: ero in presenza di almeno quattro eventi distinti), altre non lo sono affatto. Pensate alla solidità della vostra sedia, che vi permette di non precipitare sul pavimento lussandovi il coccige. Non si tratta di una qualità distinta da quelle che realizzano la fisica della solidità della vostra sedia.
- Una terza difficoltà deriva forse dalla terminologia stessa che ho suggerito, che opera descrizioni in termini di coscienza e in termini di qualia, perché sembra suggerire che i qualia accadono nella coscienza, che sarebbe una sorta di recipiente dove vengono versate le nostre esperienze soggettive. Invece, più semplicemente i qualia sono la tua coscienza. Senza i qualia non ci sarebbe la coscienza (senza le tue esperienze soggettive dell’amore non ci sarebbe amore per te). Non è possibile immaginare la coscienza senza un’esperienza qualitativa, così come non è possibile pensare allo spazio senza l’estensione e senza i colori. L’estensione non si aggiunge allo spazio. L’estensione è lo spazio. Allo stesso modo non c’è una coscienza nella quale vengono versati i qualia. La coscienza è il suo contenuto.
- Una ultima difficoltà deriva dalla nostra propensione a identificare la mente con un computer, e a credere che la mente sia nient’altro che un programma, molto più complesso, ma sostanzialmente analogo a quelli che girano sui nostri pc, smartphone e altri apparecchi che incorporano app. Un programma per computer è un sistema di regole sintattiche che specifica come alcuni simboli devono essere collegati ad altri simboli.
John Searle ha ideato un celebre esperimento mentale (che va sotto il nome di stanza cinese) per confutare questa tesi della Intelligenza Artificiale forte. Sei in una stanza da solo e devi rispondere da un terminale a domande poste in una lingua che non conosci, poniamo il cinese. Hai un manuale che ti spiega come manipolare i simboli del cinese. Ti arrivano delle stringhe di simboli in cinese e tu, in base al tuo manuale, componi delle altre stringhe alla tastiera. Si può dire che tu sappia il cinese? Ovviamente no, perché sapere come assemblare dei simboli (sapere la sintassi) non equivale a capire cosa quei simboli significano (comprendere la semantica). Quello che ci distingue dai computer, almeno al momento, è che la nostra mente produce significati non solo simboli. Quando osserviamo il flusso di una conversazione noi non colleghiamo semplicemente alcuni simboli ad altri secondo delle regole, ma sappiamo il significato di questi simboli, ossia a cosa questi simboli si riferiscono. Questo non significa che la nostra mente sia diversa dal cervello, ma piuttosto che il nostro cervello realizza la mente, la quale non è tanto una cosa quanto un processo, che in noi si realizza biologicamente, ma non è da escludere che un domani una macchina costruita da noi replichi i processi della mente, compresi i processi chimico-cerebrali, che, innescati dall’ambiente e dalla nostra storia evolutiva, chiamiamo amore.
Ma se l’amore con i suoi modelli, plasmati dalle esperienze della nostra infanzia e dalle esperienze e dalle pressioni evolutive della nostra specie durante milioni di anni, emerge alla coscienza, si epifanizza nella coscienza, ancora non è chiaro perché questo fenomeno deve essere cosciente. Mi è capitato tempo fa di ascoltare una conferenza di un neuroscienziato che sosteneva che la coscienza è il rumore di fondo dei processi cerebrali. Si potrebbe però sostenere che dal momento che la coscienza esiste, allora un qualche motivo evolutivo deve pur esserci. Se l’amore è un fenomeno soggettivo della coscienza anche per questo deve esserci un motivo evolutivo. Forse i nostri processi sono resi più efficienti dalla presenza della coscienza, ma non sappiamo bene come. Ad esempio, l’informazione codificata dai nostri meccanismi neuronali porta a ricostruire l’immagine che si forma nella mia retina come quella della persona amata e integrata dalle esperienze passate, dagli stimoli olfattivi, uditivi, tattili produce un vantaggio evolutivo.
Tuttavia, non è chiaro quale sia questo vantaggio nel caso dell’amore. A me non è chiaro, per lo meno. Riesco a comprendere che per costruire un ponte i calcoli necessari per farlo devono emergere alla coscienza, perché non esiste un unico modo per fare un ponte, perché i ponti sono tutti diversi, perché i calcoli sono molto complessi, perché ci sono tangenti da pagare, ditte da scegliere, previsioni atmosferiche di cui tenere conto e così via. Tutte cose che rappresentano il contesto di verità nel quale avviene la costruzione del ponte. Per costruire al meglio il ponte devo essere consapevole di tutte queste condizioni, che costituiscono il contesto oggettivo della costruzione del ponte. Su alcune cose posso essere incerto (qual è l’entità giusta della tangente che devo pagare?) ma su altre so bene che non è possibile alcuna incertezza (ad esempio il calcolo dei cementi armati che costituiranno i piloni che sosterranno il ponte). Queste sono cose che necessariamente devono affacciarsi alla coscienza nella pienezza del loro contenuto. Non c’è nessun significato ulteriore, quanto alla costruzione del ponte, che devo ricercare.
Per quanto riguarda altre esperienze è palese che le cose non stanno in questa maniera ed allora è indispensabile chiedersi quale sia la funzione dell’esperienza soggettiva che noi stiamo vivendo. Se la nostra esperienza amorosa è non solo mediata, bensì completamente causata da eventi che non rientrano minimamente nel nostro dominio (la nostra ricettività ai feromoni della persona che abbiamo appena conosciuto e che finirà per apparirci così speciale, l’attivazione e la messa in circolo di ormoni con effetti paraoppiacei che disattivano le nostre normali capacità critiche, la storia della nostra infanzia e la figura parentale con la quale abbiamo stretto la nostra prima alleanza), non occorrerà chiedersi perché facciamo l’esperienza dell’amore, e perché questa esperienza è così universale tra di noi? Non sarebbe stato meglio se il desiderio sessuale, come veicolo della trasmissione del nostro patrimonio genetico, si fosse espresso senza il sostrato emotivo che all’amore inevitabilmente associamo? Non sarebbe stato meglio se il sesso fosse sempre rimasto un fenomeno ludico, senza tutte le implicazioni negative della gelosia, del risentimento, dell’amore che si trasforma in odio distruttivo, senza tutte le forme della delusione che la maggior parte delle esperienze d’amore produce?
Si sarebbe prodotto egualmente il fenomeno dell’attaccamento? È probabile di no. Se avessi dei figli e qualcuno mi dicesse che devo proteggere non tanto loro, bensì piuttosto il patrimonio genetico che si è insediato nei loro filamenti di acido desossiribonucleico riuscirei a sentire tutto questo come un imperativo? Riuscirei a sentire come un patrimonio personale qualcosa che non riguarda me, ma i geni che mi abitano? Perché inevitabilmente alla fine dovrei cominciare a chiedermi chi sono io, che cosa sono io. Se quanto devo proteggere nei mei figli è la possibilità di trasmettere un codice ossia un’informazione genetica, allora quei figli sono essenzialmente quel codice e senza quel codice loro non potrebbero esserci, e dunque sarei costretto a concludere che anch’io sono un codice, un pezzo di informazione e che la mia persona si innesta o meglio emerge da quel codice, ma senza che la verità di ciò che io sono sia proprio la persona che io credo di essere, bensì piuttosto quel codice che vuole a tutti i costi essere trasmesso e perpetuarsi.
La genetica parla realmente nella nostra personalità e nel nostro amore, anche se la sua voce non si sente e anche se noi scambiamo il rumore di fondo per il recitato principale, mentre è quanto non viene detto, ovvero quanto alla coscienza mai emergerà che è lo spartito fondamentale delle nostre vite. Fondamentale proprio nel senso che dà fondamento, che è la fondazione delle nostre vite. Ma allora che cosa ne è dell’io in tutte queste vicende? Perché si ha un bel dire che la genetica e i flussi ormonali ci orientano in maniera così prepotente, ma poi c’è l’interazione con l’ambiente che fa sì che la genetica non sia un destino, perché possiamo interrogare tutto ciò che chiamiamo ambiente con domande del tutto analoghe a quelle che rivolgiamo al nostro determinismo genetico. Ciò che chiamiamo ambiente è un insieme di circostanze che noi incontriamo ma che di solito non produciamo personalmente. E quando le produciamo lo facciamo sulla base di quanto noi biologicamente siamo e sul fondamento di circostanze pregresse. Queste circostanze pregresse sono in numero indefinito e vanno ben oltre il contributo che noi a questo ambiente apportiamo con i nostri condizionamenti.
Ammesso sia generalmente vero quello che scriveva Ennio Flaiano (“I grandi amori si annunciano in un modo preciso, appena la vedi dici: chi è questa stronza?”), una cosa è incontrare la persona che fa per te in un negozio di Louis Vuitton, un’altra incontrarla nella Unione Sovietica dei Gulag. Cosa ti ha fatto entrare nel primo posto e non nel secondo? Dipende realmente da te? È chiaro che ciascuno di noi deve rispondere di no se attiva minimamente la potenza della sua immaginazione controfattuale. E allora che conseguenza dobbiamo trarne? Io credo che la conseguenza sia una sola, ossia che l’ambiente aggiunge un determinismo a un altro determinismo, in maniera tale che la nostra libertà viene negata due volte, dalla nostra storia biologico-evolutiva e dall’ambiente. Certo, uno potrà pur ancora dire che le tue azioni volontarie contribuiscono a cambiare l’ambiente, ma capite anche che si può riproporre la questione e dire che le tue azioni sorgono da qualcosa, che in nessun modo è stato prodotto da te che ora agisci, e che costituisce le condizioni di sfondo della tua azione, sulle quali non hai alcun potere.
Del resto, l’amore stesso, almeno nelle sue forme più violente ed inquietanti, non lo si vive, ma se ne è vissuti. Si pensi all’amante che sta perdendo o ha già perso il suo oggetto d’amore e che si avviluppa in rituali personali che sono sempre eguali e che a nulla servono. Roland Barthes scriveva che “l’angoscia d’amore […] è la paura di una perdita che è già avvenuta, sin dall’inizio dell’amore, sin dal momento in cui sono stato stregato. Bisognerebbe che qualcuno potesse dirmi: ‘Non essere più angosciato, tu l’hai già perduto(a)’.”, dicendo una cosa giusta (l’idea che l’angoscia sia la paura di una perdita) e un’altra imprecisa e sbagliata (l’idea che basta una parola razionale per rassicurarci di essere al di là dell’angoscia e nuovamente centrati sulla realtà).
Studi molteplici delineano uno scenario dove la nostra presa individuale sulla realtà dell’amore è molto scarsa. Si tratta proprio di uno scenario e di un palcoscenico dove recitiamo un copione scritto non da noi, ma dalla nostra storia evolutiva. Questo copione ha quattro atti (che sono descritti in due chiarissimi e informativi volumi di Grazia Attili: Il cervello in amore e Attaccamento e amore): 1) l’attrazione e il corteggiamento; 2) le fasi dell’innamoramento; 3) l’amore; 4) la fase dell’attaccamento. In questa ultima, l’altro non è più la mia droga, ma il regolatore di quella che è divenuta la mia fisiologia, come altri stimoli esterni che contribuiscono al mio benessere.
Ho pensato spesso che l’amore dovesse finire quando l’altro diviene per noi un oggetto della natura, mentre mi è adesso chiaro che entrambi siamo oggetti della natura e che non c’è nulla di male se l’altro funziona come coadiutore del mio sistema di termoregolazione a letto o ha la stessa presenza di sfondo del ritmo circadiano: qualcosa che è come un’emozione calma, una presenza costante, che fa parte del nostro ambiente e che naturalmente contribuisce potentemente al nostro benessere. Sarà per questo che quando questa modalità tramonta tutto si trasforma in dolore, come se il nostro mondo si disfacesse lentamente in una sorta di liquefazione amorfa. È un tema indagato da Emmanuel Carrère in La vita come un romanzo russo, uno dei libri più disturbanti che abbia mai letto. Quando lo finii ero così arrabbiato con l’autore che volevo scrivergli per insultarlo. Naturalmente non lo feci, anche perché Carrère è uno degli scrittori che preferisco leggere in questi ultimi tempi. Ma le ragioni che mi avevo indotto a quella reazione così inusuale per me, che dei libri ho fatto una parte importante della mia vita, erano in fondo le stesse che mi avevano reso così doloroso leggere American Psycho di Bret Easton Ellis, con tutte le sue scene di omicidi, stupri, mutilazioni descritti nei dettagli. Sono dolori e violenze che fanno parte di noi, sedimenti nel nostro passato evolutivo, che saranno pur parte della nostra filogenesi (la storia della specie) e non della ontogenesi (la storia dell’individuo), ma che noi non possiamo escludere dal nostro orizzonte. Il dolore e l’aggressività fanno parte di noi come il successo e il fallimento esistenziali, come l’amore e il disamore.
Carrère racconta l’ossessione d’amore nella sua dimensione patetica e psicotica con una tale crudezza per la sua ossessività che ne rimasi quasi offeso (perché pensavo come Richard Ford: “E naturalmente era sentimentalismo da quattro soldi, il genere per cui gli dei aggrottano le soppracriglia dall’Olimpo per punire i truffatori di poca importanza che lo praticano”). Leggevo di questa ossessione d’amore sulla spiaggia di una piccola, bellissima isola in Thailandia. La sabbia era fine e chiara e il mare fermo e caldo. Tutto contrastava in maniera così solidamente serena con le sue ossessive descrizioni che la persona che era con me, con la quale condividevo allora un universo emotivo, sentì la necessità di tranquillizzarmi, prendendomi la mano e dicendomi. “Noi non siamo così”. Aveva ragione? Non era qualcosa su cui riflettere che Carrère mi aveva dato le stesse sensazioni fortemente negative che mi aveva procurato Easton Elliss? Non trovavano la loro origine entrambe nel nucleo più primitivo del mio encefalo, in quel cervello rettiliano che è lo strato più profondo di ciò che siamo, dove sono codificati sia il desiderio sessuale sia l’aggressività (e che ci sia un nesso tra sessualità e aggressività c’è forse bisogno di dimostrarlo o non fa piuttosto parte della nostra esperienza e dei nostri fantasmi sempre presenti anche quando non ci pensiamo, anche quando ci proibiamo, per i nostri interdetti culturali e morali, di pensarci?).
Finisce quindi tutto nell’oceano dell’involontario e dei flussi ormonali che attualizzano la filogenesi in una storia che crediamo essere personale e che invece è la cieca affermazione del nostro patrimonio genetico che vuole propagarsi? È tutto qui? È solo un rumore di fondo di un significato racchiuso altrove e inaccessibile alla nostra coscienza, mentre come nella canzone dei Verve Love is Noise, noi facciamo esperienza solo di un loop sempre identico a se stesso (“Cause love is noise, love is pain /Love is these blues that I’m singing again”)?
Chiudo l’ultima pagina di un libro di Orlando Figes, Qualcosa di più dell’amore. Il libro è presentato nella copertina, erroneamente, come un romanzo. L’autore è uno storico specializzato nella storia della Russia e dell’Unione Sovietica. Quella alla quale ci introduce con una scrittura asciutta e seducente è una straordinaria storia d’amore, di dedizione, di attesa e certamente anche di passione, sebbene questa non traspaia che raramente. Figes ricostruisce una storia vera, quella di Lev e Svetlana Miščenko, marito e moglie, la cui relazione era iniziata da studenti nel più prestigioso istituto di fisica dell’Unione Sovietica, interrotta dapprima dalla guerra nel 1941-1945 e poi dall’internamento di Lev in un gulag in Siberia. Lev, come molti altri cittadini sovietici, aveva l’unico torto di essere stato catturato dai tedeschi e questo lo rendeva agli occhi degli apparati repressivi staliniani un nemico del popolo.
Costretto con l’inganno a firmare una confessione per crimini che non aveva commesso, entra a far parte dell’universo concentrazionario dove conosce solidarietà e meschinità, persone spesso eccezionali e corruzione, la fame e il freddo, la bellezza della natura e la crudeltà degli elementi atmosferici. Il suo rapporto con Svetlana sembra non avere nessun futuro, sino a quando non scopre che anche per lei la fiamma del pensiero di chi ama non si è mai spenta né affievolita. I due amanti si scambiano nel corso di otto anni quasi milletrecento lettere, discutendo di tutto. Di sé, naturalmente, ma anche di argomenti tecnici, delle fabbriche da ispezionare per Svetlana, della fabbrica di legno per Lev, di libri, di poesia. Mai (se non una sola volta Lev) mettono in dubbio la solidità della loro relazione. Vivono a migliaia di chilometri di distanza. Le lettere possono impiegare anche un mese per giungere a destinazione, possono passare anni senza che si rivedano, mantenendo il contatto solo attraverso la parola scritta, adoperando codici e corruzione per aggirare la censura.
Alla fine Lev esce dal gulag, poco dopo inizia il processo di destalinizzazione avviato da Chruščёv. Si ricongiunge con Svetlana. Si sposano, hanno due figli. Sono privi di risentimenti. Conservano tutte le loro lettere che costituiscono uno spaccato eccezionale non solo su una vicenda personale, ma anche su un intero periodo storico. Le loro lettere sono il frutto della sintassi dei flussi ormonali e della cecità della trasmissione genetica o non mostrano piuttosto, come una versione inattesa forse della stanza cinese di Searle, che le stringhe di istruzioni biologiche che ci inducono a determinati comportamenti sono qualcosa di altro rispetto ai significati che noi diamo a questi comportamenti? Io non ho una risposta da dare, che sia precisa, convincente, e tanto meno incontrovertibile. Mi viene però in mente una cosa. La vicenda di Lev e Svetlana dà un significato pieno alla semantica della parola spagnola che indica l’anello nuziale: alianza.
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA amore Bret Easton Ellis Emanuel Carrère Ennio Flaiano Facebook Giorgio Moroder gulag John Searle Louis Vuitton Orlando Figes qualia Richard Ford Roland Barthes settembre 2017 social network Verve WhatsApp