TANTO PEGGIO PER I FATTI: L’IDIOSINCRASIA DEL POSITIVISMO GIURIDICO
 ANDREA RACITI
ANDREA RACITI
- Il diritto e il resto
Ai nostri giorni, a volte, si usa sentire ancora nei piccoli e grandi consessi della scienza del diritto una frase latina – un brocardum – che suona così: “Ius causa hominum est”. Il diritto esiste per gli uomini, è utile solo per loro. Ed effettivamente, presa nel suo palmare, quasi triviale, significato, non si può che ammettere la correttezza di questa affermazione.
Proprio una volta che si sia preso per buono questo detto, non bisogna nasconderselo, iniziano i problemi. Diciamolo subito: i problemi che sorgono dall’interpretazione di questa (apparentemente) piana e ingenua formula non vengono quasi mai considerati dalla scienza del diritto odierna, e le ragioni di questa mancata interrogazione sono certamente molteplici. Diciamo fin d’ora un’altra cosa: queste ragioni mi appaiono del tutto legittime, se considero il punto di vista del giuspositivista. Anzi, qui avanzo l’ipotesi che queste ragioni rispondano ad un fondo di “verità necessario” per il giuspositivista, nel senso che questo fondo riguarda la stessa sopravvivenza della scienza giuridica. La scienza giuridica, appunto, deve garantirsi la sopravvivenza, deve mantenersi in vita, preservarsi. Ogni ente per preservarsi deve ritagliarsi uno spazio. Come? Negando ciò che lo circonda.
Ora, la scienza giuridica, che non è solo un ente “spirituale”, ovvero un complesso di conoscenze, dottrine disparate, indirizzi giurisprudenziali, è fatta di uomini, di gente che ha come sua passione un oggetto particolare, particolarissimo, quasi indefinibile, che chiamiamo “diritto”. La scienza di cui parliamo, pertanto, deve isolare quel fenomeno di cui si occupa da tutto il resto. Questo resto, appunto, non conta ai fini della scienza. Bisogna astrarre il diritto dal magma in cui si trova originariamente e farne perdere il più possibile le tracce, perché il resto è pericoloso per la sopravvivenza della scienza, rischia di macchiarla con un mìasma, una lordura, una contaminazione. Serve garantire una certa purezza alla scienza del diritto.
Adesso, certamente, delle orecchie mediamente informate sulle vicissitudini storiche e dottrinali che hanno riguardato la teoria del diritto, penseranno subito che il mio riferimento alla purezza della scienza giuridica riguardi la teoria elaborata dal grande giurista austriaco Hans Kelsen. Queste orecchie, per così dire, penserebbero correttamente. Tuttavia, non penserebbero ancora a sufficienza. La dottrina formal-imperativista di Kelsen, che troviamo esposta nei suoi aspetti essenziali in testi quali La Dottrina pura del diritto (1934) e nella Teoria generale del diritto e dello Stato (1945), non è che una e, forse, neanche la più estrema delle formulazioni contemporanee di un indirizzo filosofico incredibilmente pervasivo e fondamentale per la storia del diritto: il positivismo giuridico.
Non si tenterà qui una ricostruzione storica della pur avvincente trama del giuspositivismo, impresa realizzata da tanti studiosi più che degnamente.
In questo breve spazio, mi piacerebbe tracciare i caratteri essenziali di questo indirizzo, che, come tutti gli “ismi” consiste in qualcosa di più che un mero “ismo”. A mio modo di vedere, se – come ci insegna l’“archeologia del sapere” di Foucault – provassimo a compiere un’interrogazione del presente che getti un’ombra sul passato, ebbene, lo stato attuale della scienza del diritto ci si staglierebbe dinanzi come un “destino” in un certo senso.
La “positività” del diritto, che isola se stessa dal resto costantemente inascoltato, si disvela come l’idiosincrasia della formula latina che si è citata più sopra. L’idiosincrasia di una specifica, e cionondimeno storicamente vincente, interpretazione del ius causa hominum est. La vittoria dell’interpretazione giuspositivista della formula presenta una variegata sintomatologia, che ci permette di individuare, con un grado di sufficiente certezza, i fautori del positivismo giuridico anche in coloro che apertamente lo rinnegano – di fatto così misconoscendolo – e si presentano quali alfieri dell’anti-formalismo, o di una visione ispirata al Freirecht, oppure all’ “istituzionalismo” che si vuol rifare ad ogni costo al Santi Romano de L’ordinamento giuridico (1918) o a Maurice Hauriou, e, a volte, addirittura a Il Nomos della Terra (1950) di Carl Schmitt.
In particolare, financo lo storico, il filosofo del diritto o il giurista teorico che intendessero liberarsi del positivismo giuridico con un colpo di spugna, alla fine, alla prova “dei fatti”, non potrebbero che cadere in una stridente contraddizione, costretti ad argomentare sempre a favore di una pur minima “positività” del diritto. Il carattere minimale della positività, stranamente, diventa quasi subito magicamente capace di assorbire il resto che rimane sempre impensato dalla scienza del diritto. Il presupposto dell’idiosincrasia che io denomino “positivismo giuridico” nasce dall’interpretazione (quasi) letterale della formula latina: è diritto solo ciò che è posto da un’autorità umana, quali siano poi i suoi criteri di legittimazione si vedrà nei singoli ordinamenti e, in ogni caso, sarà tutt’al più un problema dell’etica o della filosofia politica, giammai della scienza del diritto. Alla domanda di Kant, che egli si pone nel contesto dei Principi metafisici della dottrina del diritto (1797), che suona così: “Quid sit iuris?”, che cos’è del diritto, cosa appartiene al diritto, la risposta non può essere che tautologica: è del diritto ciò che appartiene al diritto, ovvero, è diritto tutto ciò che è prodotto conformemente ad un’autorità umana preposta alla produzione del diritto. Se ci chiediamo da chi o da che cosa quell’autorità venga preposta, nasce la filosofia del diritto, che, secondo Kant, sarebbe un’interrogazione sulla giustizia del diritto stesso: “Quid sit ius?”, che cos’è il diritto?
Tuttavia ci si potrebbe ulteriormente chiedere: siamo davvero approdati alla filosofia del diritto se partiamo dal presupposto che il diritto sia un quid? In qualche modo, anche la domanda della cosiddetta “filosofia del diritto” sembra mal posta, perché ci stiamo già dando una risposta abbastanza chiara: qualunque cosa sia, sappiamo già che il diritto è comunque una “cosa” o un “qualcosa” e che questa cosa o qualcosa certamente “è”. Quindi, qualunque cosa sia, il diritto è già subito identificato come un “che cosa”, un quid. E sì, questa cosa ha a che fare con l’uomo, è posta dagli uomini, causa hominum est, esiste per loro. Il resto invece, come sempre, deve rimanere silente, è ingombrante per una scienza del diritto la quale, se è davvero “scienza”, deve avere ben chiaro il suo oggetto, circoscriverlo, renderlo intelligibile dandogli un determinato “tono”, una voce (Stimme) che rimane fuori dal coro per possedere una sua propria determinazione (Be-stimmung).
Attenzione, ciò non toglie che non esistano branche quali l’analisi economica del diritto o la sociologia del diritto o fini analisi politiche del diritto da parte dei politologi, ma anche, di recente, inedite collaborazioni tra filosofia del diritto e ingegneria gestionale, diritto e informatica… Insomma, chi più ne ha più ne metta. Come si potrebbe parlare di un’idiosincrasia, allora, vista tutta questa messe di interdisciplinarità? In realtà, a mio avviso, l’idiosincrasia del positivismo giuridico semplicemente si fa più estesa e pervasiva: tutte le analisi economiche, sociologiche, informatiche o ingegneristiche devono dare per presupposto e intelligibile il loro oggetto, il diritto: questa cosa posta da un’umana autorità preposta (da chi?) alla sua produzione, emanazione o creazione… Il linguaggio pseudo-teologico del positivismo giuridico ci offre un variegato bestiario dogmatico di cui servirci ai fini della scienza.
- Un fantasma tangibile
Allora, ci si pone un problema: ma non si stanno forse mettendo i puntini sulle “i”, spaccando il capello in quattro per un ingiustificato e personale livore contro una scienza del diritto che deve essere “positiva” per essere scienza? In fondo, il messaggio della scienza “positiva”, anche quella giuridica, sembra essere del tutto ragionevole: il diritto è qualcosa di tangibile, deve esserlo se si vuole farne scienza. Questo è, nel suo nocciolo essenziale, il fulcro del positivismo giuridico, così duro e infrangibile da mettere d’accordo anche coloro che si dicono anti-positivisti, anti-formalisti, anti-legalisti, neo-contrattualisti, neo-giusnaturalisti. Insomma, gli “anti” e i “neo” non possono che concordare con la buona novella del positivismo giuridico. Il diritto è qualcosa, un “quid” tangibile, e anche quando è posto nella fantasmatica “natura” o “ragione” umana, anche quando fosse posto in primis da Dio stesso – si veda il De legibus ac Deo legislatore (1612) di Suarez per farsene un’idea – che il diritto sia un qualcosa, un quid posto, in un’ultima istanza, da un’autorità umana, rimane un presupposto irrinunciabile. Il resto, appunto, non rileva. Difatti, cosa significa parlare di “natura” o di “ragione”, se non di un’auto-autorità, di un comando interiorizzato che detta una determinata regola che guidi l’uomo, che lo conduca per mano? Spinoza parla di un uomo che pensa e agisce ex ductu rationis, che segue appunto il dictamen rationis. Ciò che può sembrare giustificato sul piano ontologico, trasposto sul piano giuridico (ciò che Spinoza fa soprattutto nel Tractatus politicus) si trasforma nell’asserzione incondizionata della positività (qui presentata come statalità) del diritto, pur se teoreticamente agganciato sempre a un diritto naturale che, come centro vuoto a cui sempre far riferimento, possa ricordare allo Stato di garantire la tanto agognata libertas philosophandi.
Il fulcro dell’idiosincrasia giuspositivista lo riscontriamo proprio nell’affermazione dell’esistenza di un centro vuoto a cui il pensiero si obbliga far riferimento: “natura”, “ragione”, “volontà di Dio”, “volontà del legislatore”, “Carta costituzionale”, “Grundnorm”, “Sovranità”.
Ciaramelli, nel suo Consenso sociale e legittimazione giuridica (2013), parla di una eterogenesi dei fini del giusnaturalismo: la originaria affermazione di un diritto meta-positivo e meta-fisico (a volte, come nella sua versione confessionale, meta-umano) realizza un fine diverso da quello che si era originariamente prefissato: la positivizzazione del diritto naturale da parte dell’autorità dello Stato, il quale sancisce il suo monopolio della produzione giuridica a partire dalla Rivoluzione francese, facendosi garante ed effettivo performer del diritto naturale stesso.
Nonostante il risultato, da un punto di vista storico, sia consistito certamente nella conversione per via autoritativa del diritto naturale in diritto positivo, non credo che questo risultato possa definirsi altro rispetto al fine originariamente prefissato. Non solo Spinoza, ma tutta la filosofia propugnatrice di una forma di giusnaturalismo, da Grozio e Hobbes fino a Leibniz, Locke, Rousseau e Kant, mai sganciò il diritto naturale dalla tensione verso una realizzazione storica in forma statale: se il centro vuoto del diritto naturale nasceva come mera idea filosofica, in statum potentiae, per passare in actu era necessario che questo centro vuoto si realizzasse storicamente in forma autoritativa. Ma, sempre, attenzione, di un centro vuoto trattavasi, e si tratta ancor oggi, quando si parla di positività del diritto.
Con questo, naturalmente, non si vuole affatto dire che la filosofia politica e giuridica moderna abbia in qualche modo preparato l’avvento del positivismo giuridico nella sua forma avanzata o altre simili esagerazioni: la filosofia non detiene un simile potere fondativo. Si vuol dire, piuttosto, che la filosofia dei secoli XVII-XVIII è riuscita, come ogni vera filosofia, a esporre il destino storico della sua epoca, essa davvero compì l’impresa di “cogliere in pensieri il suo tempo”, come direbbe l’Hegel dei Lineamenti di filosofia del diritto (1821). La filosofia moderna ha esposto il destino storico dell’Occidente, facendo emergere la positività del diritto come la sua realtà effettiva. La ricchezza della filosofia sta nel presentare gli innumerevoli aspetti dello Stesso in guise diversissime, quasi sempre opposte l’una all’altra, in base alla visione particolare e spiccatamente penetrante del singolo filosofo.
Non credo che la filosofia possa ridursi soltanto ad una battaglia dei caratteri umani come vorrebbe Hans Jonas, o alla mera “invenzione di concetti” propugnata da Deleuze e Guattari. Questi aspetti sono certamente importanti e contribuiscono a delineare le infinite sfaccettature dell’avventura storica che la filosofia è. Ma, senza quel potere espositivo, capace di mettere in luce lo Stesso, il destino storico di un’epoca, attraverso opinioni, linguaggi e, a volte, “sistemi” diversissimi tra loro, non si andrebbe oltre una, pur grande, letteratura.
Ecco che, invece, qui si coglie quell’aspetto dello Stesso che ho denominato, in senso lato, “positivismo giuridico”. Esso consiste nella credenza in un centro vuoto di per sé sussistente, una vera e propria ipostasi, che, nelle sue varie formulazioni, ci si presenta come una sorta di fantasma capace di produrre legittimazione.
Legittimazione di che cosa? Di determinate azioni umane dirette ad influenzarne altre. Ed è adesso che, se cerchiamo di guardare appena sotto il nostro naso, ovvero attraverso la nostra esperienza, potremo provare a renderci conto del fatto dell’intangibilità che fonda il positivismo giuridico, l’assoluta discrasia rispetto all’umana esperienza che lo caratterizza. Anche in questi giorni, per fare un esempio, si fa pedissequamente riferimento ai nostri diritti fondamentali sanciti dalla “Costituzione”, o, a volte, in funzione sterilmente polemica, alla “riserva di legge”, e, naturalmente, agli atti normativi del Governo, dai decreti legge agli ormai celeberrimi decreti del Presidente del Consiglio, fino ad arrivare alle sentenze dei tribunali o della stessa Corte costituzionale, ma anche gli atti normativi di Regioni ed enti locali. Quanto qui è stato sbrigativamente elencato costituisce l’armamentario basilare del giurista, alcune delle cosiddette “fonti del diritto”, anche se, ma solo formalmente, le sentenze sarebbero da escludere in un ordinamento di civil law, ma di fatto, come i giuristi sanno bene, vanno incluse eccome (nella teoria kelseniana, su questo, a modo suo, più “realista”, le sentenze sarebbero “norme individuali”). Ma il punto è il seguente: tutto ciò è davvero qualcosa di tangibile e di vivo?
Come una volta scrisse Norberto Bobbio in uno dei suoi saggi kelseniani contenuti adesso in Diritto e potere (2014), riferendosi però alla Grundnorm della dottrina pura, anche nella situazione di cui parliamo qui il giurista positivo si trova davanti al “capo delle tempeste” della sua scienza. Ciò che lo scienziato del diritto afferma è: bisogna fare costante riferimento, ad esempio, ai “diritti fondamentali” sanciti dalla Costituzione, bisogna tener presente gli indirizzi giurisprudenziali della Corte Costituzionale in merito, e il resto… beh, considerare questo resto, ciò che sta sotto il nostro naso, ma che sfugge sempre ai fantasmi che il positivismo porta a spasso come vessilli strappati, questo resto è reputato inutile.
Potremmo tentare di dare un nome al resto; per esempio, adottando il punto di vista delle ipostasi giuridiche, potremmo chiamarlo ingiustizia. Dal punto di vista della giustizia immancabilmente “posta”, propria del positivismo giuridico, la non conformità di un fatto rispetto all’ipostasi della giustizia posta, che può chiamarsi con il nome di “diritti fondamentali costituzionali” o di “sentenza additiva di principio della Corte Costituzionale”, è certamente da considerarsi illegittimo, incostituzionale, illegale, o che dir si voglia. Il resto, ossia ciò che è effettivamente il vissuto reale del singolo, una volta considerato illegittimo rispetto ad una delle ipostasi di turno, non ha una sua ragion d’essere oltre il giudizio – altrimenti detto “qualificazione normativa” – che discende dalla bocca (?) del fantasma giuridico. Nel caso in cui, per fare un esempio non troppo di scuola, si venga selvaggiamente manganellati da qualche poliziotto in un autobus o in un treno perché ci si trova sul mezzo senza biglietto durante l’attuale quarantena, sarà più o meno di questo genere la risposta del giurista positivo: che si inizi un procedimento penale e si accertino le responsabilità. Tutto ciò è formalmente ineccepibile. Chiunque farebbe lo stesso e si rivolgerebbe alla Procura, con ogni probabilità. Cosa succede allora? Il rimedio all’ingiustizia si otterrebbe con l’inclusione del resto, così com’è, in una dinamica in cui un’azione incondizionata, ma che si presume debba essere vincolata all’osservanza della legge e al rispetto dei diritti fondamentali costituzionali, viene giudicata in base alle medesime ipostasi alle quali quell’azione si credeva dovesse essere vincolata. Il fantasma, in un certo senso, si rivolge su se stesso e a se stesso ed emana un giudizio su qualcosa che crede di vincolare, ma da cui si trova totalmente scisso, sganciato irrimediabilmente. Se noi guardiamo al solo fantasma per cercare giustizia e legittimazione otterremo solo un flatus vocis, formule normative o giudiziarie.
Nel caso dell’attuale situazione italiana, questa dinamica fantasmatica si traduce nel disconoscimento dell’essenza storica della Costituzione stessa: questa non è nata da un’operazione di “bilanciamento” di diritti, né da astratte formulazioni, bensì da una lotta storica contro un nemico concreto, da una guerra di Resistenza. L’intera struttura formale del testo approvato il 22 Dicembre del 1947 acquista un senso, un orientamento determinato solo e soltanto a partire dalla Costituzione storica, nata dalla pura eccezionalità dell’evento fondatore che la costituzione formale ci ricorda nella XII disposizione transitoria e finale, la quale vieta la ricostituzione del disciolto Partito fascista. Secondo l’interpretazione giuspositivista, con questa disposizione il legislatore costituente avrebbe previsto una deroga rispetto alla libertà di associazione sancita dall’articolo 18 della stessa costituzione formale. Ma, se guardiamo oltre la dogmatica ipostatica del giuspositivismo, ci accorgiamo che proprio nella XII disposizione transitoria e finale la costituzione formale riporta alla memoria dei cittadini il conflitto estremo da cui è scaturito un novus ordo saeclorum, il quale più che causato, si dovrebbe dire che si è occasionato da un evento eccezionale, strutturandosi in un ordinamento che nega alla radice il suo nemico storico sul quale ha prevalso. La Costituzione storica è l’unica davvero esistente, perché è l’unico evento davvero accaduto, tale da dare un senso determinato ad espressioni contenute nella costituzione formale che, altrimenti, ne sarebbero del tutto prive. Se si disconosce l’evento eccezionale che la Costituzione è, riducendola a una mera “Carta”, come il giuspositivismo deve fare per preservarsi, si giunge ben presto alla miopia etica che fa tutt’uno con il positivismo giuridico stesso: pretendendo e credendo fermamente di guardare ai “fatti”, il giuspositivismo si concentra su statuizioni astratte, ovvero costruzioni evanescenti alla quali si presta fede, che si tengono- per- vere. Wahr-nehmung, la percezione, letteralmente vuol dire proprio questo: è un tenere, un prendere-per-vero, ossia rappresentarsi una costruzione astratta a partire da una somma di tratti comuni riscontrabili nell’esperienza. Il positivismo giuridico, in quanto scienza as-tratta, allontana e separa dall’esperienza alcuni tratti per farne degli universali mentali (ad es. i “principi fondamentali della Costituzione”). E fino a qui non ci sarebbe nulla di strano, trattandosi di un procedimento del tutto naturale per l’essere umano il rappresentarsi gli oggetti dell’esperienza in schemi astratti: la descrizione che, tra gli altri, Hegel fa della Wahrnehmung, nella sua Fenomenologia dello Spirito (1807), ci descrive proprio una simile dinamica. Tuttavia, se questo universale astratto viene scambiato per oggetto di “scienza”, poiché si crede che l’azione degli uomini dipenda e sia condizionata da questi universali (es. dalle norme giuridiche o dalle sentenze giudiziarie) e, di conseguenza, si crede così di stare parlando della “concretezza”, proprio qui si presenta l’idiosincrasia che il positivismo giuridico non può non essere quando pensa “scientificamente”. Credere che le ipostasi giuridiche siano effettivamente reali di per sé, significa non considerare l’ineliminabile scarto che vi è tra un universale astratto (normativo) e la sua esecuzione. Se si giudicherà quest’ultima sussumendola in schemi qualificativi a priori, si trasporrà un fatto sotto la lente di una proposizione sciolta dal fatto medesimo, credendo che il fatto possa esser stato o possa venire in futuro condizionato dalla proposizione. Il fantasma, ancora una volta, si rivolge su se stesso e a se stesso.
- L’idiosincrasia “scientifica”
Da questa credenza derivano tutte le formulazioni “scientifiche” del giuspositivismo. Una molto in voga da sempre, ma ripetuta spessissimo in questi giorni di quarantena, è quella del bilanciamento dei diritti fondamentali in Costituzione: si crede, in poche parole, che “la Costituzione”, intesa solo come “Carta” naturalmente, sia dotata di un suo buon senso, potremmo dire, e, tra le altre sue qualità naturali, che essa “parli” e, stando a ciò che dice, utilizzi una bilancia per stabilire se e quando dev’essere compresso un determinato diritto fondamentale a favore di un altro. Tutto ciò, stando a sentire gli “interpreti”, veri e propri aruspices della ornitologica, ma, attenzione, “immanente” volontà del “costituente”, indicherebbe che i diritti vengono reciprocamente limitati in base alle esigenze dettate dalle circostanze. Nulla prevale e tutto si equilibra nel magico sistema ipostatico, verbale, che la Costituzione presenterebbe da sé, in forza di valori tanto “pregnanti” quanto “tangibili”, sempre a parere della “Carta”…
Preso atto della ricostruzione divinatoria, uscendo soddisfatti dal pensatoio del giuspositivismo, come Strepsiade dopo l’incontro con Socrate ne Le Nuvole di Aristofane, torniamo a casa e ci guardiamo intorno, o, almeno, guardiamo sotto il nostro naso.
Cosa vediamo? Il Parlamento non esercita più alcuna reale attività legislativa autonoma durante lo stato d’eccezione che stiamo vivendo in questi mesi. Certo, neanche prima dello stato d’eccezione degli ultimi due mesi, anzi da più di due decenni a questa parte, si può dire che l’organo centrale di una Repubblica che si dichiara “parlamentare” abbia esercitato pienamente le sue alte funzioni. L’attività di conversione dei decreti-legge governativi appare predominante da anni, pochissimi sono ormai i progetti di legge di iniziativa parlamentare che vengono approvati. La necessità e l’urgenza scandiscono l’attività legislativa della Repubblica. Ma, per tornare agli ultimi due mesi, adesso si vede qualcosa di più: l’annichilimento persino dell’attività di indirizzo del Parlamento sull’attività del Governo. Questa situazione, tra l’altro, non può neppure essere imputata davvero a questo o a qualunque altro Governo: è il Parlamento che sembra aver esaurito la sua funzione storica, da decenni, e, negli ultimi anni, dall’emergenza economica per giungere all’attuale emergenza sanitaria, l’organo in cui, più che in ogni altra istituzione, si dovrebbe concentrare la cosiddetta “sovranità popolare”, contempla la propria agonia politica. Anche qui, da buoni giuspositivisti, dovremmo richiamare noi stessi alla calma, alla pacatezza, ad accogliere l’invito a porgere lo sguardo alla limpidezza del dettato costituzionale al riguardo: poche e scarne disposizioni (artt. 92-96 Cost.) sono dedicate dalla costituzione formale alla disciplina dei poteri del Governo, i quali vengono descritti mediante formulazioni generalissime e vaghe (“direzione della politica nazionale” attribuita al Presidente del Consiglio, etc.), proprio perché si sono voluti limitare i poteri del Governo, dirà il giurista positivo, dopo l’accentramento inverosimile nelle mani di esso durante il fascismo. Certo, un positivista più accorto potrebbe avanzare l’ipotesi che più indeterminati sono i poteri più si autorizza la prassi ad estenderli de facto, traendo profitto dall’indeterminazione stessa. Ma questo, forse, è il massimo che potrà essere affermato dal giuspositivista, azzardando magari dei riferimenti a concetti solitamente presi in prestito dalla filosofia giuridica e dalla scienza politica come la “crisi della democrazia parlamentare” o, addirittura, la “crisi dello Stato di diritto”, formule che, se restano tali, ossia del tutto impensate, condividono con le ipostasi giuridiche la medesima natura fantasmatica.
Ed ecco che, a questo punto, di fronte all’attuale situazione eccezionale, ciò che il giurista positivo vede chiaramente come “un fatto concreto” è un problema di bilanciamento. Davanti a noi, sotto il nostro naso, il resto rimasto impensato dal positivismo giuridico ci mostra una situazione in cui, con alterni risultati, un Governo, in nome della tutela prioritaria della salute, ha deciso che l’esercizio delle altre libertà fondamentali previste dalla Costituzione doveva essere praticamente annullato. Sarebbe del tutto inopportuno dare dei giudizi estemporanei su queste misure, le quali dipendono dallo stato d’eccezione attuale (rimando al mio articolo pubblicato su Endoxa nel mese di marzo: “Finzioni eccezionali”). A tal proposito si è voluto parlare e si parla ancora, usando un evergreen dei mitologemi giuridici, appunto, di bilanciamento. Bisognerebbe immaginare questa scena: se chiunque di noi, fino alla data del 4 Maggio, fosse uscito in macchina soltanto per “prendere un po’ d’aria” come si suol dire, per poi tornare a casa, se fermato dalla polizia, sarebbe stato legittimamente multato. La libertà di circolazione è stata trasmutata dall’interno dallo stato d’eccezione, in cui regola e vita giungono a coincidere, in una sorta di soglia d’indeterminazione, come scrive Agamben in Stato di eccezione (2003).
Ma non è necessario scomodare le raffinate analisi agambeniane. Poter circolare solo al verificarsi di determinate condizioni previste da un atto normativo del Governo (riassumibili nell’adempimento delle funzioni necessarie alla sopravvivenza: salute, lavoro, approvvigionamento alimentare) non significa poter circolare: una vera libertà di circolare non può essere necessariamente vincolata all’assolvimento di attività volte al mantenimento del mio sostrato biologico.
Parlare di bilanciamento può risultare un buon modo di parlare per metafora, ma è lontano anni luce da una qualsiasi possibile concretezza.
Di fronte a una prassi incondizionata, il centro vuoto costituito dai dogmi (perlopiù) normativi del giuspositivismo ci mostra la sua funzione storica: la produzione di legittimazione di una prassi incondizionata, che non ha effettivamente bisogno del centro vuoto, ovvero, non ha bisogno, ad esempio, dei principi costituzionali per essere portato ad esecuzione. Le ipostasi giuridiche serviranno, allora, solo a legittimare, per il tempo necessario, la prassi incondizionata dell’autorità governativa, la quale si attua concretamente nell’azione delle forze di pubblica sicurezza, come lo stato di eccezione che stiamo vivendo paradigmaticamente ci insegna. Walter Benjamin, non a caso, in Per la critica della violenza (1921), individua nella polizia, e nella sua “presenza spettrale”, la vera forza motrice del diritto statale.
Ciò non toglie che, una volta tramontato lo stato di eccezione, le leggi di conversione dei decreti legge del Governo potranno essere dichiarate incostituzionali, determinati agenti o ufficiali delle forze dell’ordine potranno essere processati per gli abusi, si faranno ricorsi amministrativi al Tar o al Consiglio di Stato per invalidare atti amministrativi vari, etc. Il fantasma, di nuovo, si rivolgerà a se stesso. Ma, per la durata dell’esecuzione, dell’attuazione della prassi incondizionata, nulla potrà essere invalidato a partire dalla considerazione di proposizioni normative scritte e solenni ragionamenti basati su mitologici principi e bilance. L’unico limite reale, forse, sembrerebbe davvero costituito da un misto di timore e di buon senso dei singoli “rappresentanti della legge”, ma, come garanzia reale contro una prassi svincolata da universalità astratte, è davvero troppo poco. Non si può pensare seriamente che dei meri fantasmi linguistici costituiscano un reale limite ad una prassi di polizia che, nella sua concreta esecuzione, per definizione, non conosce limiti a priori.
Ma, a questo punto, il buon senso del giurista (o del filosofo del diritto), che magari si professa anti-formalista e anti-positivista tout court, potrebbe invitarci alla moderazione, dicendo: “Sarà pur vero che ci sono stati degli abusi in questa situazione, ma, se guardiamo alle statistiche, ai grandi numeri, si tratta pur sempre di casi sparuti, marginali, qualche migliaio, forse centinaia… Non è importante, il punto è che le misure stanno funzionando, i cittadini sono perlopiù responsabili, i principi costituzionali guidano costantemente la prassi, e, diciamocelo pure, lo stato di eccezione non esiste!”.
Una volta giunti alla negazione radicale del fatto che, in questo momento, la popolazione stia vivendo una vera sospensione dell’ordinamento costituzionale – ossia, lo stato di eccezione – forse si realizza il vero compimento, il pleroma del positivismo giuridico. Tanta è la repulsione idiosincratica per il nudo e schietto fatto di verghiana memoria, da credere che l’esercizio delle libertà costituzionali sia tutto sommato sempre posto sotto la guida saggia della “Carta costituzionale”, tale che non si possa davvero parlare di uno stato di eccezione. Ma, sia detto solo di passaggio, sarebbe giusto far presente al nostro ipotetico interlocutore che lo stato di eccezione non è una situazione totalmente altra rispetto all’ordine costituzionale concreto, bensì consiste in una una dinamica nomotetica inscritta nella medesima struttura storica della Costituzione, ma certamente non interna alla mera costituzione formale. Tuttavia, il giuspositivista tenderà, perlopiù, a credere fermamente che le ipostasi giuridiche che tanto gli stanno a cuore, ma che vengono travolte assai facilmente da un tratto di penna alla Kirchmann o da una manganellata, sussistano comunque, anche quando non se ne vede più l’ombra, e, se magari si verificano abusi e “violazioni dei diritti”, beh, ci si rivolgerà, a tempo debito, magari “quando l’emergenza sarà finita”, ai patri Tribunali… Le violazioni, certo, saranno qualche migliaia, forse centinaia, ma, d’altronde, lo “scienziato” del diritto deve guardare ai grandi numeri, a ciò che è rilevante in termini statistici, mentre il resto, appunto, ormai lo sappiamo, è inutile ai fini di una “vera scienza”, i singoli casi sono davvero fuori legge, hors de la loi.
Insomma, la formula del giuspositivismo potrebbe così riassumersi: se i fatti contraddicono la regola, tanto peggio per i fatti!
Quest’ultima formula (“Tanto peggio per i fatti!”) sembra attagliarsi davvero bene al positivismo giuridico. Non si sa se realmente i personaggi a cui la frase è stata attribuita l’abbiano mai pronunciata, probabilmente no. La si attribuì a Fichte, a Hegel, e, più recentemente, a Emanuele Severino: pettegolezzi filosofici.
Ma questa impossibilità di attribuzione a una persona, a un chi determinato, ci mostra la recondita sottigliezza di questa sorta di aforisma senza autore, la performatività di questa frase: la sua stessa formulazione linguistica è immediatamente efficace, non c’è davvero alcun fatto (chi l’ha detta?), ma l’assenza di un fatto diventa l’unico fatto rilevante (positivismo giuridico).
La scissione, l’isolamento da qualsiasi tipo di fatto per rifugiarsi nella pura ipostasi linguistica che la frase rappresenta, non ci permetterà mai di stabilire se, da qualcuno di coloro a cui fu attribuita, fu davvero pronunciata.
Che ne è, alla fine, del resto?
DIRITTO Endoxa FILOSOFIA POLITICA Andrea Raciti DIRITTO endoxa maggio 2020 idiosincrasie Kelsen

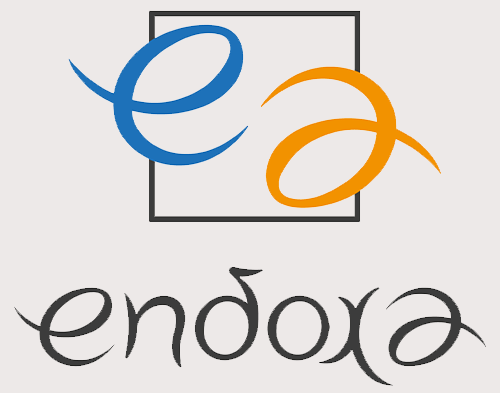
Quando si tratta di vivificare qualcosa che, nel sentire comune, aleggia nelle stanze delle astrazioni e del linguaggio puro del diritto, bisogna avere il coraggio e la “sfrontatezza” di tagliare le “siepi” ben curate della scienza giuridica. Ciò che appare “positivo” svela di sé, sottoposto al taglio alla radice, una sua negligenza necessaria che lascia al di là di sé, del puro sé, la carne e il cuore del singolo.
"Mi piace""Mi piace"