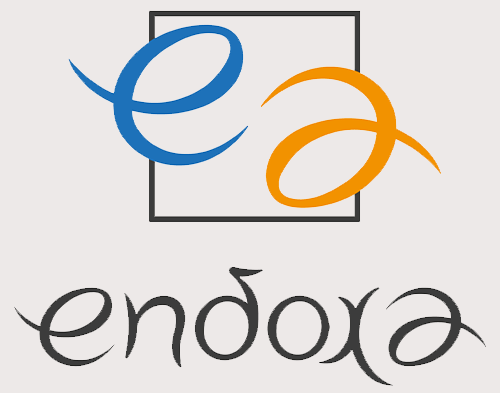VERBA VOLANT: QUANDO IL PLAGIO ERA NATURALE E NECESSARIO
 PAOLO CASCAVILLA
PAOLO CASCAVILLA
Mi trovavo a Palermo, anni fa, commissario agli esami di maturità. Ero in un camping nel parco della “Favorita” e l’ultima sera il custode con la moglie volle preparare una “spaghettata”, oltre a me e mia moglie vi era pure una coppia di Torre Pellice (TO). Mi venne in mente un aneddoto, che mi era stato raccontato come “fatto vero”, accaduto nel Tavoliere di Puglia e attribuito a persone precise e conosciute. Il padrone ospita a pranzo i mietitori e prepara “acqua e sale” con le uova. Una zuppa con cipolle, prezzemolo, olio e… un solo uovo. Per sette-otto persone! Tutti intorno al tavolo, nell’unico grande piatto bagnano e mangiano il pane e nessuno, per delicatezza, tocca quell’unico uovo. Arriva il padrone: “E la crascia puttana… che non debbano avanzare le uova?”. Prende la forchetta e mangia l’uovo. Le ultime parole furono coperte dalle voci delle due coppie che all’unisono mi anticiparono, sorridendo, dicendo che questa storia si racconta anche da loro, è una loro storia. Ci rimasi male. Provai verso la fine della serata con un altro aneddoto. Quella di un raccoglitore di olive che, intravisti nella pentola pezzi di lardo, comunica ai suoi compagni questa scoperta. Tutti lavorano con buona lena… Quale delusione quando si trovano nei piatti pezzi di zucca bollita. Anche questo aneddoto terminò come il precedente.
Aveva ragione Propp? Le fiabe hanno radici comuni, pur provenendo da paesi molto diversi e lontani? Non prodotti di fantasia, quindi, ma documenti di età antiche, prima anche della pastorizia e dell’agricoltura. Per cui invece di chiedersi da dove quella fiaba proviene, occorre interrogarsi a quale tempo e a quale evoluzione storico sociale possono risalire i contenuti e i singoli elementi costitutivi.
Le fiabe, le storie, i proverbi volano sulla bocca degli uomini. Vengono da un passato non definibile e circoscrivibile. Omero parla di parole alate. “Verba volant, scripta manent”. E’ possibile comprendere questa espressione in modo diverso? Non solo come diffidenza verso la parola che passa da una bocca alle orecchie di uno o di molti, e fiducia verso la parola scritta, immutabile e stabile. Potrebbe significare anche la leggerezza della parola che si sposta, vola libera, rispetto alla rigidità e alla pesante concretezza della scrittura.
La parola nella cultura orale è suono, nasce da situazioni concrete, da una interazione immediata tra esseri umani, ed è per questo agonistica, enfatica, ridondante, gestuale. Assicura la coesione sociale dentro la tribù, Il villaggio, il paese. Non è vero che sia sconnessa, questa impressione deriva dalla trascrizione che registra pause, esitazioni, le forme dell’intercalare tipiche dell’oralità… Parlare e scrivere sono due registri diversi. Senza compiere schematizzazioni nette non è possibile parlare come si scrive o scrivere come si parla. Anche se ci sono opere letterarie che hanno cercato di riprodurre i moduli linguistici della lingua parlata. In Italia “I malavoglia” del Verga. Un romanzo verista, costruito con i proverbi, le inciurie (i soprannomi), le espressioni formulaiche, che racconta le vicende di una famiglia patriarcale in una comunità arcaica e chiusa, priva di elaborazioni ed espressioni soggettive e personalizzate. Un romanzo corale che deve mostrare d’essersi fatto da sé, senza il peccato d’origine di un narratore – Dio, che conosce l’animo, i sentimenti, i pensieri dei personaggi.
Se pure è storicamente certo che con la scrittura nasce la filosofia, la matematica, la geometria… I missionari cattolici in America latina ammirano la capacità di argomentare degli indigeni che vivono in un mondo di cultura orale primaria (in totale assenza di scrittura); non conoscono la ruota ma sono abili nella pratica della diplomazia, della convivenza con gli europei che hanno secoli di cultura della scrittura alle spalle. Alla scrittura appartiene il sillogismo, al mondo dell’oralità gli indovinelli, gli stornelli… usati per sostenere vere e proprie battaglie orali. Dire un proverbio significa spesso sfidare l’altro a rispondere con uno più appropriato.
La lingua orale si rivolge a un uditorio, a persone che ascoltano, annuiscono, dissentono immediatamente con gli occhi, con il capo, ed è per questo che abbiamo ripetizioni, epiteti, formule, espressioni aggregative che permettono più facilmente di ricordare paesaggi, situazioni, e soprattutto i personaggi, che escono fuori dalla normalità (le figure incolori non sopravvivono nel ricordo). Uno stesso aggettivo li accompagna e li fissa nella memoria: l’astuto Ulisse, il piè veloce Achille, il saggio Nestore, il prode Orlando… Modalità che troviamo in Omero, Gilgamesh, Le mille e una notte, Chanson de Roland…
La ridondanza è data dalla presenza del pubblico e chi parla deve pensare a ciò che ha detto e a quello che deve dire. Pause ripetitive per richiamare alla memoria alcuni elementi fondamentali della narrazione, pause di cui si giovano anche gli uditori, per mettere ordine nella storia che ascoltano, in quanto non possono ripassarla e rileggerla su un supporto scritto. Si erano aggiornati, invece, gli ultimi cantastorie delle feste popolari del Sud quando usavano pannelli con disegni che sottolineavano i momenti salienti della storia raccontata.
Ma l’oralità include anche i gesti, la voce, l’espressione del viso e l’intero mondo esistenziale e umano. Impegna tutto il corpo. L’attività corporea non è un elemento aggiuntivo, esterno, è una componente naturale, necessaria e inevitabile. Nell’espressione orale, specialmente se pubblica, la stessa immobilità è di per sé carica di significato. Nelle culture orali le controversie dipendono dall’uso efficace delle parole, dall’interazione, dalla recita… Come nelle fiere di paese, i mercati all’aperto. Nei quali l’acquisto di qualcosa non è mai una semplice operazione economica, quanto una serie di manovre e finzioni, una gara di abilità, di agonistica orale.
La comunicazione orale vive in un equilibrio che elimina le parole che non hanno più rilievo per il presente. Non ha un dizionario, vive nella “ratifica semantica diretta”, cioè nelle situazioni in cui la parola viene usata, e, se non viene compresa, si sostituisce immediatamente o si spiega con una perifrasi.
Il plagio c’è e non c’è. C’è perché la storia può essere simile, le parole le stesse, ma il racconto è diverso. “Lo cunto è nente, tutto sta come lo cunto se porta”. Dice una narratrice popolare siciliana a Leonardo Sciascia.
La memoria occupa un posto centrale nella cultura orale ed è per questo che nel pantheon greco c’è una divinità per una funzione psicologica. Mnemosine è dea ed è la madre delle muse. La memoria possiede mezzi e sostegni mnemotecnici, ancora oggi riconosciuti: antitesi, allitterazioni, assonanze. Il fine è ricordare e aiutare le persone e la comunità a conservare il passato individuale e collettivo.
Come funziona la memoria nelle culture orali? Noi conosciamo come funziona nella cultura della scrittura, con la presenza di un testo che permette il confronto e ne verifica la fedeltà. I cantastorie e i poeti popolari hanno una memoria agile, ascoltano altre storie e poi fanno “rapsodie”, preferiscono ripetere la storia dopo due o tre giorni e mai allo stesso modo. La loro è una ripetizione creativa nella quale è essenziale l’immedesimazione emotiva e passionale. (Ong, Havelock …)
E’ plagio? Non c’è un supporto certo che permetta di misurare e fissare i paletti della “lezione corretta”, come avverrà con la scrittura, che toglie la parola dall’arena, dove gli esseri umani si incontrano e si scontrano, la raffredda, la mette nel “freezer”, e poi chi vorrà potrà scongelarla quando e come vuole.
La cultura orale è conservatrice e poco creativa? Di certo le energie sono utilizzate per ricordare e trasmettere le conoscenze da una generazione all’altra. Nelle botteghe artigiane il rapporto da maestro ad allievi – apprendisti avviene attraverso l’imitazione quotidiana, la comunicazione di tecniche, segreti… L’istruzione possiede stabilità, gesti e parole ripetute da generazioni con fedeltà e senso di appartenenza.
C’è creatività e originalità? L’originalità non consiste nell’inventare nuove storie, nuovi personaggi, ma in un diverso modo di interagire con il pubblico e nell’adattare la storia alle vicende della comunità. La creatività non è un fulmine illuminante; è invece fusione faticosa e personale dello stesso materiale, è davvero come la gravidanza di cui parla Rilke.
La consapevolezza di un impasto di materiale appartenente alla comunità è evidente nelle culture africane, nelle tradizioni orali, dove narrazione e narratore costituiscono un legame stretto.
L’antropologo Marco Aime racconta l’incontro all’Università di Torino con lo scrittore nigeriano Amos Tutuola, autore del libro “Il bevitore di vino di palma”. Sottoposto a domande di tipo accademico, Totuola si sentiva a disagio, continuava a ripetere che lui in fondo era solo un panettiere, che aveva impastato storie da lui ascoltate nel suo villaggio. L’imbarazzo era evidente. A un certo punto venne invitato a raccontare una delle sue storie. La sala, dopo un attimo, era piombata in un silenzio assoluto. “Tutuola parlava un pidgin spesso incomprensibile, ma quel volto, la sua voce, il suo corpo evocavano personaggi magici e feroci, donne, uomini, dei con una potenza inaudita”. Nella tradizione africana, in tutti i popoli a cultura orale la comunicazione non è solo orale, è soprattutto teatrale, il gesto accompagna e spesso precede la parola. Il corpo diventa tutt’uno con la voce e il narratore si fonde con la narrazione.
Anche il premio Nobel della letteratura del 1986, Wole Soyinka, sottolinea che vi è continuità tra tradizione orale del suo popolo (Yoruba) e le sue opere teatrali. Il narratore non realizza il racconto con la parola, ma dà vita a una performance mimica e vocale rivolta a rendere più efficace la storia. Narratori che hanno una memoria notevole, la quale non ripete, ma seleziona, sceglie, rinnova.
Il plagio nella cultura orale è il motore della coesione sociale, è conservazione, tradizione, contaminazione (come nel teatro antico), ma apre spazi di creatività e mantiene vivo lo scambio delle idee e delle conoscenze.
Il plagio inizia a porsi come problema con la diffusione del testo scritto. C’è un simpatico scontro tra cultura orale e cultura della scrittura nel film “Il postino”, l’ultimo di Massimo Troisi. Mario Ruoppolo è assunto come postino per consegnare la posta a Pablo Neruda in esilio in quell’isola. Mario è colpito da quante persone scrivono al poeta, donne in particolare. Si innamora, nel frattempo, di Beatrice Russo (Maria Grazia Cucinotta), nipote della proprietaria della locanda. Inizia a corteggiarla e chiede al poeta di aiutarlo, scrivendogli una poesia da dedicarle. Mario fa passare la poesia come sua, Pablo Neruda lo rimprovera, ma lui risponde sorpreso e risentito: “la poesia non è di chi la scrive, ma di chi se ne serve”.
Credo che il primo a parlare di plagio sia stato Marziale nel libro I degli epigrammi (LII). I suoi epigrammi girano per Roma, ma c’è chi se ne appropria e li fa passare per suoi. Si rivolge a Quinziano al quale affida i suoi libri, se è lecito chiamarli così, visto che li declama un altro poeta. “E se chi li declama dirà di essere il loro padrone, /tu devi dire che sono miei, che io li ho liberati. / Se dirai questo più di una volta a voce alta, / costringerai il plagiario a provare un po’ di pudore (impones plagiario pudorem)”. Non interventi legislativi o punitivi. Solo un pizzico di vergogna.
“38/52 Verba volant scripta manent” by Tomás Morales Herrera is licensed under CC BY-SA 2.0
ENDOXA - BIMESTRALE LETTERATURA Endoxa marzo 2021 Paolo Cascavilla Plagio