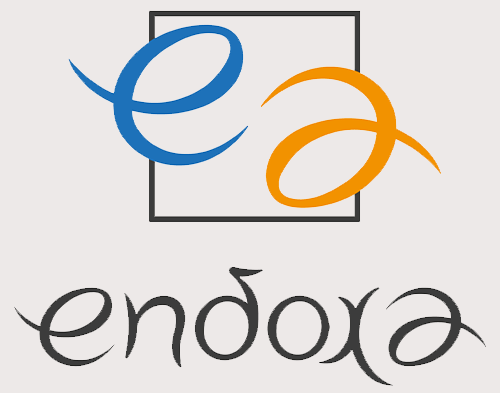IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI? BARUCH SPINOZA E LA “NAVE DEI FOLLI”
 DANIELA BOSTRENGHI
DANIELA BOSTRENGHI
Può forse stupire il richiamo a Spinoza, adamantino filosofo del metodo geometrico e della lucida chiarezza delle sue argomentazioni, in un discorso dei nostri giorni sulle prospettive della devianza e, nello specifico, della follia. Rischieremmo, così, di fraintendere il suo pensiero cercandovi l’adesione ad un’etica normativa (e normalizzante) che non sembra essere – soprattutto dopo la lettura novecentesca di Deleuze – quella dell’ebreo olandese, allontanato a ventiquattro anni dalla Comunità ebraica di Amsterdam con l’accusa di eresia, la più grave, all’epoca, delle “devianze”. Una “anomalia” di pensiero (per usare il linguaggio di Negri) che gli procurò in Europa la fama di maledictus (maledetto), ma anche quella di “ateo virtuoso”, come ebbe a scrivere Pierre Bayle nel suo celebre Dizionario storico-critico. Profondo conoscitore delle opere di Spinoza e delle biografie redatte dai suoi contemporanei, Bayle evidenziava infatti il contrasto tra la vita esemplare, schiva da ogni forma di mondanità ma non per questo disinteressata alle cose del mondo, del filosofo di Amsterdam e lo scandolo della sua dottrina portatrice, a suo parere, di ateismo sistematico (una posizione che, all’epoca, neppure gli spiriti liberi, come lo stesso Bayle, potevano tollerare).
Quanto alla follia, in uno scritto giovanile sul metodo dalle implicite ascendenze cartesiane, Spinoza fa notare come gli uomini quantomeno conoscono la natura e le sue leggi determinate e necessarie, tanto più possono “fingere” (cioè rappresentare a sé come presenti facendo ricorso all’immaginazione) molte cose che possono apparire se non altro bizzarre: che gli alberi parlino, che essi stessi si trasformino improvvisamente in pietre e fonti, che appaino fantasmi negli specchi, che il nulla diventi qualcosa, che gli dei si trasformino in bestie e queste, a loro volta, in uomini. Una sorta, insomma, di “sognare da svegli” che addirittura lo induce ad accomunare l’errore che porta con sé l’idea “fittizia” (di cui in questo luogo, sulla scia del razionalismo cartesiano, si tratta) ad un vero e proprio “delirio”, dal quale la mente è occupata e talvolta, addirittura, sopraffatta.
Si avverte in queste pagine dedicate – con evidenti echi baconiani – alla ben nota “emendazione dell’intelletto”, una dimensione della finzione, del delirio e del sogno che evoca al nostro immaginario l’allucinato universo pittorico di Jeronymus Bosch, piuttosto che la quiete composta di alcune vedute del contemporaneo Johannes Vermeer, nato a Delft lo stesso anno in cui, ad Amsterdam, nasceva Baruch Spinoza. Nel dipinto attribuito al pittore fiammingo, esposto al Prado, che rappresenta la scena – assai diffusa all’epoca – della Cura della follia, le mani del chirurgo estraggono un oggetto dal capo di un uomo, come se la follia fosse qualcosa di estraneo alla mente umana, dalla quale va dunque “estirpato”, “emendato”, allontanato ed espunto. Un rituale che i guaritori del tempo (il dipinto di Bosch risale alla fine del XV secolo, momento del delicato passaggio dal tardo medioevo alla modernità) non esitavano a praticare, in forma simulata e con scarsi risultati, come diverse narrazioni polari di quegli anni tramandano. Al lettore attento non sfugge, d’altra parte, come nell’incompiuto Trattato sull’emendazione dell’intelletto, dove l’idea “fittizia” è nettamente distinta dalla “vera” e l’errore non è ancora inteso, come in seguito, quale privazione (attuale) di conoscenza, Spinoza non esiti a individuare una decisa alterità tra immaginazione e intelletto, stabilendo così una netta linea di demarcazione tra la follia e la sana costituzione della mente, con la quale è identificata la ragione stessa, il cui sonno, secondo uno dei celebri Capricci di Goya (la cui spiegazione autografa si trova, di nuovo, nelle stanze del Prado), “genera mostri” e fantasmi.
Con intonazione polemica e i toni accesi che gli sono tipici quando denunzia le nefaste conseguenze del pregiudizio e della superstizione, Spinoza fa ricorso di frequente al lessico della “follia”, del “delirio” e del “sogno” anche nella Prefazione al Trattato teologico-politico. Qui, nel corso della ben nota difesa della libertà di pensiero ed espressione, lo “sragionare” è attribuito non tanto e non solo alle masse superstiziose e alla loro indole mutevole. Follia e delirio sono anche l’atteggiamento dei teologi, quando cercano di “piegare” le Scritture alla loro autorità e interpretazione e quello di coloro che – facendo leva sulla superstizione e sulle false credenze – tendono a governare gli uomini con la paura, piuttosto che liberare le loro menti (e i loro corpi) dai fantasmi e dalle catene che la paura, passione triste per eccellenza, produce.
Nell’Etica, l’opera cui Spinoza lavorò tutta la vita senza però darla alle stampe per motivi precauzionali dopo le molte confutazioni e condanne che fecero seguito alla pubblicazione del Trattato teologico-politico, non c’è una trattazione esplicita della follia, che pure qualche volta vi viene menzionata, seppure incidentalmente. La “definizione generale degli affetti” che conclude la terza parte dello scritto, enumerandone ben quarantotto tipologie che, a loro volta, possono combinarsi tra di loro all’infinito, non ne prevede un’analisi specifica. Ciò che a Spinoza interessa evidenziare qui della follia è (come già per Hobbes) una sua connotazione quantitativa, non qualitativa, che la riconduce non tanto a una malattia (morbus) o vizio (vitium) che corromperebbe la nostra natura alterandone l’essenza, quanto a un “eccesso” di passioni: la follia o il delirio implicano, piuttosto, una sorta di ‘fissità’ dell’immaginazione che, perdendo di vista l’intero, si sofferma su una parte rivolgendo il suo sguardo a un solo oggetto, o a un aspetto parziale di esso (es. nella “folli amorosa” o nelle forme del fanatismo e dell’ammirazione). Ecco allora spiegate, con metodo geometrico e senza esprimere su di esse un giudizio morale, la superbia (una specie di “delirio”), l’avarizia, l’ambizione, insomma quelle passioni che ci rendono “schiavi” poiché riducono la nostra potenza e il nostro “sforzo” (conatus) per conservare noi stessi (con Nietzsche) secondo ciò che siamo. Una spiegazione che chiama direttamente in causa l’ontologia spinoziana e, nel suo contesto, l’analisi del diritto naturale individuale svolta nel cuore argomentativo del Trattato teologico-politico. La natura di ciascuno – leggiamo in un delicato passaggio del capitolo XVI – è determinata dalle leggi necessarie della sostanza, che circoscrivono e de-limitano l’umana potenza, così come di qualunque altro “modo” della sostanza, frammento finito della potenza divina del tutto: “né qui – afferma Spinoza senza ambiguità – riconosciamo alcuna differenza tra gli uomini e gli altri individui della natura, né fra gli uomini dotati di ragione e quelli che ignorano la vera ragione, né tra gli idioti (fatuos), i pazzi (delirantes) e i sani di mente (sanos). Tutto ciò, infatti, che ciascuna cosa fa secondo le leggi della sua natura, questo fa di pieno diritto, in quanto agisce nel modo in cui è determinata dalla natura, né può fare altrimenti”.
Assai prima dell’antipsichiatria novecentesca, come ha giustamente sottolineato Giuseppe Semerari in contributo dei primi anni Ottanta, presentato in occasione del 350° anniversario della nascita del filosofo di Amsterdam, Spinoza “parifica, sul piano della natura, sani e malati di mente come modi diversi della complessiva potenza di esistere e di operare della Natura, gli uni e gli altri altrettanti diritti naturali. Per la prima volta nella storia, e in un’epoca dominata dalla concezione etico-metafisica della malattia mentale – la malattia mentale come non essere, colpa e peccato – al folle viene riconosciuta una positività, che è la positività del suo diritto naturale, della sua potenza di esistere e di operare in un certo modo”. Una positività che va senz’altro ricondotta, come già scriveva Basaglia, nell’ambito di “una condizione umana”, che in noi “esiste ed è presente come lo è la ragione”.
Nessuna Nave dei folli, di nuovo con la pittura di Bosch, solcherà dunque l’oceano infinito della sostanza spinoziana e dei modi, nel quale ciascuno di noi “fluttua” oscillando, per sua natura, tra speranza e paura, immaginazione e ragione. Nessuno “strano battello ubriaco”, carico delle debolezze e delle intemperanze degli uomini – per usare le parole di Foucault, che ne descrive l’ “equipaggio insensato” – verrà sospinto dalla corrente e dal giudizio del mondo verso mete lontane, simbolo di allontanamento e, insieme, di purificazione. Consapevole del carattere determinato della natura umana, che è la natura finita del “modo”, Spinoza si sforzerà nell’Etica di “non ridere né piangere” sulle azioni umane, ma di “comprenderle” (intelligere). In natura, non manca di farci notare più volte, nulla può essere attribuito a un suo “vizio” o difetto. Le nozioni di “bene”, “male”, “merito” e “peccato”, “ordine” e “confusione”, “bellezza” e “deformità” non sono – per l’ateo virtuoso del cui pensiero Bayle intuì lo scandalo – che pregiudizi dovuti al fatto che gli uomini, il più delle volte, “nascono ignari delle cause delle cose” e degli affetti e delle passioni che costitutivamente li attraversano. Nel loro equilibrio ‘metastabile’, del quale a suo tempo alcuni interpreti hanno trattato, queste nostre, per così dire, perturbazioni, “conseguono dalla stessa necessità e virtù della natura dalla quale conseguono le altre cose singolari; e perciò riconoscono certe cause, mediante le quali sono compresi, e hanno certe proprietà, degne della nostra conoscenza a pari titolo delle proprietà di qualunque altra cosa, dalla cui sola contemplazione triamo diletto”. Spinoza, dunque, così come il suo contemporaneo Vermeer, può rivolgere alla natura umana (con il prezioso aiuto del metodo geometrico), uno sguardo disincantato e lucido che gli permette di cogliere questa stessa natura o “essenza” sotto la specie dell’eternità. La realtà, in ogni sua forma è, sia per l’uno che per l’altro, perfezione. Una perfezione da rappresentare con gli occhi della mente, in assenza di giudizio morale e senza alcuna forma di irrisione o condanna, nella profonda comprensione della dignità del finito.
Con la stessa perizia con cui Vermeer si cimentò con l’uso della camera oscura, Spinoza, molatore di lenti e filosofo, tratta dunque degli affetti e delle passioni “come se fosse questione di linee, di superfici e di corpi”, offrendo al lettore dei nostri giorni gli strumenti necessari per un superamento del pregiudizio relativo alla sofferenza psichica e alla dimensione altra della follia. “Se la ragione esiste – scriverà tre secoli dopo Foucault – essa consiste proprio nell’accettare questo cerchio continuo della saggezza e della follia, nell’essere chiaramente coscienti della loro reciprocità e della loro impossibile separazione”. Come volevasi dimostrare, direbbe il filosofo dell’Etica a conclusione di una delle sue geometriche proposizioni.
“2018 – Amsterdam – Baruch Spinoza” by Ted’s photos – For Me & You is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA Daniela Bostrenghi Endoxa maggio 2021 Freaks/Devianze