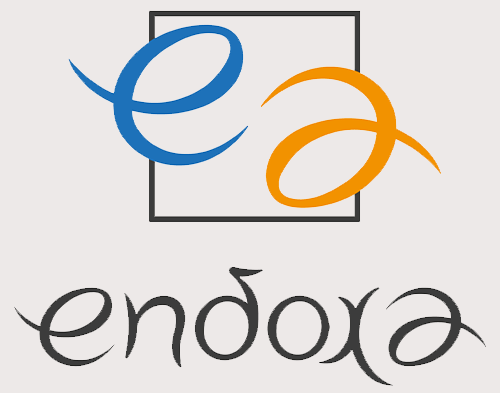DELL’INTUIZIONE MORALE: CONTRO IL CONSEQUENZIALISMO (E I DONALD TRUMP)
FERDINANDO MENGA

Immaginiamo il seguente scenario che, per quanto semplificato, risulta non troppo distante, nei suoi contorni generali, dalle sfide morali a cui la realtà contemporanea ci pone di fronte: assumiamo infatti che una determinata generazione sia chiamata a decidere tra politiche energetiche alternative da adottare. Da un lato, può propendere per una politica maggiormente improntata allo spreco – che possiamo chiamare politica A –, con più elevati benefici per i presenti e maggiori svantaggi per i futuri e, dall’altro, può optare per una politica di risparmio e sostenibilità – che contrassegniamo come politica B –, più votata al sacrificio per i contemporanei a fronte di maggiori benefici per soggetti a venire. Evidentemente, il risultato della politica A sarà quello di generare un più elevato standard di vita per la generazione attuale e probabilmente anche quello d’incentivare, nell’immediato, il concepimento di un numero maggiore di soggetti rispetto a quello che ci sarebbe se fosse adottata la politica B. Attuando la politica A si avrebbe dunque non soltanto un maggiore numero di soggetti totali, ma anche un maggior numero totale di soggetti felici o soddisfatti nel presente. La politica A, però, come appena rilevato, risulterebbe chiaramente in una disponibilità di risorse e qualità di vita inferiori per le generazioni future rispetto a quanto si avrebbe se si decidesse per l’opzione B.
Quale politica adottare, dunque? Ebbene, a tutta prima, sembrerebbe non esserci dubbio alcuno. Nonostante tutto, la conclusione più intuitiva parrebbe essere quella che invita a propendere per l’opzione B, proprio in base ad un ponderato giudizio di responsabilità che mira a garantire il massimo grado di benessere per le vite future, malgrado questo comporti sacrifici per i presenti. Questa propensione morale sarebbe, peraltro, ulteriormente incentivata dalla considerazione secondo cui molte azioni a esclusivo beneficio per il presente potrebbero implicare svantaggi irreversibili per i futuri.
Giusto per dare una connotazione maggiormente concreta a questo quadro, possiamo ipotizzare che sia stato proprio questo tipo di spinta morale ad aver giocato un ruolo decisivo nel tentativo attuato, qualche anno fa, dal presidente Obama – e radicalmente sconfessato dal suo successore alla Casa Bianca – di realizzare una decisa inversione di tendenza nella politica energetica statunitense – per quanto poi, nello specifico, si possa obiettare che siffatto tentativo sia risultato, in ultima analisi, in una green politics molto più tiepida e timida di quanto ci si sarebbe augurato. Il punto fondamentale comunque resta fermo anche in questo contesto: a prescindere dalle sue specifiche forme di realizzazione, a far propendere per l’opzione B rispetto a quella A è l’effettiva operatività di un profondo e intuitivo sentimento morale.
Sennonché, proprio rispetto a questa prospettiva connotata da siffatta solida certezza, almeno due considerazioni andrebbero compiute, non tanto per amore di complicazione delle cose – da cui talvolta l’esercizio teorico è animato –, quanto piuttosto per far emergere in tutta la sua portata concreta l’aspetto “ripugnante” di alcuni scenari, che è bene non nascondere a noi stessi visto il loro indubitabile carattere di attualità.
La prima considerazione non risulta in altro che nella semplice registrazione di uno stato di fatto altrettanto diffuso a livello sociale e istituzionale rispetto alla tendenza morale or ora riportata e che la sconfessa nel modo più eminente: oggi più che mai, infatti, l’assunzione generalizzata di responsabilità a beneficio dei futuri – appena richiamata in tutta la sua immediata forza di appellatività – parrebbe smentita da politiche di welfare che, pur di preservare diritti acquisiti e prerogative oramai consolidate, si rivelano assolutamente impermeabili rispetto al compito di porre un serio freno al trasferimento di enormi oneri sui futuri. Questo atteggiamento orientato a far pagare alle coorti dei nostri discendenti il conto del nostro attuale benessere – fenomeno divenuto oramai celebre nella letteratura internazionale nei termini di buck-passing – rivela così una vera e propria “corruzione morale” dei contemporanei. La chiama in questo modo il filosofo morale statunitense Stephen Gardiner, sottolineandone il sincero sentimento di ripugnanza che questa suscita in non pochi di noi. Sì, probabilmente si tratta del medesimo sentimento di ripugnanza che in molti ha suscitato la decisione di Trump – sopra richiamata – di azzerare gli sforzi profusi dal suo predecessore verso una politica energetica di maggiore sostenibilità.
In linea con questa prima considerazione, non sarebbe dunque troppo peregrino mettere tra parentesi ogni certezza e chiederci cosa sia davvero a prevalere e ad avvicinarsi maggiormente alla nostra inclinazione antropologico-morale di fondo: se sia l’intuitivo appello alla cura responsabile nei confronti dei futuri – di cui la politica di Barack Obama, come abbiamo visto, trasmette un qualche riverbero – o se non sia piuttosto la sfrontatezza (spesso) mostrata da Donald Trump, da donde l’ipotesi che quest’ultima più che stridere con la diffusa sensibilità di molti contemporanei, in fondo ne realizzi, depurata da ogni ipocrisia, la più profonda e segreta aspirazione “tirannica” tutta concentrata su una primazia del presente a scapito del futuro.
Ma si sa, visto che – come ci rammenta Kant – l’umanità può ben essere paragonata ad un “legno storto” allorquando si tratta di irreprensibilità e coerenza morali, le conclusioni ripugnanti a cui la considerazione or ora richiamata conduce consentono ancora una via d’uscita. Difatti, si può sostenere che è proprio perché la corruzione morale può sempre portare ad aberranti derive che si necessita una rigorosa strategia di argomentazione etica atta a riorientare verso il più genuino e corretto sentimento morale.
Sennonché, è esattamente a questo livello che entra in scena la seconda considerazione che lo scenario sopra richiamato suscita. E qui le cose si fanno assai più difficili. Sì, perché un raffinato consequenzialista morale qual era Derek Parfit, proprio mettendo in moto una delle più poderose riflessioni morali – nota come Non-Identity Problem –, ci avverte che l’opzione per la politica B – quella che suggerirebbe sacrifici per i presenti a beneficio dei futuri – non è per nulla scontata e non è nemmeno quella davvero moralmente accettabile, una volta che si resiste alla corruzione dettata dall’egoistica stortura dell’animo umano. Anzi, è la “conclusione ripugnante” suggerita dalla politica A quella a cui, a rigore, ci si dovrebbe attenere.
L’argomento del Non-Identity Problem, sviluppato da Parfit nel suo capolavoro Reasons and Persons (1984), rappresenta forse una delle linee argomentative più discusse e controverse in seno al dibattito sull’etica intergenerazionale, poiché con esso si giunge a dimostrare il carattere ingiustificabile di una responsabilità nei confronti di esseri futuri con una cogenza e rigore tali da rendere il sostegno della tesi contraria impresa assai difficile da realizzare.
Semplificando tutta una serie di passaggi, sui quali non posso qui soffermarmi, l’argomento di Parfit può essere illustrato a grandi linee nel modo seguente. Bisogna tenere ferme, anzitutto, le due premesse fondamentali, da cui l’autore procede: la premessa consequenzialista, in base a cui un’azione può essere reputata moralmente rilevante solo se implica una conseguenza per qualcuno e, quindi, moralmente condannabile solo se risulta in un danno per qualcuno; e la premessa causativa o generativa, in base alla quale si deve ritenere che l’effettuazione di azioni da parte di soggetti attuali determina lo stato o destino di soggetti futuri tanto in relazione alla loro identità, quanto in relazione al loro numero.
Mentre la prima premessa risulta piuttosto chiara, la seconda necessita di un’illustrazione esplicativa. Facciamo un esempio: poniamo che, in un determinato giorno x dal tempo atmosferico incerto, l’ottimista Sofia decida, nonostante tutto, di lasciare a casa l’ombrello, così da imbattersi per strada in un improvviso acquazzone, trovandosi, di conseguenza, nella condizione di dover accettare l’offerta di riparo da parte dello sconosciuto passante Marcello (evidentemente munito di ombrello). Poniamo inoltre che esattamente questo incontro abbia propiziato l’innamoramento dei due e il conseguente concepimento della primogenita Lisa. Conclusione: l’esistenza e l’identità di Lisa dipendono esattamente dalle azioni originarie intraprese dai genitori Sofia e Marcello nel giorno x. Ed ancora: poniamo che sempre Sofia e Marcello, in un determinato giorno x, nuovamente a causa di un’improvvisa pioggia, abbiano deciso di rinunciare ad andare al cinema, restando così a casa e concependo quelli che poi si sarebbero rivelati i gemelli Sergio e Carlo. Ebbene, in questo caso, la conclusione a cui si giunge rivela esattamente l’altro aspetto della premessa generativa del consequezialismo, giacché mostra come le originarie decisioni prese dai genitori Sofia e Marcello, in quel determinato giorno x, abbiano causato sia nell’identità che nel numero l’esistenza dei gemelli Sergio e Carlo.
Applichiamo, ora, queste due premesse nel contesto intergenerazionale sopra illustrato riguardo alle politiche energetiche alternative A e B. Quale che sia l’opzione scelta, in base alla premessa causativa sopra riportata, i soggetti futuri concepiti nel caso A sarebbero diversi nella loro identità rispetto a quelli che risulterebbero nell’alternativa B. La politica A, come è ovvio, risulterebbe però anche in una disponibilità di risorse e qualità della vita inferiori per le generazioni future rispetto a quanto si avrebbe se si decidesse per l’opzione B. Ora, come abbiamo visto, in base alla conclusione più intuitiva, si sarebbe spinti ad adottare indubbiamente l’opzione B. Tuttavia, è proprio a questo livello che entra in gioco la cogente, quanto paradossale, logica della non-identità a cui si riferisce Parfit. Secondo questa logica, infatti, bisogna coerentemente concludere che anche l’adozione dell’opzione A è da ritenersi moralmente accettabile, visto che essa non danneggia nessuno. In effetti, realizzando l’opzione B piuttosto che l’opzione A, non avremmo comunque come risultato finale l’esistenza dei medesimi soggetti, i quali avrebbero poi la possibilità di esprimere alternativamente un giudizio di riconoscenza o di condanna nei confronti delle scelte della generazione originaria, avremmo bensì sempre e soltanto soggetti diversi, ovvero esattamente quei soggetti che, di volta in volta, devono la loro esistenza alle condizioni che li hanno generati e i quali, in alternativa, non sarebbero esistiti affatto. Pertanto, la conclusione a cui si giunge è che i soggetti futuri, nella misura in cui dispongono di una vita minimamente degna d’essere vissuta e quindi non affermano di preferire non essere mai nati, non possono in alcun modo condannare i predecessori per le loro scelte, qualunque esse siano, e questo dal momento che scelte alternative avrebbero escluso la loro esistenza punto e basta. I soggetti attuali, quindi, qualunque siano le scelte da essi intraprese, non possono essere ritenuti in nessun caso responsabili nei confronti di esseri futuri, poiché non arrecano danno a nessuno.
La negazione di responsabilità verso le generazioni future, che così si evince dall’argomento della non-identità, si rivela di portata radicale: la conclusione ripugnante è moralmente accettabile! Donald Trump si muove in fondo, seppur inconsapevolmente, entro le linee dettate da un consequenzialismo morale di gittata intergenerazionale!
Eppure, forse un’ancora di salvezza ci giunge da alcune pieghe nascoste della medesima narrazione di Parfit. Sì, perché quest’ultimo, proprio nel momento di più elevata espressione speculativa della sua argomentazione, sorprendentemente fa una sorta di passo indietro e ci avverte – in modo più o meno diretto – che esiste un’istanza morale molto più originaria rispetto all’argomento della non-identità. E questa istanza è esattamente rappresentata da quanto ci suggerisce l’intuizione morale, chiaramente incline a rifiutare ogni (seppur ben congeniata) conclusione ripugnante e a prendersi carico di una responsabilità per le generazioni future.
Qui non deve interessarci il fatto che Parfit dichiaratamente non riesca ad addivenire ad una teoria in grado di superare l’ostacolo rappresentato dal Non-Identity Problem, da egli stesso peraltro teorizzato. Quanto deve qui catturare la nostra attenzione è, invece, che Parfit ricorra proprio all’extrema ratio dell’intuizione morale al fine di giustificare la sua ricerca volta a trovare una “Teoria x” capace di fornire una legittimazione davvero convincente per una responsabilità verso i futuri.
Sennonché, il problema spinoso sta proprio nel fatto che l’intuizione morale, a ben guardare, non ha alcun carattere di ratio organizzabile, articolabile, spendibile e proceduralmente iterabile. Insomma, non è un’arma impiegabile all’occorrenza, ma piuttosto un fragile richiamo, poiché si alimenta esso stesso della medesima sensibilità umana (e per l’umano) a cui volta per volta ingiunge.
Probabilmente, una tale intuizione morale concretizza semplicemente il fatto che l’umano – e la sensibilità per esso che ne scaturisce – ha un carattere incondizionato: alla lettera, senza condizioni ovvero senza proprietà precostituite (e giusnaturalisticamente desumibili). In altri termini, l’umano – e la responsabilità che da esso promana – si realizza, di volta in volta e mai una volta per tutte, unicamente grazie alla capacità stessa – giammai garantita! – di testimoniarlo come tale.
Ma se così stanno le cose, è allora altrettanto vero che una capacità del genere può sempre anche affievolirsi, fino a dissiparsi. E con essa può anche spegnersi irrimediabilmente l’intuizione morale che ne è intimamente connessa. Ogniqualvolta si approssimano tali limiti – e la storia ci ha insegnato in più di un’occasione che una tale approssimazione non è per nulla una mera ipotesi –, (il senso del)l’umano è a rischio d’estinzione e, di pari passo, il ripugnante cessa di ripugnare. Nonostante ciò, resta pur possibile che, in tali casi, l’intuizione morale non si estingua definitivamente. Quasi a rappresentare una sorprendente ultima ancora di salvezza (o consolazione) è infatti ancora possibile che siffatta intuizione scaturisca da fonti inaspettate. Questo ci ricorda, per esempio, Emmanuel Lévinas in un racconto della sua esperienza nel campo di prigionia (nella Germania nazista) per soldati israeliti francesi durante la Seconda Guerra Mondiale, allorquando ci riporta come, alla fine, proprio là dove ogni traccia di umanità sembrava “non e[ssere] più nel mondo”, restava pur sempre “Bobby” ad ergersi a “ultimo kantiano” – un cane randagio che, “abbaiando felicemente” a coloro i quali non si vedevano più riconosciuta alcuna umanità, la restituiva loro, rammentandola al contempo (forse invano) a coloro i quali non intendevano più riconoscerla.
Un umano senza condizioni e senza garanzie rimette così sempre a un’istanza testimoniale da cui dipende la sua stessa insorgenza, tenuta e destino, quale che sia la forma attraverso cui una tale istanza si manifesta (mi piace anche qui far risuonare le parole di Lévinas tratte dal racconto sopra citato: “Nell’ora suprema della sua attestazione – senza etica e senza logos –, il cane attesta la dignità della persona”!).
Una considerazione del genere invoca indubbiamente un’ampia gamma di riflessioni e approfondimenti. Non potendoli affrontare in questa sede, mi limito qui soltanto a rilanciarne la problematicità attraverso due domande conclusive: ci sarà sempre un Bobby a tenere sveglio, in ultima istanza, il senso del ripugnante e del (dis)umano contro il Trump di turno (dovunque questo si palesi)? E ancor di più: di fronte a un’eventuale tirannia dei presenti totalmente dispiegata, come potranno soggetti futuri, senza voce e senza volto, mai “abbaiare” per rammentarci ancora della loro (e della nostra) umanità?
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA POLITICA consequenzialismo Donald Trump Endoxa luglio 2018 Ferdinando Menga FILOSOFIA filosofia politica POLITICA Trump