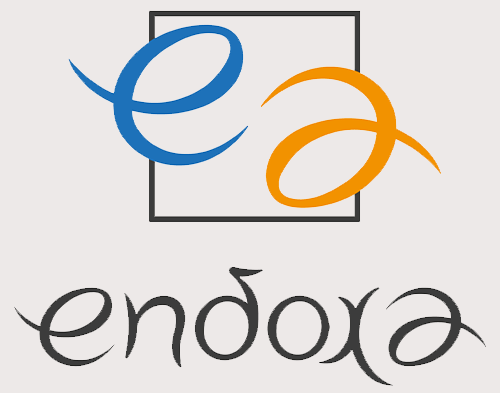“COS’ERA QUESTA CURA…?”: UMANITÀ, STORIA, DEMOCRAZIA NEL COTTOLENGO DI ITALO CALVINO
 PIER GIUSEPPE PUGGIONI
PIER GIUSEPPE PUGGIONI
“Once one dismisses
The rest of all possible worlds,
One finds that this is
The best of all possible worlds”.
- Bernstein, J. Wells, Candide (1989)
Democrazia, cura e politica in La giornata d’uno scrutatore
Il problema della funzione storica della democrazia e quello del significato politico-sociale della cura tendono a risolversi in questioni direttamente attinenti all’umano, all’idea di ‘uomo’. È specialmente nei momenti in cui si è chiamati a partecipare all’esercizio democratico dei diritti politici che si palesa l’urgenza di interrogarsi sul senso che la democrazia assume rispetto all’esistenza storica dell’umano. Così, nei tempi in cui il bisogno di cura è avvertito con maggiore impellenza emerge e prorompe la questione del rapporto fra tale bisogno e l’orizzonte relazionale in cui l’uomo si muove.
L’interrogativo sulla democrazia si mostra, dunque, a un tempo parallelo e secante rispetto a quello sulla cura. È parallelo in quanto ciascuna delle due categorie mostra, per così dire, un doppio volto: il termine dèmos si riferisce, anticamente, ad una sezione della moltitudine, un gruppo di individui separato e distinto dagli altri, ma viene associato all’idea del legame (déo racchiude, infatti, il significato di “legare”) o a quella del corpo unito (démas): se, cioè, per un verso il dèmos esclude, per l’altro ‘chiude’ nel senso che unisce. Analogamente, la nozione di cura implica il rivolgimento dello sguardo all’altro, il riconoscimento dell’altro in quanto riconoscimento di se stessi nell’altro, ma comporta, al contempo, che da quella relazione privilegiata sia escluso colui nei confronti del quale tale riconoscimento non avviene.
I due problemi, del resto, si intersecano nella misura in cui implicano entrambi lo spazio politico. Quello della democrazia è infatti un problema che attiene all’assunzione delle decisioni nella polis e sulla polis, all’interno cioè di quel contesto nel quale si svolge l’interazione fra gli uomini. Ma la stessa polis, se la intendiamo con Heidegger come “luogo dell’esserci dell’uomo stesso”, o il sito storico dell’esserci, viene allora presupposta dalla dinamica dell’”avere cura (Fürsorge)”, in cui si traduce la struttura dell’uomo, dell’esserci, come “essere-con”: per esser-ci, è infatti necessario un “ci (Da)”, la polis.
È proprio attraverso questa sovrapposizione – o, se vogliamo, questa congiunzione – di democrazia e cura che si apre la possibilità di riflettere sulla connessione dell’una e dell’altra all’esperienza umana. Un’indagine siffatta è quella che emerge a più riprese ne La giornata d’uno scrutatore (1963) di Italo Calvino: in questo romanzo viene, del resto, rappresentata la vicenda di un uomo, fervente appassionato della democrazia in quello che lui ritiene esserne il “vero senso”, all’interno di un luogo di cura, il Cottolengo torinese, che ha le fattezze di una città, anzi di “una città nella città”. Da questo luogo lo scrutatore Amerigo Ormea, nel controllare lo svolgimento delle operazioni elettorali, riceve un’”impressione […] di estraneità e freddezza”: il Cottolengo si presenta come un mondo tutto diverso da quello della città che lo circonda, una fortezza “cinta da mura e soggetta ad altre regole”, dotata cioè di un proprio ordine di significati, di un peculiare ordine etico e giuridico.
L’incontro di ‘ordini’ nel Cottolengo: quale ‘cura’ e quale ‘democrazia’?
Due mondi sembrano, quindi, incontrarsi nella giornata di Amerigo: quello di chi vive e opera dentro il Cottolengo, “i credenti nell’ordine divino, nell’autorità che non proviene da questa terra”, e quello di chi sta fuori, ossia “i compagni suoi, ben coscienti dell’inganno borghese”. Fra queste due “razze di gente”, che si ritrovano insieme per via di un’operazione politica, unite da un procedimento democratico, lo scrutatore viene colpito da quella che trova a sé estranea: si legge, infatti, che “la battaglia legalitaria” di Amerigo “contro le irregolarità e i brogli non era ancora cominciata e già tutta quella miseria – la miseria del Cottolengo – gli era calata addosso come una valanga”. Non è d’altronde in questo modo che opera, come ricorda Waldenfels, l’estraneità dell’altro, la quale “ci sopraffà e ci sorprende, disturba le nostre intenzioni prima che noi le comprendiamo in questo o in quell’altro modo”?
Il Cottolengo, l’”enorme ospizio” che svolge la funzione “di dare asilo, tra i tanti infelici, ai minorati, ai deficienti, ai deformi, giù giù fino alle creature nascoste che non si permette a nessuno di vedere”, riceve una duplice qualificazione nell’opinione dei cittadini ‘esterni’: da una parte, esso suscita un profondo rispetto nella loro “pietà” attraverso l’immagine di “provvidenza benefica” che essa ordinariamente palesa al pubblico; d’altra parte, in periodo di elezioni quel luogo assume un significato “tutt’affatto diverso”, trasformandosi nel teatro dello “sfruttamento elettorale” della miseria. Lo spettacolo mostra i malati, gli infermi e gli “idioti” venire accompagnati alle urne da monache e preti, divenendo così una “grande riserva di suffragi” per la Democrazia Cristiana. Nel luogo che per antonomasia ospita la relazione di cura, l’altro che di tale relazione è il presupposto viene come privato della propria soggettività. Esso è inserito in un processo di produzione elettorale, che annulla e rende a lui estranea la libertà promessagli dalla democrazia liberale: per dirla con il Marx dei Manoscritti economico-filosofici del 1844, tanto caro allo scrutatore Amerigo, il misero viene oggettivato ed egli stesso “annullato”, reso uno strumento di quel processo che strumentalizza la “gratitudine” da lui dovuta a “Dio, nostro Signore, e basta”.
Questa seconda funzione del Cottolengo si è sviluppata nel corso del tempo. A ben vedere, la “Piccola Casa della Divina Provvidenza” non ha semplicemente mutato il proprio compito, bensì ha perduto la propria identità originaria. È come se l’ospizio, dominato “alle origini” dal “calore d‘una pietà che pervadeva persone e cose”, avesse “adesso” assunto in misura pressoché totale le fattezze di una fabbrica che “produc[e] voti”. La stessa cura trasforma il proprio oggetto e, di conseguenza, se stessa divenendo, da impegno per l’accudimento e il riconoscimento della vulnerabilità, una “cura” volta esclusivamente ad “appendere per bene [d]ei manifesti come bianchi lenzuoli”, al fine di consentire quel “plebiscito di tutti i vivi e i moribondi e magari anche i morti”. La democrazia italiana appare, agli occhi di Amerigo, vittima di un’involuzione simile: nell’Italia appena uscita dal fascismo la democrazia vedeva “la partecipazione di tutti alle cose e agli atti della politica”, mentre “adesso” si fa più presente “l’ombra grigia dello Stato burocratico, uguale prima durante e dopo il fascismo, la vecchia separazione tra amministratori e amministrati”. Alla luce di questa constatazione, si fa strada nella mente dello scrutatore il pensiero “che solo quella democrazia appena nata pote[sse] meritare il nome di democrazia”.
È a quest’altezza che Calvino pone sotto i riflettori la problematica relazione che intercorre fra cura e democrazia, da una parte, e realtà storica dell’uomo, dall’altra. Non è, infatti, vero che il momento iniziale, l’istante dell’eccezione, esaurisce interamente l’autentico significato dell’ordine democratico o della relazione di cura, come se questi fossero necessariamente destinati a snaturarsi allo stabilirsi della normalità (la “normale amministrazione”). “Quel che conta – riflette Amerigo Ormea – non sono le istituzioni che invecchiano ma le volontà e i bisogni umani che continuano a rinnovarsi, a ridare verità agli strumenti di cui si servono”. Le istituzioni del mondo acquistano significato in relazione alla loro capacità di accostarsi alla vita dell’uomo, dalla quale trae origine – e alla quale fa capo – la verità che informa tali istituzioni. Queste, perciò, smarriscono la loro verità quando si allontanano o, come paventa Savigny nella Vocazione (1814) a proposito della scienza del diritto, si “distaccano” dal proprio oggetto, ossia “la vita stessa dell’uomo, considerata da un punto di vista particolare”.
Ecco che viene a galla lo storicismo dello scrutatore e dello stesso Calvino, il quale dichiara nella Presentazione al romanzo di aver voluto denunciare “uno degli aspetti più assurdi della nostra democrazia”, espressione di una “concezione del mondo che tiene la storia per cosa vana”. Le istituzioni come le organizzazioni di cura e di assistenza, la democrazia, il diritto, lo Stato, sono calate nella dimensione della contingenza storica e non sono destinate per necessità a durare nel tempo. Si tratta, non a caso, di una tesi ampiamente sostenuta nella letteratura marxista – dal Lenin di Stato e rivoluzione (1917) al Laski di The Foundations of Sovereignty (1921) –, che Calvino sembra assumere e distinguere dal movimento comunista italiano tramite il quale Amerigo tende, invece, a riconoscersi nella procedura elettorale, almeno all’inizio della sua giornata. La “storia”, nel Cottolengo come nella democrazia italiana, sembra “rimasta ferma in un punto”, mentre nel corso della propria esistenza l’uomo incessantemente si trasforma, mutando così la sua volontà e i suoi bisogni.
Dall’uomo “menomato” alla sua interezza
La concezione delle istituzioni come determinazioni storiche contingenti apre il campo al nodo fondamentale tra quelli rilevabili nella Giornata. Calvino, in particolare, sembra chiedersi in che modo le istituzioni, la cui verità dipende dal contatto con la vita dell’uomo, possano a loro volta incidere sull’esistenza stessa dell’essere umano. Del fatto che l’istituzione colpisca l’animo dei votanti nel Cottolengo, rompendo la loro quotidianità con la richiesta di un’”insolita prestazione pubblica”, Amerigo Ormea si accorge quasi subito, notando ad esempio come alcuni di quelli ostentino una “specie di fierezza”, vedendo finalmente riconosciuta la propria esistenza. Nel permettere l’incontro fra questi “abitatori di un mondo nascosto”, il Cottolengo, e i “rappresentanti d’un ordine sconosciuto”, quello della democrazia e dello Stato, il procedimento elettorale sembra illuderci che dietro la “finzione di libertà” del voto si celi “un barlume, un presagio di libertà vera”.
Soltanto in un secondo momento lo scrutatore sembra accorgersi di come la credenza che lo Stato possa elargire una “libertà vera” sia quanto mai falsa. L’”uomo del Cottolengo” non è, infatti, un uomo meno completo dell’uomo “sano”, “dotato di tutte le sue facoltà”: quest’ultimo promuove valori come “progresso, libertà, giustizia”, ma conferisce a essi un significato corrispondente alle “idee di privilegiati, cioè idee non universali”. L’uomo ‘sano’ non è l’”uomo intero”, è anch’egli – come il “deficiente” o il “menomato” – dimidiato o dimezzato (per richiamare un celebre aggettivo calviniano), in quanto “non considererà mai abbastanza raggiunta la sua interezza”. Egli, purtuttavia, non nasconde la presunzione di “costruire” da sé la propria “storia”, in qualità di homo faber, e “rischia sempre di scambiare le sue istituzioni per il fuoco segreto senza il quale le civiltà non si fondano”.
Quello dello Stato – quand’anche ‘democratico’ – non è “il migliore dei mondi possibili”, come forse affermerebbe il Pangloss del Candido volterriano, e di questo il fautore della lotta di classe dovrebbe essere ben consapevole: Amerigo Ormea non lo è, ma a ben vedere nemmeno lo sono i comunisti italiani di cui si parla ne La giornata, che appaiono proni rispetto all’ordine liberale, vivendo una contraddizione che Calvino non manca di far emergere. Nel corso della sua giornata, lo scrutatore realizza che l’ordine statuale è soltanto “un angolo dell’immenso mondo”, non è cioè “il solo mondo al mondo”. Si tratta di un ‘mondo’ possibile, di una realtà che si impone sulle altre e che pretende di stabilire la norma, l’ordine di significati in base a cui sia possibile “parlare di minorati, di idioti, di deformi”. È ancora Marx, in un’osservazione supplementare al Terzo manoscritto, a dirci che la “realtà umana”, corrispondente all’”agire umano e […al] patire umano”, è “molteplice quanto sono molteplici le determinazioni essenziali e le attività dell’uomo”: essa non può dunque esaurirsi in un solo orizzonte di senso. La realtà del Cottolengo – osserva allora Amerigo Ormea – non rappresenta che un altro mondo possibile, o meglio un altro modo in cui si può “essere umani”. Rispetto a questa “diversa possibilità d’essere, dimenticata”, è l’homo faber, l’individuo liberale che si pretende l’artefice unico del proprio destino, a essere “deforme” e “minorato”.
All’interno del Cottolengo è inoltre possibile intravvedere, anzi scrutare, osservare una realtà nuova, “un mondo che rifiut[a] la forma”, che respinge le determinazioni della società esistente all’esterno, e sembra perciò avere accesso a una regione di felicità e di serenità tale da sbalordire gli scrutatori. Non è un caso, d’altronde, che le monache dell’ospizio, così come gli “idioti completi”, palesino volti “felici e fotogenici”. È come se, entrando nel Cottolengo, l’uomo ‘sano’ potesse per un momento uscire dalle mura che ne opprimono l’esistenza e scoprire la propria completezza. Richiamando, stavolta esplicitamente, la riflessione del giovane Marx sull’”universalità dell’uomo”, che sussiste nella misura in cui l’”intera natura” diviene “il corpo inorganico” dell’uomo stesso, Calvino si sofferma sulla condizione esistenziale dell’”uomo menomato”, il quale non è soltanto – ormai l’abbiamo capito – “l’uomo-Cottolengo”, ma “l’uomo” storico e concreto. Si tratta di uscire “fuori dalla società che fa divenire gli uomini cose”, affinché la “totalità delle cose” possa diventare “umana”; o, meglio, affinché l’umanità possa accedere al proprio “corpo totale”.
A menomare e spezzare il corpo dell’uomo non è dunque la natura, che ne farebbe parte, ma sono le istituzioni, e in particolare quelle istituzioni che pretendono di esaurire i modi in cui potersi ‘legittimamente’ definire umani. “Le istituzioni – osserva Calvino – modellano il volto e l’anima delle civiltà” e informano l’uomo, apponendo dei confini alle sue possibilità di essere e di esprimere la propria umanità. L’umano, quindi, pare in un certo senso de-naturarsi tramite l’istituzione che egli stesso stabilisce, come sembra suggerire la scena, ritratta negli ultimi capitoli del romanzo, dell’incontro fra il vecchio contadino e suo figlio, ricoverato nell’ospizio, per il quale il padre schiaccia delle mandorle e lo guarda mangiarle. Agli occhi di Amerigo Ormea – e così ai nostri –, questa scena indica “un territorio sconosciuto”, al di là, cioè, della strada conosciuta che le nostre istituzioni prescrivono: è forse, questo territorio sconosciuto, uno scorcio di quel “regno della libertà” di cui parlano Marx, Engels e Gramsci, che si troverebbe compiendo un “salto” al di fuori del “regno della necessità”?
Non parrebbe strano se proprio questa fosse la libertà che indicano il vecchio e suo figlio: mentre il giovane mastica “la sua lenta merenda” grazie all’aiuto del padre, questi “fiss[a] il figlio negli occhi per farsi riconoscere, per non perderlo”. In questo modo i due, “così come sono”, cioè allontanando da sé le determinazioni esterne, “sono reciprocamente necessari”. In questa necessaria reciprocità Amerigo vede manifestarsi l’amore, che non è tanto una proprietà dell’essere umano, quanto piuttosto la sua vera e propria identità: “l’umano – si legge infatti in conclusione del capitolo XII – arriva dove arriva l’amore; non ha confini se non quelli che gli diamo”. Viene dunque istituita un’associazione, una connessione vitale tra umano e amore, tale da far coincidere l’estensione dell’uno con quella dell’altro, sicché nella misura in cui l’amore sperimenta limitazioni e confinamenti, è l’uomo stesso a trovarsi rinchiuso, limitato, confinato.
I confini che l’uomo pone all’amore, cioè a se stesso, sono di fatto soprattutto quelli stabiliti attraverso convenzioni, superstizioni, istituzioni come lo Stato e il diritto, tramite le quali si opera sulla vita e sull’esistenza una decisione, un taglio, e sul corpo dell’uomo uno smembramento. La salvezza da questo smembramento pare, tuttavia, accessibile proprio attraverso un gioco di sguardi come quello cui assistiamo durante La giornata – lo ‘scrutare’ di Amerigo, gli occhi del vecchio contadino –, uno che ci permetta di ricordare, di rimemorare l’interezza ‘smembrata’, di ri-membrare.