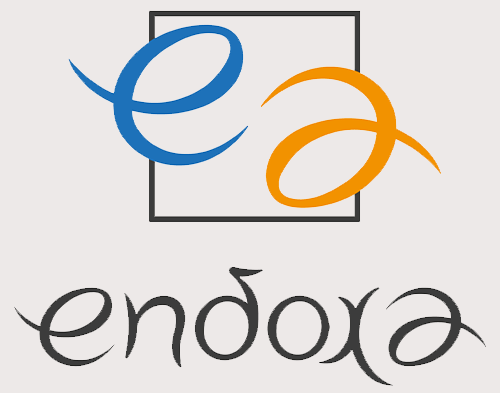TERAPIE NIETZSCHEANE COME CURA ALL’INDIFFERENZA E IL “GIARDINAGGIO” DELL’ANIMA
 TOMMASO CICCARONE
TOMMASO CICCARONE
“Non mi piace il prossimo troppo vicino:/che stia in alto e in lontananza! /Come potrebbe sennò diventare la mia stella?” Così Nietzsche in un passaggio poetico del suo Preludio in rime tedesche alla Gaia Scienza (1884).
A dispetto del tenore innescato dall’apparente disprezzo per il prossimo, per l’altro, e al di là della vulgata che lo tramanda come refrattario a qualsiasi fondazione di valori etici, si può considerare Nietzsche come un ri-propositore di un’etica della cura, “umana, troppo umana”.
Si fa volutamente riferimento alla riproposizione e non a una pioneristica “proposizione” della cura perché il suo originario senso filosofico afferisce allo spirito greco orientato verso la felicità (Eudaimonia), il benessere e la saggezza. È nota l’inattualità di Nietzsche –lui ne era consapevole: egli, piuttosto, è, come Spinoza, un pensatore “antico”, che assume il pensiero greco come il martello con cui demolire la decadenza morale in cui la civiltà occidentale è precipitata o attraverso cui l’“ultimo uomo” ha consumato, fino a raschiarne il barile, l’Occaso/Tramonto dell’Essere in una generalizzata in-differenza; la “morale degli schiavi” (basti solo considerare il Così parlò Zarathustra, un libro per tutti ma, purtroppo, per nessuno).
Nietzsche: sul predone il brabaro eil giardiniere
In molteplici luoghi del suo pensiero viandante Nietzsche ha tentato di identificare l’uomo come un “essere di relazioni”. Il suo destino dipende dal modo prospettico di relazionarsi, di esperienza in esperienza, non solo con l’altro da sé ma con sé stesso. È in questa ottica che ha elaborato immagini simboliche di possibili tipi del suo essere in relazione, come, costitutivamente, “predone”; come, storicamente, “barbaro”; come, auspicabilmente, “giardiniere”. L’uomo è, prima che essere razionale e, al di là di ogni illusorio individualismo per cui egli sarebbe bastevole a sé stesso, colui che configura il proprio essere al mondo come “appropriazione” dell’altro in una relazione potremmo dire “nutritiva”. Dal punto di vista storico, nello sviluppo della cosiddetta civiltà la relazione che l’homo sapiens ha strutturato con gli altri è all’insegna della aggressività come volontà di fare e godere del male altrui. A un terzo livello, che apre la riflessione a una presa di posizione etica o curativa verso l’avvenire, per ciò che Spinoza avrebbe chiamato un conatus di miglioramento, l’uomo può, non senza sacrificio, realizzare sé stesso prendendosi cura dell’altro e, di riflesso, prendendosi cura di sé, ovvero: nel prendersi cura di sé non può non mettersi in gioco per la cura del prossimo.
Innanzitutto la costitutiva condizione di predone non coincide con un giudizio negativo o moralistico se si considera, prospetticamente –come vuole Nietzsche- la crescita o affermazione di sé attraverso il prendere dal mondo e dagli altri materiale di nutrimento spirituale e senza che la presa dagli altri divenga una espropriazione degli altri o una loro alienazione. Ciò sortirebbe la condizione espropriativa e barbarica di una condotta egoistica connotata da chiusura e volontà di dominio (così Spinoza: omnis determinatio est negatio!). Gli incontri innescano “furti” di pensieri in un senso positivo di consapevolezza del limite e dell’apertura all’altro. Cosa è il nostro proprium?
Difficile rispondere se siamo il risultato, nemmeno definitivo, di ciò (idee, cose, persone) che sta fuori di noi e che costituisce il nostro stare al mondo. L’uomo non si costruisce da sé, quindi il suo “proprium” è il risultato di una continua e necessaria messa in discussione del proprio sé in una sana es-propriazione o fuoriuscita dagli steccati dell’egoismo. Contro l’orgoglio e il carattere grossolano dell’uomo ciò che può essere curativo è una filosofia dell’onestà, dell’acutezza, direi: dell’attenzione nell’ammettere che il nostro proprio nutrimento sono gli altri.
Solo con questa onestà si può, e si deve, restituire al Mondo ciò che si è preso, nella misura delle nostre possibilità.
È un diritto/dovere quello della cura di sé, della propria individuale salute che si riflette nella trasvalutazione di sé nel senso dell’oltrepassamento di quei pregiudizi e chiusure che fanno il carattere dis-onesto e grossolano dell’uomo. Simone Weil, ne La prima radice (1943) preferiva usare non la parola “diritto” –che può alludere a rapporti materiali con le cose oltre che con le persone-, ma quella più cogente e apriori di “obbligo”. È infatti un obbligo morale l’aver cura degli altri come fini e mai come mezzi. L’apertura all’altro, mettendo in gioco il proprio sé, può variare da individuo a individuo in ragione delle singole esperienze che noi decidiamo di vivere e che, vivendole, decidiamo di cambiare; oppure vivendole, senza prospettiva di cambiamento ma per abitudine, non vogliamo cambiarle negando in anticipo l’apertura alle differenze e alla ricchezza degli inter-essi (alla lettera): l’incuria dell’indifferenza e della non curanza.
La ricchezza, infatti, deriva dall’apertura e i suoi rischi, accettando comunque il più grande fra questi: quello di ridefinirsi. La povertà, al contrario, sortisce da ogni chiusura rispetto all’altro, che così è percepito come ostacolo, pericolo, o mezzo per i propri fini, in un orizzonte melmoso di incuria e banalizzazione dell’esistenza. Ci si può appropriare dell’altro in termini di ricchezza relazionale (nel ventaglio delle sue declinazioni: amore, amicizia, lavoro) ma ci si appropria per lo più degli altri in termini di opportunismo e alienazione dell’identità dell’altro a cui si nega la propria differenza specifica.
Il ridefinirsi o sapersi, in parte, “obliare” esclude l’essere i “guardiani della propria rocca”: è importante perdersi per essere restituiti e rinnovati a sé stessi e con gli altri. Bisogna sapersi “perdere per qualche tempo”, così Nietzsche lo esprime attraverso la metafora del viaggiatore nel fr. 638 di Umano, troppo umano (1878)
Chi è il barbaro?
È l’uomo occidentale che storicamente ha abdicato al senso nutritivo/appropriativo degli altri in una torsione manipolativa, aggressiva e direi “prensile” sugli altri. Il barbaro è uguale e contrario all’asceta o al martire; se questo trae il nutrimento dal male autoinferto, quello si nutre del male altrui. La storia dell’uomo è la storia di crudeltà e sopraffazione sulla tonalità emotiva fondamentale della “beatitudine alla vista delle torture”. In Aurora (1881) si legge, per esempio, che “la crudeltà è la grande gioia festiva della più antica umanità”.
L’indagine storica o genealogica non deve soffermarsi all’idea del male e della tortura su cose e corpi (come si evince dall’immaginario greco arcaico attraverso la goduria/invidia degli Dei del sangue e sacrifici umani), ma è interessante rilevare che il male è tanto più profondo e subdolo quanto più è elevato alla dimensione dello spirito nella cosiddetta civiltà “superiore” dell’Occidente. Si pensi alla morale della colpa e colpevolizzazione che, in Al di là del bene e del male (1886) Nietzsche non esita a chiamare morale dei deboli o “del risentimento” rispetto a criteri e norme imposti come valori dominanti e assoluti: il Bene, il Male; l’utile e l’inutile.
La crudeltà, inoltre, può passare e esercitarsi anche nella compassione. L’eccessiva sollecitudine a strappare l’altro dalla sofferenza è essa stessa una forma di incuria, al limite della ipocrisia, verso chi è privato della possibilità di rigenerarsi attraverso la sofferenza. L’esperienza del negativo, come aveva anche detto Hegel, fortifica lo spirito che, al contrario, sarebbe anestetizzato nell’eccesso di compassione. Negare agli adolescenti la quota necessaria di disagio nella propria crescita e proteggerli a ogni costo sotto le campane di vetro di comodità digitali e anestetizzanti è un grado di incuria che può generare l’incapacità ad affrontare la caoticità –ma anche la variabilità proteiforme- dell’esistenza non solo nel mondo della scuola e poi del lavoro, ma soprattutto nel terreno delle relazioni sociali.
Ed ecco allora farsi strada l’idea etica dell’immagine dell’uomo come “giardiniere”. Qui la cura per l’altro coincide con la cura di sé stessi, in una complementare reciprocità perché attraverso questa è coinvolto il sentire dell’io, ed è un sentire non asettico o ascetico ma umano, troppo umano che nella odierna civiltà della tecnica nel cinismo globalizzato, potrebbe essere ricostruita attraverso l’educazione alla ospitalità, al dono, al pudore, all’amicizia.
Per una geneaologia dell’incuria
Il pendersi cura di sé è diventato l’imperativo categorico innescato dall’ideale del Wellness e dell’adeguare la propria condotta alla cura del corpo (Fitness), entro i codici di accettazione dettati suadentemente e persuasivamente dal sistema di consumo e della apparenza. Il vecchio adagio antropocentrico per cui l’uomo è faber ipsius fortunae si è piegato nel principio dell’essere fabbricati serialmente da un destino superiore che distingue, in un inesorabile codice binario vero/falso, ciò che è efficace da ciò che non lo è.
Gli stessi rapporti intersoggettivi passano al vaglio di un setaccio invisibile e onnipervasivo (Non avrai altro Dio all’infuori di me!) che è il comandamento tecnocratico del mercato e la cui promessa è la “beatitudine” dell’aver tutto disponibile e a portata di mano (manipolabile, compresi gli altri –ma compreso vice-versa sé stessi), nella più “normale” (nel senso di normativa) ovvietà. Ob-vius, ciò che sta davanti, sulla via, e…immediatamente. L’incuria è innescata proprio dalla condizione di non problematizzare l’ovvio, perché la tecnica ha esonerato l’uomo dal porsi domande o avere la curiositas per ciò che è misterioso e sfugge alla disponibilità immediata. Si è diventati incuranti in una acclarata condizione di lassismo, negligenza e irresponsabile incuria.
Oltre l’oblio: la cura come therapia
Nella lingua greca la parola “cura” si esprime con il termine “therapeia” che allude, nella sua ricchezza polisemica, al “servizio”, “mettersi all’ascolto dell’altro”. Oggi, al contrario, cura/terapia è termine svuotato del riferimento etico e agganciato all’aspetto strumentale della scienza medica. Nella lingua inglese è significativo si distingua il verbo to care (aver cura, preoccuparsi di qualcuno o qualcosa) dal sinonimo, non omologo, to cure (curare, in senso strumentale e oggettivo/oggettuale).
Platone nel Cratilo, esaminando la radice etimologica della parola anthropos, ha circoscritto l’essenza dell’uomo come “colui che si preoccupa e riflette su ciò che vede” (…). Per estensione si può sostenere che per il Platonismo l’uomo è quell’essere che per riflettere su di sé e su ciò che lo circonda ha la necessità (e dovere morale) di riflettere su ciò che vede attraverso il rammemorare. Il verbo vedere è legato alla radice id contenuta nel termine eidos, nel senso dell’atto contemplativo rispetto all’immediato atto percettivo della retina: in effetti la conoscenza è reminiscenza, anamnesi, prestare attenzione, accendere la fiamma della curiosità e del proprio demone, senza che ciò trasformi il motto delfico del conoscere se stessi in ripiegamento solipsistico e incurante del Mondo. La filosofia nasce dal thauma –che significa meraviglia ma anche dolore, trauma, spaesamento- dallo scarto ontologico, dalla ferita aperta dell’esistenza: lo stare al mondo è l’aver cura di questa ferita che costitutivamente si è.
Per il pensiero antico, dal Platonismo allo stoicismo romano, questo tipo di cura è esercizio di interiorizzazione, funzionale all’esperienza del de-centramento o trascendenza dell’io, rispetto alla fissità della propria struttura egotica. La filosofia si configurerebbe così come squadernamento dell’identico nelle alternative da sé e quindi trasformazione e rinnovamento, sul solco luciferino (alla lettera: portatore di luce) e demonico dell’essere presenti a sé stessi, del gnothi seauton. Un ritorno in sé (rammemorazione) dall’essere autocentrato o, peggio, cosalizzato dalle e nelle maglie dei meccanismi strumentali di assuefazione, nella società e nella politica.
Si prenda, per esempio, la cosiddetta contemplazione “dall’alto” di Marco Aurelio e poi dello stesso Seneca. Contemplare dall’alto significa relativizzare sé e le proprie frontiere in una pratica quotidiana di prospettivismo, come lo chiamerebbe Nietzsche, o di una immersione nella Natura. L’uomo può così cogliersi come piccola parte dell’incommensurabile mistero del cosmo e dell’essere, rispetto ai quali ogni frontiera o muraglia appaiono risibili, frivoli; alla lettera effimeri. In epoca moderna da questa prospettiva è risultato per lo meno risibile e anti-physis il soggettivismo cartesiano o ancora prima il mito dell’antropocentrismo.
Tornando ancora a Platone, questo esercizio di decentramento in cui consiste la filosofia, relativizzando e oltrepassando la sacralità del dato di fatto contingente e, per esempio, dell’immediato edonismo in cui banalmente si circoscrive la felicità, si configura come l’imperativo categorico dell’esercizio per la morte. “Esercitarsi a morire”, da Platone allo stoicismo, non implica un suicidio filosofico o un invito macabro e disfattista a evadere dal mondo come carcere dell’anima, bensì è la predisposizione a rimaner-ci (nel mondo) col senso della prospettiva e del cambiamento; del mettere in gioco l’ovvietà e i pregiudizi; trascendere l’incuria (di sé) e l’indifferenza (per l’altro da sé), nella generalizzata indifferente ovvietà della tecnica da cui non “soltanto un Dio può salvarci” (Heidegger) ma forse il darsi al giardinaggio della propria anima con la complicità di Platone e Nietzsche.
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA Senza categoria Cura/Incuria Endoxa maggio 2023 Tommaso Ciccarone