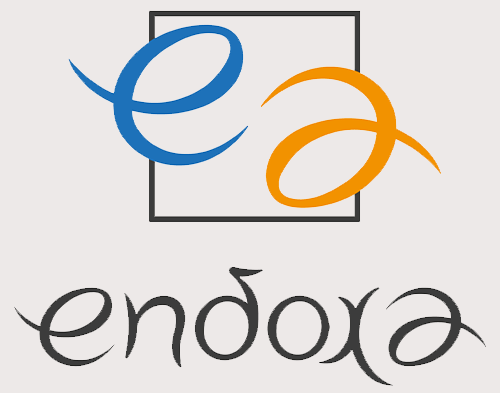CREARE UN UOMO NUOVO: LA RIVOLUZIONE FRANCESE E LA NUOVA IDEA DI FELICITÀ
CESARE VETTER
La questione della felicità sta al centro della narrazione che fin dagli inizi la rivoluzione francese produce su se stessa. La promessa e la speranza di felicità sono ingredienti fondamentali della sua capacità di riaccendere speranze millenaristiche e del suo presentarsi ed essere vissuta come “buona novella”. La parola “bonheur” e la parola “félicité” ricorrono costantemente nel lessico della rivoluzione. Una rapida verifica sul corpus digitalizzato delle Archives Parlementaires, messo in rete dall’università di Stanford, registra 9611 occorrenze di “bonheur” e 1631 occorrenze di “félicité”. Numeri importanti, se si pensa che “fraternité” registra 3142 occorrenze ed “égalité” 11063 occorrenze. Con riferimento ai tre termini del motto repubblicano, solo “liberté” va di gran lunga oltre con 54164 occorrenze.
Nella sua seduta di apertura (21 settembre 1792) la Convenzione – per bocca di Pierre Louis Manuel – si autodefinisce “une assemblée de philosophes occupés à préparer le bonheur du monde”. Un paio di mesi dopo (3 dicembre 1792), in occasione del processo al re, un deputato affermerà che “Il appartient aux grandes assemblées de créer le bonheur social”. Gli farà eco nell’ottobre 1793 Legendre, in quel momento rappresentante in missione, che richiamerà con enfasi “les efforts redoublés des mandataires du peuple pour créer son bonheur et assurer sa liberté”. Lo stesso Legendre nel settembre 1794, in un intervento alla Convezione, ribadirà che è compito dei legislatori “créer le bonheur du peuple”.
“Le bonheur de tous” figura nella Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 26 agosto 1789, che diventerà il preambolo della costituzione del 1791. L’articolo primo della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 24 giugno 1793 (preambolo della costituzione del 1793) recita che “le but de la société est le bonheur commun”. “ Braves sans-culottes, pourquoi avez-vous fait la révolution ? n’est-ce pas pour être plus heureux, foutre ?” scrive Hébert nel numero 241 (fine maggio 1793) del Père Duchesne. E ancora nel numero 263 (24 luglio 1793) : “Il y a trop longtemps que les pauvres bougres de sans- culottes souffrent et tirent la langue. C’ est pour être plus heureux, qu’ils ont fait la révolution”. “Le but de la Révolution est le Bonheur du Peuple” si legge nell’intestazione dell’Instruction de la Commission temporaire de surveillance républicaine (26 brumaire an second: 16 novembre 1793), il documento che Albert Soboul definisce il manifesto dei sanculotti, Françoise Brunel il manifesto di quella parte della Montagna più sensibile ai “droits sociaux” e che Hannah Arendt prende come cartina di tornasole per testare le diversità tra rivoluzione francese e rivoluzione americana. “Che vuole ciascuno di noi ? Cosa vogliamo noi tutti? Cosa cerchiamo dall’istante in cui diveniamo capaci di qualche volontà fino al momento in cui il nostro sangue si ghiaccia e tutti i nostri bisogni vengono meno? Noi vogliamo essere felici, nient’altro” argomenta Joseph Marie Lequinio nel discorso (ateo e materialista) Du Bonheur (20 brumaire an second: 10 novembre 1793), il testo forse più noto sulla felicità prodotto nel periodo rivoluzionario. Nel suo testamento filosofico (Esquisse: 1793-1794) Condorcet – proscritto e fuggiasco – non rinuncerà a ribadire la convinzione che “la nature lie, par une chaîne indissoluble, la vérité, le bonheur et la vertu”. Il riferimento alla felicità è componente essenziale delle strategie discorsive che mettono in campo il sanculotto come figura centrale nell’ anno secondo (1793-1794).
Le caratteristiche e i contenuti di questa felicità tanto evocata variano a seconda delle fasi della rivoluzione e degli orientamenti ideali e politici che si contendono il campo. Per alcuni – nel solco e in sintonia con il diritto alla ricerca della felicità (“pursuit of happiness”) prospettato nella Dichiarazione di indipendenza americana del 4 luglio 1776 – si tratta di creare le condizioni in cui ogni individuo possa cercare al meglio la propria felicità, sviluppando i propri talenti e le proprie capacità.È questa l’impostazione – che potemmo chiamare procedurale – di Condorcet, già esposta con chiarezza nello scritto De l’influence de la révolution de l’Amérique sur l’Europe (1786):
Una nazione presa nel suo insieme è un ente astratto e non può essere né felice né infelice. Di conseguenza, quando si parla di felicità di una nazione, non si può intendere che due cose: o una specie di valore medio, inteso come la risultante della felicità e dell’infelicità dei singoli individui; o i mezzi generali per raggiungere la felicità, vale a dire la tranquillità e il benessere che possono essere offerti a tutti i cittadini dalla terra, dalle leggi, dall’attività manifatturiera, dai rapporti con le nazioni straniere. Basta avere qualche idea riguardo alla giustizia per capire che bisogna attenersi al secondo significato.
Per altri la politica ha il compito non solo di creare opportunità per la libera e piena fioritura delle capacità e dei talenti individuali ma deve intervenire concretamente nella costruzione della felicità dei singoli. In questo solco – e in una prospettiva egalitarista – si muove il bonheur evocato nelle celebri strofe de La Carmagnole (anonimo, agosto 1792): “Il faut raccourcir les géants / Et rendre les petits plus grands / Tout à la même hauteur / Voilà le vrai bonheur…”. Egalitarista e improntato a una visione sostantiva della felicità è anche il bonheur evocato nella sopracitata Instruction de la Commission temporaire de surveillance républicaine:
Tutto è permesso per coloro che agiscono nel senso della rivoluzione; non c’è altro pericolo per un repubblicano che fermarsi al di qua di dove dovrebbero arrivare le leggi della repubblica; chiunque le anticipa e anche in apparenza ne supera il limite, spesso in realtà non è ancora giunto alla meta. Fin tanto che ci sarà un solo infelice sulla terra, bisognerà continuare a procedere nel cammino della libertà [….] La rivoluzione è fatta per il popolo; il suo fine è la felicità del popolo […] Se una eguaglianza perfetta di felicità fosse disgraziatamente impossibile tra gli uomini, sarebbe comunque possibile ridurre sempre di più le differenze di felicità.
Questa visione sostantiva della felicità declinata in senso sociale (a volte egalitario e a volte egalitarista) affonda le sue radici remote in antiche e consolidate tradizioni di pensiero. Le radici prossime rinviano ai filoni più radicali della cultura illuministica. Mably – sostenitore e teorizzatore della “communauté des biens” – enuncia con molta chiarezza l’idea che la natura ha predisposto per l’uomo un solo tipo di felicità e che è compito della politica individuarla e realizzarla (1763):
Ma crederete, mio caro Aristide, che, assecondando la bizzarria dei nostri gusti, la natura, incostante e capricciosa come noi, abbia diversi tipi di felicità da offrirci? No, essa offre un solo tipo di felicità a tutti gli uomini, e la politica deve imparare a conoscere questa felicità di cui l’uomo è suscettibile, e i mezzi per raggiungerla.
Saint-Just a volte sembra inclinare verso una impostazione procedurale, a volte sembra indulgere a una visione sostantiva:
Non si tratta di rendere un popolo felice, ma di impedirgli di essere infelice. Non opprimete, ecco tutto. Ciascuno saprà trovare la sua felicità. Un popolo presso cui si consolidasse il pregiudizio che deve la sua felicità al governo non la conserverebbe a lungo […..] La rivoluzione ha per compito la realizzazione compiuta della felicità e della libertà pubblica tramite le leggi.
Anche le formule cambiano: “bonheur de tous”, “bonheur commun”, “bonheur commun de tous”, “bonheur républicain”, “bonheur du peuple”, “bonheur de la nation”… La formula “bonheur commun” – recepita nella Déclaration del 1793 e ampiamente usata nell’anno secondo – attraversa tutta la rivoluzione. La si ritrova, per esempio, in Mirabeau e Condorcet, con significati diversi da quelli del giacobinismo e della sanculotteria e ancor più radicalmente diversi dall’ accezione che assumerà con Babeuf. Nel giacobinismo dell’anno secondo e nella sanculotteria “bonheur commun” corrisponde prevalentemente al significato messo a fuoco da Jean Bart, all’idea cioè di “un bonheur partagé, frugal [.…] accessible à tous”, un bonheur raggiungibile tramite “la généralisation de la petite propriété”. È questo il bonheur prefigurato da Saint-Just (13 marzo 1794):
Vi parlammo della felicità; l’egoismo abusò di questa idea per esasperare le grida e il furore dell’aristocrazia. Si sono improvvisamente ridestati i desideri di quella felicità che consiste nell’oblio degli altri e nel godimento del superfluo. La felicità! La felicità! Si esclamò. Ma non era la felicità di Persepoli che vi offrimmo; quella è la felicità dei corruttori dell’umanità; noi vi offrimmo la felicità di Sparta e quella di Atene nei suoi giorni migliori; vi offrimmo la felicità della virtù, quella dell’agiatezza e della giusta misura; vi offrimmo la felicità che nasce dal godimento del necessario senza il superfluo; vi offrimmo come felicità l’odio della tirannia, il piacere di una capanna e di un campo fertile, coltivato con le vostre mani. Noi offrimmo al popolo la felicità di essere libero e tranquillo, e di godere in pace dei frutti e dei costumi della rivoluzione; quella di tornare alla natura, alla morale, e di fondare la repubblica [….] Un aratro, un campo, una capanna al riparo dal fisco, una famiglia al riparo dalla lubricità di un furfante, ecco la felicità.
Nella sanculotteria dell’anno secondo sono però già presenti richieste più radicali, che prefigurano le successive teorizzazioni comuniste di Babeuf. Con Babeuf l’aggettivo commun, affiancato a bonheur e a félicité, torna ad implicare – così come precedentemente in Meslier, in Morelly e in Mably, ma non in Rousseau – l’abolizione della proprietà privata e la “communauté des biens”. Con Babeuf inoltre (e con Buonarroti) nel campo semantico di “bonheur commun” entra la nozione di dictature (declinazione particolare del nesso politica-felicità, che affida la realizzazione della felicità a minoranze virtuose e illuminate e pospone la partecipazione piena dei cittadini alla società rigenerata) e tale saldatura percorrerà gran parte delle teorizzazioni comuniste del XIX e del XX secolo. La dictature révolutionnaire saprà trasformarsi da semplice categoria del pensiero politico in forza storicamente operante, capace di alimentare speranze ed entusiasmi e di orientare sensibilità individuali e comportamenti collettivi, proprio anche grazie alle sue promesse di felicità. Nel paradosso della dittatura levatrice di libertà giocherà un ruolo importante e decisivo l’idea di poter creare la felicità attraverso l’intervento della politica. Il “bonheur commun” del filone babuvista-buonarottiano (“communauté des biens”) radicalizza il “bonheur commun” dell’anno secondo (“bonheur partagé”). In tutte e due le varianti comunque l’espressione non ha nulla a che vedere con la nozione di “bene comune” con cui viene a volte erroneamente tradotta in italiano. Non ha nulla a che vedere inoltre con il “common blessing” di Pope (tradotto in francese con “bonheur commun”), il “common good” evocato nella costituzione del Massachusetts del 1780 e con il “commonwealth” del lessico politico britannico del Settecento.
La rivoluzione francese lascia in eredità al XIX e al XX secolo un’idea nuova di felicità: una felicità suscitata e costruita politicamente per via rivoluzionaria. È questa la novità evocata da Saint-Just nella celebre frase del 3 marzo 1794 (“Le bonheur est une idée neuve en Europe”).È una novità che segna una forte discontinuità nella storia dell’idea di felicità. Se infatti il nesso politica-felicità è presente in molte formulazioni settecentesche, la declinazione in senso rivoluzionario e le prospettive egalitarie sul piano sociale aprono uno scenario inedito, che segnerà profondamente il XIX e il XX secolo. Aveva colto nel segno Mazzini – che contesta alla radice l’idea di felicità come idea ingannevole e assolutamente non rispondente alle potenzialità ontologiche dell’uomo su questa terra e che accomuna in una stessa condanna il diritto alla ricerca della felicità e il diritto alla felicità – quando individuava nel “diritto alla felicità” il tratto caratterizzante delle ideologie socialiste e comuniste. L’idea che la rivoluzione francese lascia in eredità al XIX e al XX secolo – con la sua insistenza sul nesso rivoluzione-eguaglianza sociale–felicità – segna uno spartiacque tra la felicità degli antichi e la felicità dei moderni. Il concetto di felicità – per usare la distinzione tra concetto e concezione suggerita da John Rawls – si arricchisce di una nuova concezione. Una concezione eversiva, che rompe la rassegnazione delle masse popolari di antico regime, adagiate – come acutamente suggerisce Tocqueville – in una sorta di “bonheur végétatif”. La nuova idea di felicità spazza via i supporti teorici alla rassegnazione, quelli tradizionali di ispirazione filosofica e religiosa ma anche quelli messi in campo nel secolo dei lumi (Alexander Pope, Robinet…) con l’intrigante dottrina del “compenso” e della “bilancia”. Forte è anche la discontinuità con il diritto individuale alla ricerca della felicità, prospettato dagli americani. Nelle formulazioni rivoluzionarie francesi dell’anno secondo il diritto alla ricerca della felicità diventa diritto alla felicità. Sarà la politica a rendere possibile e concreto questo diritto – per tutti e in questa terra – rimuovendo la diseguaglianza delle ricchezze e promuovendo i diritti sociali (assistenza, diritto al lavoro, istruzione), ma soprattutto procedendo a una rigenerazione morale dell’uomo. L’“homme régénéré”, l’“homme nouveau” creato dalla rivoluzione, sarà un uomo felice.
Gli estensori della Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino del 1795 rinunceranno a inserire la felicità tra i diritti dell’uomo, in base alla considerazione che era impossibile mettersi d’accordo sul significato preciso della parola. Nella seduta della Convenzione del 16 messidoro anno III (4 luglio 1795) verrà ricordato che “il y a deux mille ans que l’on comptait 288 espèces de bonheur”. Il vero motivo è però la potente carica eversiva della promessa di una felicità accessibile a tutti e suscitata politicamente. L’impegno – espresso insistentemente in molti documenti dell’anno secondo – a continuare la rivoluzione fino a che sulla terra fosse rimasto un solo essere povero e infelice (“malheureux” indica nella maggior parte dei casi sia l’infelice che il povero) configurava l’idea di una rivoluzione permanente, in netto contrasto con gli orientamenti di una parte dei Termidoriani a chiudere la rivoluzione. La posta in gioco era una prospettiva che prometteva “le bonheur du monde entier”, “le bonheur du genre humain” (Robespierre), che ribadiva che “ les malheureux sont les puissances de la terre” (Saint-Just) e che assicurava l’impegno a far sì che non ci fosse più “un malheureux ni un pauvre dans l’ État” (Saint-Just).
FILOSOFIA STORIA DELLE IDEE bonheur felicità gennaio 2017 Giuseppe Mazzini Gracco Babeuf Hannah Arendt John Rawls Louis Antoine Léon de Saint-Just Nicolas de Condorcet rivoluzione francese Robespierre