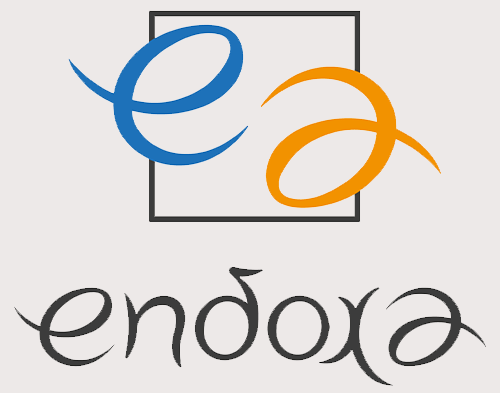UNA LONTANANZA SENZA PENSIERI
 PIER MARRONE
PIER MARRONE
La curiosità uccide la meraviglia? Questa idea mi è venuta in mente la volta che lessi il fulminante incipit di Tristi tropici di Claude Lévi-Strauss “Odio i viaggi e gli esploratori”, una frase che genera un forte effetto di spaesamento per il lettore che si immerge nel resoconto ineguagliato delle spedizioni di Lévi-Strauss in Brasile. Perché mai dovemmo odiare i viaggi, nell’epoca nella quale non ci sono più gli esploratori, mentre rilevazioni satellitari, enormi archivi di immagini sempre alla portata dei nostri dispositivi elettronici, rendono tutto così prossimo? Se è vero che verso il resto del mondo la nostra esperienza è per lo più quella della prossimità, tuttavia è una prossimità che deve essere interrogata.
Lévi-Strauss si era ben reso conto di quanta ambiguità albergasse in questo desiderio per l’insolito che non mira ad altro se non a confermare le proprie esperienze. Così la preoccupazione per l’effetto sorprendente che cerchiamo nei documentari sull’Africa (parliamo di questo territorio come se fosse un unico soggetto indiviso e non un continente con più di cinquanta stati indipendenti e con innumerevoli tradizioni che alla maggior parte di noi rimarranno per sempre non tanto inaccessibili, quanto piuttosto del tutto sconosciute), sul Tibet, sull’Amazzonia è sempre rinnovata. Questo ci attendiamo accada nonostante l’invasione di immagini che dovrebbe generare un’indigestione, e che certamente non è fatta per sollecitare un pensiero critico nello spettatore, nell’ascoltatore, nel lettore, che è più complice che vittima nella sua ricerca dell’effetto a sorpresa.
Cosa ci spinge a rincorrere questa apparente bulimia immaginativa? È la ricerca di un’intensificazione della nostra esperienza quotidiana oppure un desiderio di evasione? Nessuno di noi è un viaggiatore nel senso di Lévi-Strauss, ma un numero enorme di persone, quale mai si era precedentemente visto nella storia è in grado di fare quest’esperienza, incredibile sino a pochi decenni fa, di viaggiare in altri paesi per visitarli con il conforto di poter ritornare in tempi brevissimi a casa propria. Cosa riteniamo di queste esperienze, cosa ascoltiamo durante questi viaggi, cosa ricerchiamo nelle foto che facciamo con i nostri onnipresenti cellulari, accumulando insiemi di immagini che spesso nemmeno abbiamo il tempo e la voglia di rivedere? Io credo sia la possibilità di una testimonianza, la possibilità di dire che si è stati lì. Certo, poi questa testimonianza molto spesso è condivisa nei profili social che abbiamo, ma la documentazione che rimane dentro i nostri archivi è di solito molto superiore alle poche immagini che postiamo. Vogliamo condividere con gli altri quelle che a noi sembrano migliori, ma quello che ci pare migliore è spesso a sua volta modellato su uno standard medio di ciò che ci può apparire sorprendente. Forse nei nostri viaggi nei quali acquistiamo un esotismo che non esiste, quello del quale andiamo in cerca non è essere sorpresi, se intendiamo l’esperienza di un incontro che spiazza le nostre credenze, ma essere allietati.
Quale posto possiamo in realtà dire di non aver potenzialmente visitato? Tutto sembra essere stato documentato dall’immagine. Ma l’immagine crea un’impressione di prossimità del tutto falsa a meno che non sia sorta dallo sguardo di un grande artista, che ci certifica non la prossimità dell’immagine alla nostra esperienza, bensì la sua distanza dal nostro vissuto usuale. Il lontano invece vogliamo che ci appaia vicino, perché deve essere immediatamente incorporabile in noi, altrimenti avremmo fatto un’esperienza che non potremmo condividere realmente con gli altri, che possono comprenderla solo se sono a loro volta in grado di incorporarla senza problemi, e così via in un loop all’infinito. In fondo, questo rientra nella nostra natura di esseri abitudinari e nella natura meccanica del nostro pensiero che preferisce sempre credere che le novità siano interpretabili alla luce dell’esperienza passata, che spesso nemmeno ricordiamo bene.
Insomma, pare avere ragione Lévi-Strauss: la nostra smania di conoscenza dei luoghi distanti da noi è immersa in un conformismo rassicurante, che è quello del collezionista. Non vogliamo realmente fare delle esperienze nuove, che costituiscano delle cesure nelle nostre esistenze, ma desideriamo collezionare, possedere nuove esperienze così come si possiedono dei nuovi oggetti decorativi che entrano a far parte delle pareti delle nostre case, senza mai esserne stati realmente estranei.
È nella natura della globalizzazione, si dirà, che si realizzino queste cose, e in particolare che le esperienze vengano acquistate, assieme al loro corredo di emozioni da testimoniare nei nostri cellulari e sui social. In realtà, questo è in parte vero, poiché non è solo ed esclusivamente la globalizzazione a favorire questa apparente inclusione di ciò che è lontano in ciò che è vicino (apparente perché, come vorrei sforzarmi di suggerire, si tratta molto di più di un’inclusione del familiare nel familiare, del noto nel già noto, del prossimo a ciò che più ci è vicino). In fin dei conti, la nostra globalizzazione non è la prima che si compie, ma almeno altre due nel passato si sono già realizzate. La più vicina a noi fu quella che iniziò dalla seconda metà dell’Ottocento e fu interrotta dalla prima guerra mondiale. Il volume dei commerci a livello mondiale raddoppiò in soli quattro decenni e questa unificazione del globo suscitò tutta l’ammirazione di Marx e Engels, che alla borghesia che l’aveva realizzata innalzarono un peana nel Manifesto del partito comunista. Un’altra globalizzazione, su scala certamente minore, ma egualmente di grande importanza, si realizzò ancora prima quando si unificarono e integrarono i mercati dell’argento di America, Europa e Asia (una globalizzazione spezzata dalla fine del bimetallismo decretata nel 1873 dal presidente americano Grant). Eppure in quelle globalizzazioni non venne a compimento quella che nella nostra contemporaneità ci appare un’unificazione molto più profonda.
Perché ci appaia così profonda dovrebbe però essere una credenza a sua volta da interrogare. Forse anche a chi visse la globalizzazione interrotta tragicamente dal primo conflitto mondiale il mondo appariva unificato in profondità. Qualcosa del genere deve essere capitato nella mia città, Trieste, che in quel periodo era uno dei primi dieci porti del mondo e il cui cosmopolitismo può essere testimoniato sia dalle dimore borghesi trasformate ora in musei, sia dalla presenza di numerose etnie allogene (serbi, armeni, croati, tedeschi), sia dalla presenza di importanti sedi consolari (i neonati Stati Uniti d’America vi aprirono una delle primissime rappresentanze in Europa). Tuttavia, Trieste, come altre città, era un caso speciale e non generalizzabile. Cosa ne sapevano del resto del mondo, la maggior parte delle persone che continuavano a vivere nelle campagne, senza altra prospettiva se non quella di perpetuare una vita che appariva poco diversa da quella vissuta dalle generazioni precedenti e che con scarsi cambiamenti sarebbe stata ripetuta dalle generazioni successive?
Cosa sappiamo, invece, noi? Molto di più è ovvio, ma quello che ci permette di sapere di più è dovuto alla tecnica che ha accompagnato la nostra globalizzazione, quella nella quale siamo immersi e che solo negli anni Settanta del secolo scorso ha eguagliato i volumi dei commerci della prima globalizzazione. La tecnica delle comunicazioni, dei viaggi, degli apparati di registrazione ha democratizzato le esperienze che un secolo fa erano consentite solo a pochissimi privilegiati, che potevano sperimentare il viaggio, l’esplorazione, la conservazione di ricordi radicati in terre che non erano quelle della propria origine. La tecnica che accompagna la nostra globalizzazione è quella che permette questa democratizzazione dell’esperienza. Ecco allora che il turismo diviene un intero sistema industriale che si occupa di colonizzare il tempo libero di un numero eccezionalmente alto di persone che in una decina di ore di viaggio a un costo contenuto raggiungono mete esotiche.
Il loro tempo libero deve essere occupato, ossia deve essere introdotto sino all’ultimo minuto nei meccanismi del sistema industriale del turismo, altrimenti sarebbe condannato a essere un tempo improduttivo, ridotto a scarto e a spreco. Rimanere con sé stessi, senza una proiezione all’esterno è totalmente improduttivo e consumare il proprio tempo ad esempio a casa o anche nella nostra città durante il periodo delle ferie, che pur sempre dovrebbe essere dedicato al riposo, non appare più possibile e quasi non appare più eticamente giustificato. Dobbiamo fare nelle settimane che ci separano dal ritorno al lavoro quelle cose che non abbiamo avuto il tempo di fare, vedere quelle cose che tutti hanno visto (compresi noi), passare rapidamente davanti a quei dipinti che abbiamo visto rappresentati migliaia di volte, ma che dobbiamo assaporare dal vivo, come se anche questa esperienza non fosse un artificio pari a quello di vedere qualcosa in una fotografia (tra l’altro in fotografia spesso li si vede meglio che in un rapido passaggio di pochi secondi incalzati da altri turisti famelici di cibo già gustato al pari di noi). È davvero difficilmente comprensibile perché la gente si accalchi a vedere la Gioconda di Leonardo al Louvre quando è possibile averne un’esperienza estetica migliore in un altro modo. L’unica risposta che mi so dare è che si passa rapidamente di fronte alla Gioconda per poter dire di aver visto la Gioconda.
È per me difficile non pensare che questa ansia di assimilazione di ciò che vogliamo ancora permetterci di pensare come lontano non abbia a che fare con una qualche visione generale del mondo. Io penso che questo aveva in mente Heidegger quando scrisse un breve saggio divenuto celebre, L’epoca dell’immagine del mondo. Forse, anche noi allora dovremmo ricercare in queste esperienze, che ci appaiono innocue e in apparenza slegate tra di loro, un nesso che potrebbe essere molto più solido di quanto a prima vista saremmo disposti a riconoscere. Per Heidegger, l’esperienza dell’uomo moderno è resa possibile da una metafisica che ha dei tratti specifici per quanto generali, che è necessario individuare e isolare. Questa metafisica nelle sue caratteristiche offre il fondamento di un’intera epoca storica perché è dotata di due caratteristiche: 1) un’interpretazione di cosa sia un ente, un oggetto, una cosa; 2) un’interpretazione di che cosa sia la verità. Queste due caratteristiche non sono indipendenti ed estrinseche, ma sono unite in una sintesi da qualcosa che esiste solo nella nostra epoca, ossia dalla diffusione planetaria della tecnica, come manifestazione della volontà di potenza dell’essere umano.
Tante volte si sente distinguere tra ricerca di base e ricerca applicata, tra ricerca scientifica e applicazioni tecniche. È una distinzione cara alle anime belle che si immaginano che possa ancora esistere una ricerca fatta per il piacere della ricerca. Ora, questa in effetti sussiste ancora come piacere individuale, ma non è affatto un sistema, è semplicemente un residuo. Le ragioni per le quali gli stati finanziano le ricerche di base è che non siamo in possesso di un metodo per produrre conoscenze vere, ossia non possiamo sapere a priori quali siano le ricerche più promettenti di applicazioni pratiche e in quali campi. Ci possiamo illudere che esista ancora una distinzione tra ricerca utilitaristica e ricerca fatta per il piacere della conoscenza, ma non è così. Entrambe sono al servizio, una nell’immediato, l’altra in un futuro indeterminato, della tecnica.
Infatti, la tecnica concepisce gli oggetti, le cose, le persone, le esperienze, tutto ciò che Heidegger chiama “ente”, come ciò che può essere reso disponibile al nostro sguardo e alla nostra esperienza. In questo senso, tutto il nostro agire è inteso come culturale, ossia come l’ideazione, la progettazione, la realizzazione degli strumenti non naturali attraverso i quali le nostre società si riproducono nel corso del tempo. È questo quanto Heidegger indica come il primato del procedimento. È un primato su che cosa? Questo non è semplice da capire nel medesimo testo di Heidegger (per altro insolitamente molto chiaro), ma io credo si tratti del primato dell’ideazione soggettiva rispetto alla cose, alle esperienze, alle persone, agli enti concepiti come indipendenti dal soggetto. Tutto dipende allora dall’ideazione del soggetto, che non è una forma di idealismo soggettivo. In altre parole, Heidegger non sostiene che le cose ci sono nella misura in cui sono percepite da noi, come voleva l’idealismo di Berkley, per il quel esse est percipi, ossia “essere signifca essere percepito”. Questa posizione dovrebbe arrivare a sostenere che una galassia che non è stata ancora percepita da alcun essere umano, allora non esiste, che la mia scrivania troppo imgombra di libri e articoli, non esiste mentre non sono in casa, che le mie gatte esistono solo quando me le trovo davanti a farmi le fusa. Sarebbe una posizione assurda. Piuttosto Heidegger suggerisce che il significato delle cose, delle persone, delle esperienze, delle persone, in altre parole di ciò che chiamiamo mondo, universo, realtà, esiste solo se ci siamo noi a dargli un senso.
Nella modernità tutta l’esperienza è riportata alla sua possibilità di essere manipolata per noi, per cui le nostre esperienze alla ricerca dell’autenticità esotica si risolvono sempre in un equivoco e in un continuo fraintendimento, se non altro perché pochi tra di noi sono in grado di penetrare allo stesso modo degli gli abitanti dei paesi che visitiamo il loro patrimonio culturale medio. Questo accade per il semplice fatto che non siamo dei parlanti nativi, ma anche se fossimo in grado di parlare perfettamente tutte le lingue del mondo non potremmo mai sfuggire alla nostra impronta soggettiva. Non esiste esperienza se non nel soggetto. Questa mi pare la lezione di Heidegger. Quella lezione che i nostri viaggi, dedicati alla nostra soddisfazione personale e a null’altro, realizzano nel corpo di ciascuno di noi, ossia in corpore vili.
“Turismo de masas” by raulmahon is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA così lontani così vicini Endoxa gennaio 2022 Pier Marrone