LA CITTÀ PERTURBANTE: CALVINO TRA I VICOLI DI NAPOLI
FABIO CIARAMELLI
“Io credevo che a Napoli facesse caldo anche d’inverno. Invece il giorno che arrivammo noi arrivò anche il freddo, un vento marino che faceva battere i denti e gli stipiti degli usci. Io cercavo qualcosa che «facesse Napoli», non riuscivo a capire che colore avesse questa città, che ritmo: mi fermavo a calze rammendate appese fuori dalle case, a lenzuola in aria, ‘questo fa Napoli’, ripetevo ogni volta, ma il cielo grigio, il freddo mi perdevano, e non potevo togliermi Genova dal capo.
Venne notte e camminavamo ancora contro le cancellate di ferro del porto come in gabbia; ma in fondo mi piace più così, pensavo, Napoli ormai è nord come Torino, il Meridione non esiste, è una storia che raccontano, tutto il mondo è nord, forse l’unico «terrone» al mondo sono io che giro tra le torri a traliccio e i reparti d’imballaggio come un neofita in una cattedrale”.
Comincia così “Freddo a Napoli”, un testo poco noto di Italo Calvino, apparso originariamente nel 1949 su “L’Unità” e poi non più ripubblicato dall’autore (ma inserito poi nel terzo volume Romanzi e racconti apparsi nei Meridiani di Mondatori).
Si tratta d’un reportage sulle condizioni della città nell’immediato dopoguerra. Il giornalista scrittore incomincia la sua visita incamminandosi verso i quartieri spagnoli. Si mette a salire una via a scale dietro due ragazzini che conducono un sottufficiale di marina americano. Poi, però, incrocia uno zoppettino: un bimbetto sugli otto anni, senza una gamba, che batte una stampella sul selciato, chiedendo l’elemosina.
All’abituale ricerca della bellezza, della solarità e magari della spensieratezza che si presumono proprie del Mezzogiorno, fin dall’inizio si sostituisce la brusca scoperta d’una realtà dilacerata. Calvino annota: “Io non scherzavo già più, non dicevo più ‘fa Napoli’”. Contratto il volto in una smorfia di dolore, la città perturbante mostra tutta l’ambiguità dei suoi contrasti. Continuando per quelle rampe, Calvino ne fissa il ritmo in un’istantanea: “Lì c’era Toledo, la via bella, coi giovanotti a passeggio, e sopra, sotto, scantonato un angolo, quest’antichissimo alveare. Questa era Napoli”.
La dissonanza insanabile tra le sue parti, ecco il filo conduttore della sua visita in una città che non corrisponde all’armonia delle sue celebri cartoline. Calvino non aveva mai sentito parlare dei “bassi”. Perciò, tra l’incredulo e l’incuriosito, non si stanca di sbirciare di sottecchi il brulicare della vita serale di là dai vetri illuminati dei pianterreni. “Così salivamo da un vicolo all’altro, dirottavamo per altri vicoli trasversi e non la smettevamo più di far scoperte”.
Ma, poi, che cosa c’era da scoprire? Che cosa resta alla fine della traversata nei vicoli? In che consiste ciò che, sbirciando tra i vetri appannati, si lascia propriamente vedere?
La Napoli che emerge da racconto estraniante di Calvino non è oggetto d’una visione diretta. Lo scrittore ligure, come si sa, diffidava della visione frontale, della pretesa di quest’ultima mirante a fornire e garantire un accesso diretto a ciò che un altro ligure come Eugenio Montale aveva chiamato “l’ultimo segreto” delle cose. Attraversando in diagonale i vicoli e le viuzze della Napoli popolare in un piovoso pomeriggio invernale, il Calvino giornalista e ancor giovane scrittore sperimenta in proprio il girovagare metropolitano che più tardi avrebbe attribuito ad un suo personaggio (Marcovaldo per le strade di Torino). La città dei bassi gli appare alla fine “una città di vetro, in cui non si poteva posare gli occhi in nessun posto senza violare un segreto”. E aggiunge: “Una città ignuda e seria, con muri di mutuo rispetto”. Perciò lo scrittore rinuncia a guardare con l’intento di scoprire l’arcano dietro la superficie o al di là delle apparenze: ma proprio a questo punto, gli riesce di “vedere” esattamente le apparenze, solo le apparenze. Calvino può farlo proprio perché diffidava della bellezza, che con la sua presunta eloquenza fa trascurare ciò che appare insignificante, ciò che stona col resto, ciò che non si lascia ricondurre all’ordine della totalità. Attraverso la ricerca della bellezza, s’ha poi la pretesa di giungere all’essenza, al cuore nascosto delle cose, alla loro armonia interiore. Ma non c’è bisogno di scomodare la metafisica o l’estetica per “vedere” la realtà, i suoi dettagli, le sue ferite. Basta prender congedo dall’essenza, dalla sostanza granitica, dalla totalità onnicomprensiva. Basta riconoscere che dietro le apparenze non c’è niente, che le apparenze sono la verità.
Le immagini calviniane di Napoli sono dissonanti: e perciò sono vere. Non sono inondate dalla bellezza della famosa luce mediterranea, ma colgono nel segno, proprio perché non hanno nulla di armonico, nulla di pacificante. Per questa ragione, quelle immagini in bianco e nero costituiscono la via regia all’intelligenza d’una città diafana, che implica la trasparenza, ma non si riduce alla solarità. Città vitrea e al tempo stesso piovosa, plumbea. Questa è l’apparenza partenopea che il giovane Calvino coglie e trasmette, attenendosi a ciò che vede, al dettaglio della visione di superficie. Così gli appare Napoli, città trasparente ma non necessariamente solare, e perciò inaccessibile senza profanazione. L’occhiata diagonale che va oltre la coltre dell’oscurità e dell’esibizione coatta di alcuni dei suoi abitanti, suscita da parte di costoro ostilità. La sbirciatina lanciata furtivamente dallo scrittore di passaggio, non può che essere sfacciata e abusiva.
Calvino, che non è ossessionato dalla trascendenza della visione speculativa, ma s’accontenta della verità contenuta nell’apparenza, capisce che la visione frontale è fuori luogo. Interdetta dal pudore, ma innanzitutto inadeguata, inutile, irrealizzabile. E questo è l’aspetto decisivo. Non c’è nessuno schermo, non ci sono ostacoli materiali, ma lo sguardo frontale – proprio quello che ambisce a far sua la realtà per penetrarla nei suoi recessi più intimi – in fin dei conti si rivela un esercizio superfluo. La visione diretta, prima d’essere sconveniente, è impossibile. Di fronte all’occhio che vuole andare oltre le apparenze, e con ogni sforzo tende a impossessarsi dell’improbabile segreto del reale, in realtà non c’è niente da vedere, da afferrare, da scotomizzare. Ciò che manca è proprio il disvelamento d’una realtà ultima. Non per una qualche costituzionale impotenza dello sguardo, ma più radicalmente per l’intrinseca inconsistenza del suo oggetto. Dietro l’occhio indagatore, non c’è nessuna realtà ultima che possa lasciar vedere la sua struttura misteriosa. La Napoli fredda e piovosa di Calvino gl’insegna che il vero mistero, l’autentico segreto, è l’evanescenza del dato.
La vita nei bassi genera ritrosia. Sembra che tutto sia pubblico, ma invece la trasparenza totale è un’illusione, un miraggio. Ciò non deriva soltanto dal ritegno di chi con ogni mezzo cerca di sottrarsi all’impudica esibizione cui le condizioni esterne lo costringono: prima del ritegno, prima del pudore, c’è una ragione più profonda, una ragione “ontologica” che impedisce la visione. In realtà, all’interno della città di vetro non c’è “niente”: niente di determinato, niente di definito, niente di risolutivo da scoprire e contemplare. Per il futuro autore de Le città invisibili, “l’ultimo segreto” delle cose, e quindi della stessa città, non può rivelarsi alla visione diretta per la semplice ragione che esso non esiste. Il segreto, l’invisibilità è la cifra del possibile, la sporgenza del futuro.
“Ecco il segreto del Sud: la miseria come modo di esistere, condizione d’ogni cosa concreta. Ma questo non vuol dire rassegnarsi”. Al Calvino allora convinto militante comunista, animato dalla fede nella classe operaia, la povertà del “popolino” appare portatrice d’una missione storica. E infatti, nelle battute conclusive del reportage, è proprio nella “fiera miseria concreta” della classe operaia che egli vede un efficace antidoto al “rassegnato realismo” di chi si perde nelle verità astratte, nelle idee. “Questa forse era Napoli, il Sud; a quell’ora, in una grande casa non distante, il suo vecchio filosofo passeggiava per le stanze oscure, ricarezzava la costola dei tomi. Ma io pensavo già agli operai, che tornavano ogni sera là nei «bassi»“.
Il dramma del Sud era dunque il contrasto, il perdurare della lontananza e dell’estraneità fra l’élite (qui impersonata dal vecchio Croce) e il popolo. Ma il Sud – come poi avrebbe scritto Anna Maria Ortese – “rifletteva una lacera condizione universale”. Il suo dramma è lo stesso del Nord. Anche a Napoli fa freddo, come a Torino, dove allora viveva Calvino. E in entrambi i luoghi sono gli operai – cioè, come non manca di specificare il giornalista militante, “gli uomini della civiltà che avevo scelto come mia” – i quali patiscono bensì la contraddizione, ma hanno anche i mezzi per scioglierla. “Gli operai avevano spalle che facevano leva contro quei soffitti; erano la cerniera per far girare il mondo, i «bassi»“.
Calvino ormai è stanco di girovagare: “Cercavamo una via che uscisse fuori. Invece c’impelagavamo sempre di più in quei vicoli, arrivavamo a punti morti, con i poggioli tutt’intorno pavesati di panni, come piazze di palcoscenico, come stessero per venirci a recitare i De Filippo”. Cercare l’uscita, e restare impelagati nei vicoli: in vicoli, oltre i quali, dietro i quali, dentro i quali non c’è niente di metafisico da scorgere, niente di sostanziale da afferrare, niente di più vero, solido e incontrovertibile delle apparenze.
Non è forse questa, in fin dei conti, la cosa che più di tutte “fa Napoli”? La sua disarmata trasparenza imprigiona e irretisce. L’estrema visibilità culmina nell’invisibile, in un punto cieco da cui non proviene nessuna salvezza ma solo un invito a una responsabilità terribile (ancora più tragica, da quando è venuta meno anche la fiducia in un senso della storia che prima o poi avrebbe dovuto riscattare il Sud come il Nord).
ARCHITETTURA Endoxa FILOSOFIA LETTERATURA endoxa settembre 2019 Fabio Ciaramelli FILOSOFIA Italo Calvino LETTERATURA Napoli perturbante

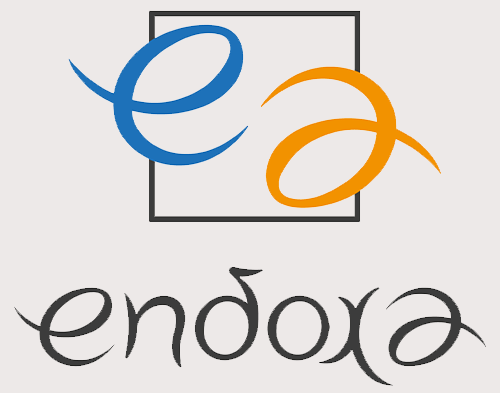

L’ha ripubblicato su indifferentemente.
"Mi piace""Mi piace"